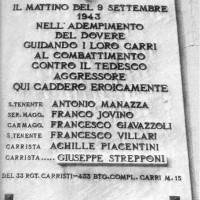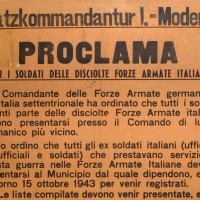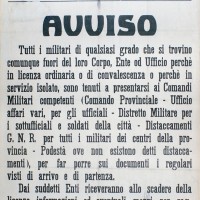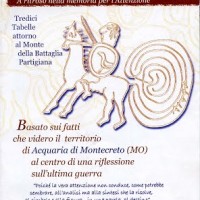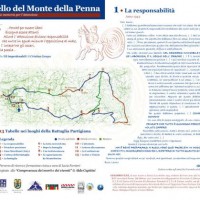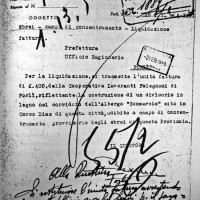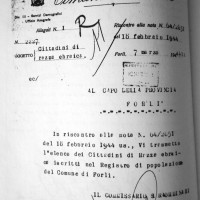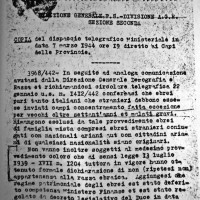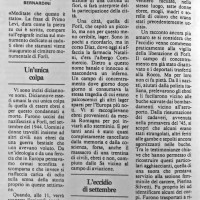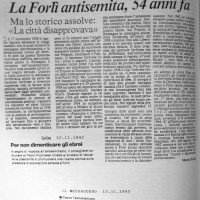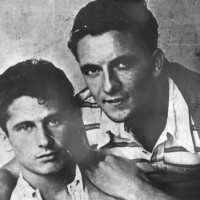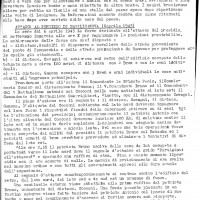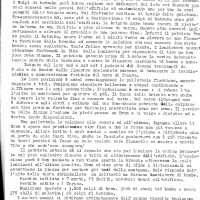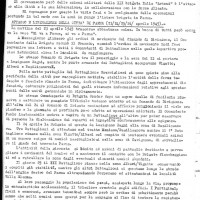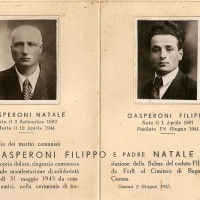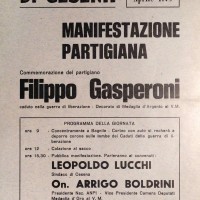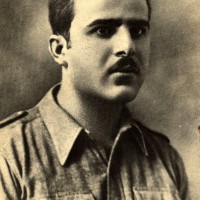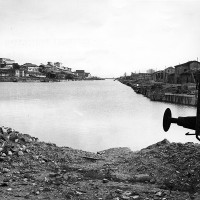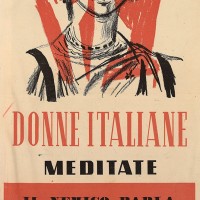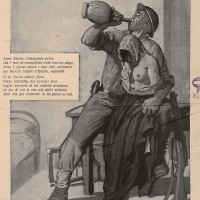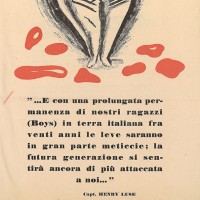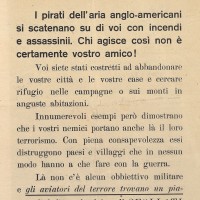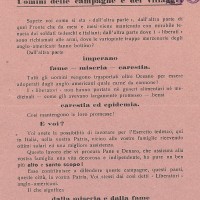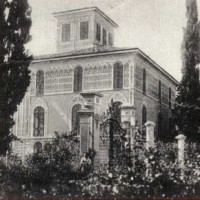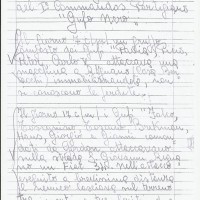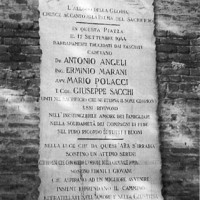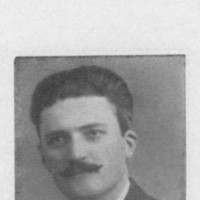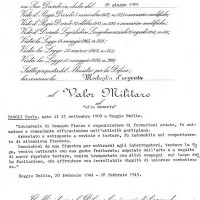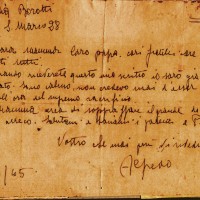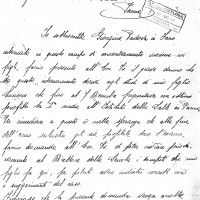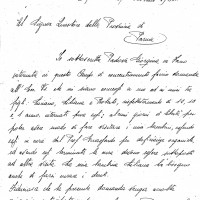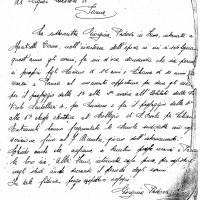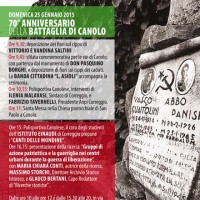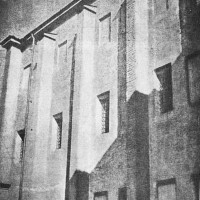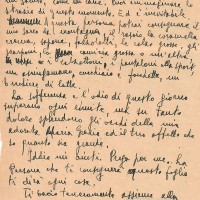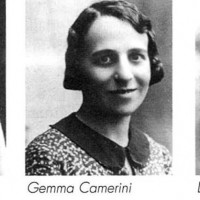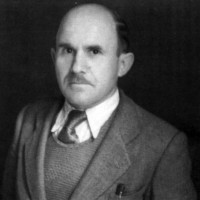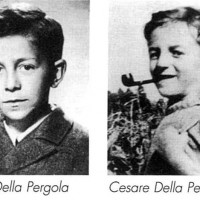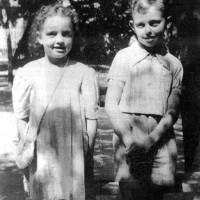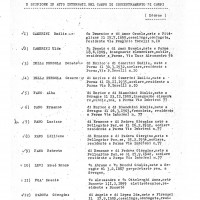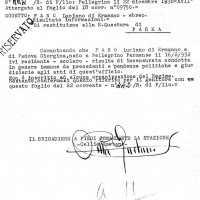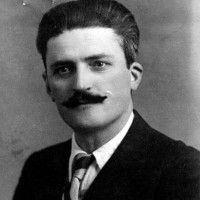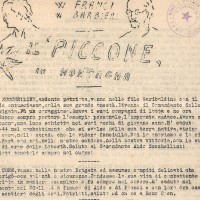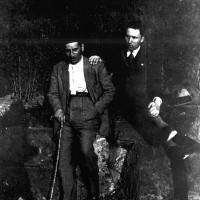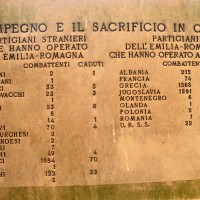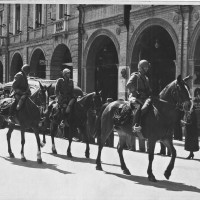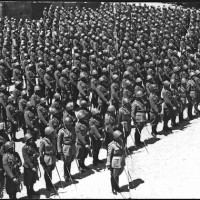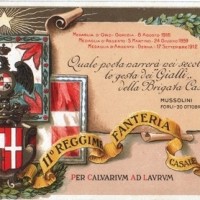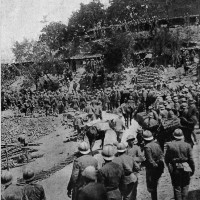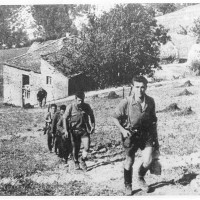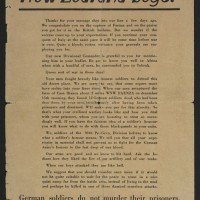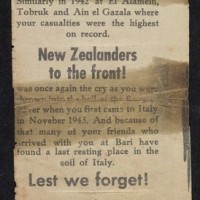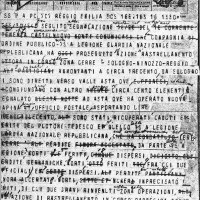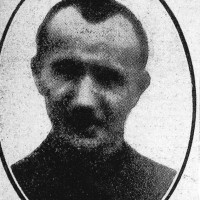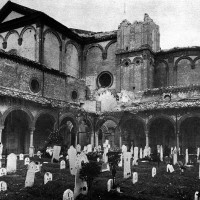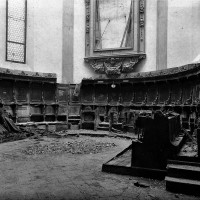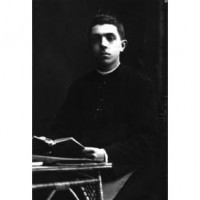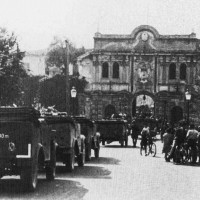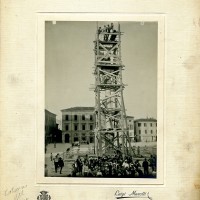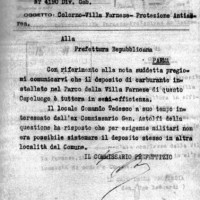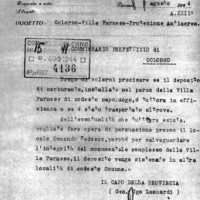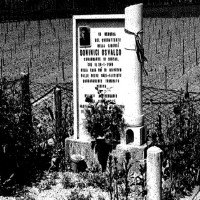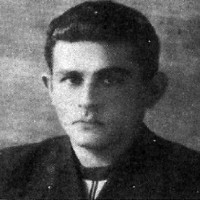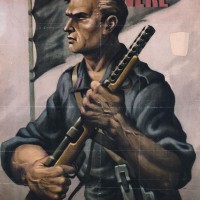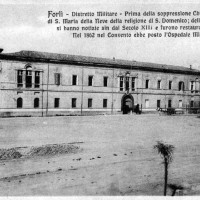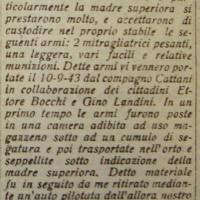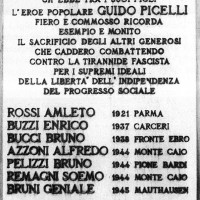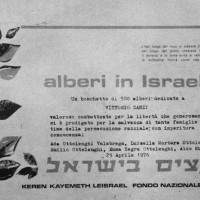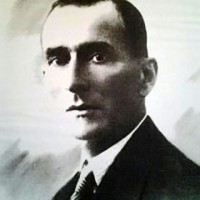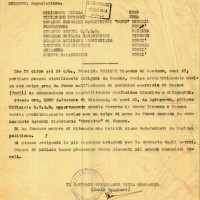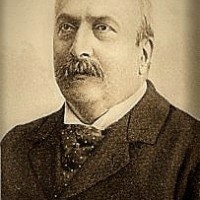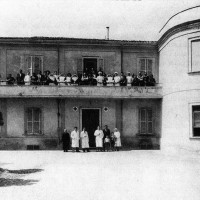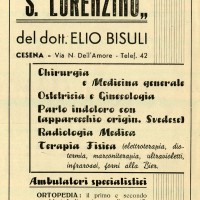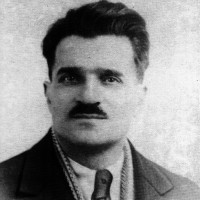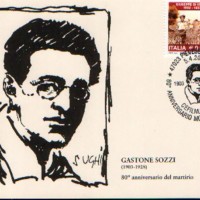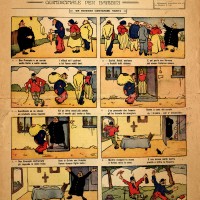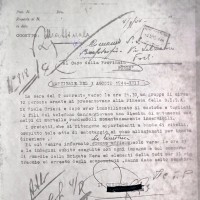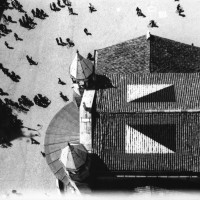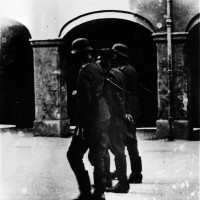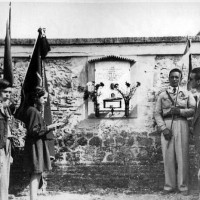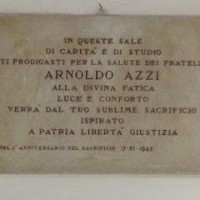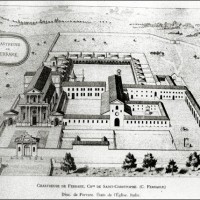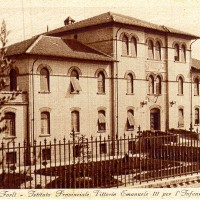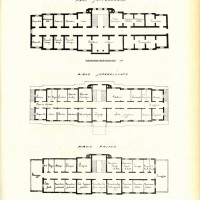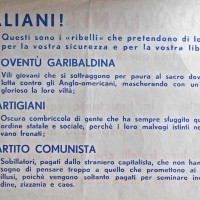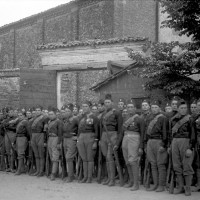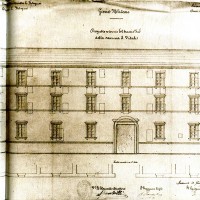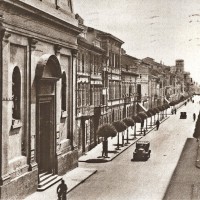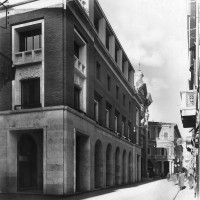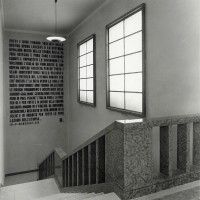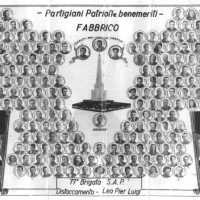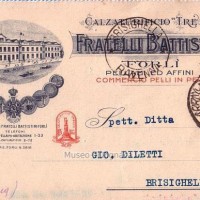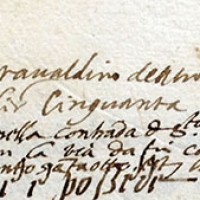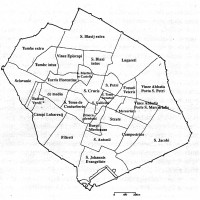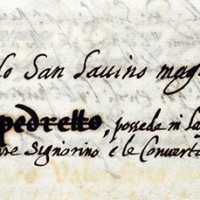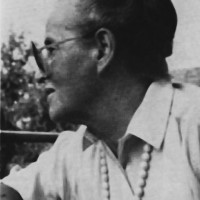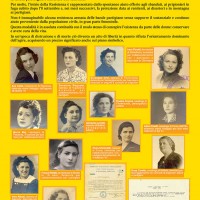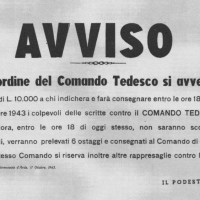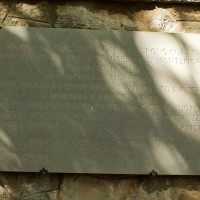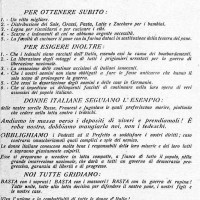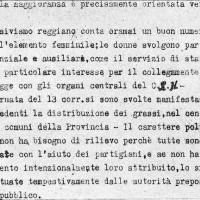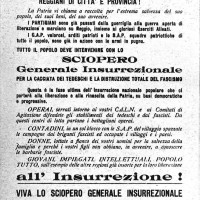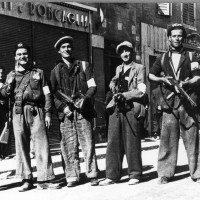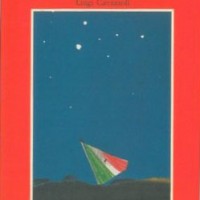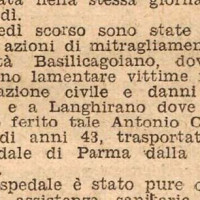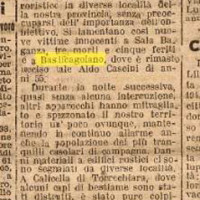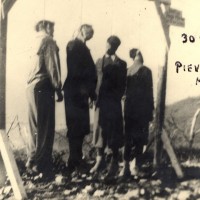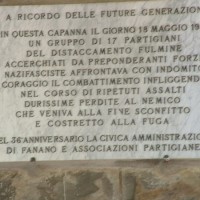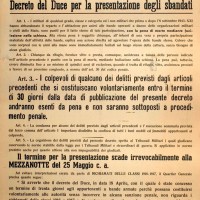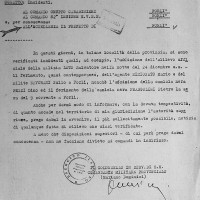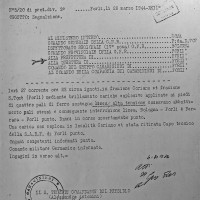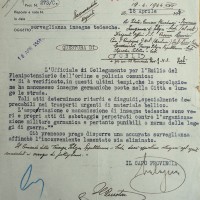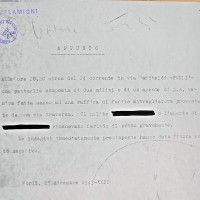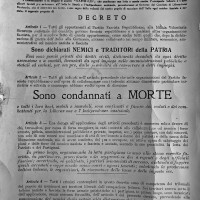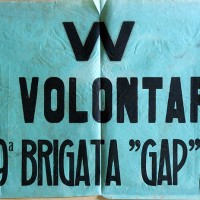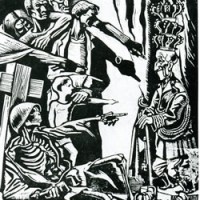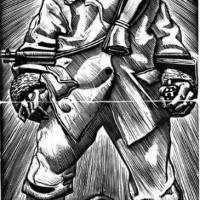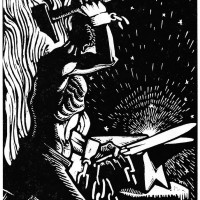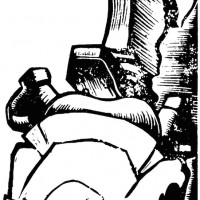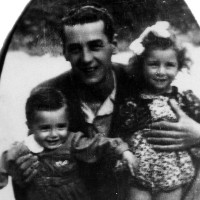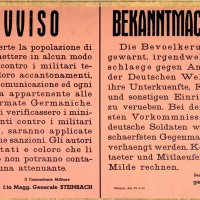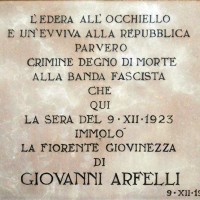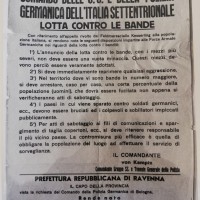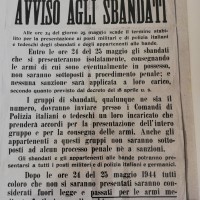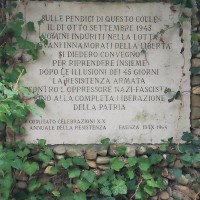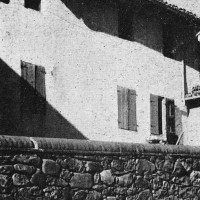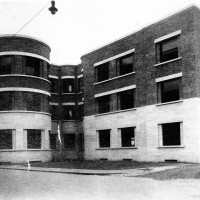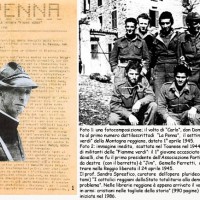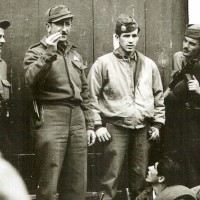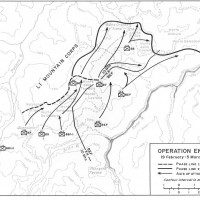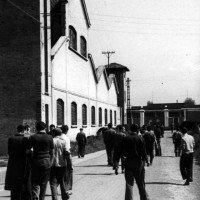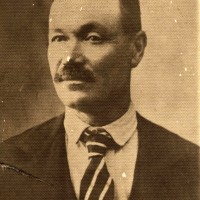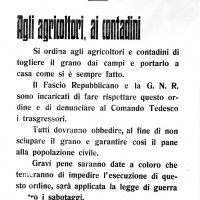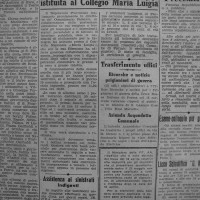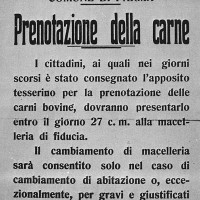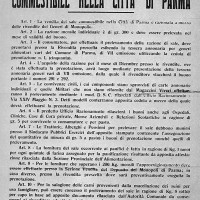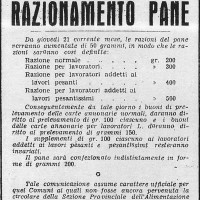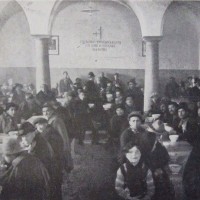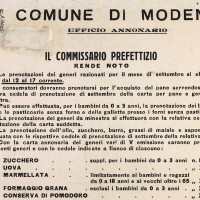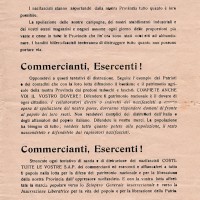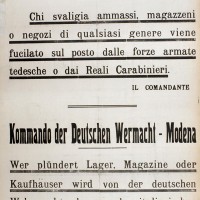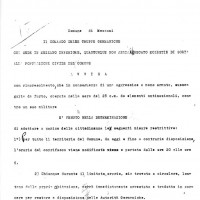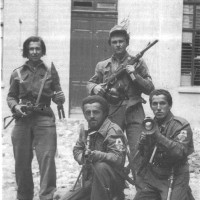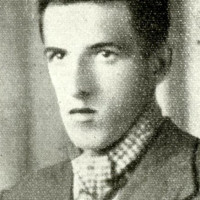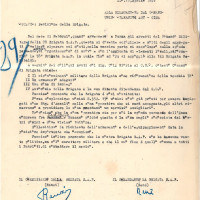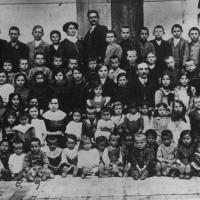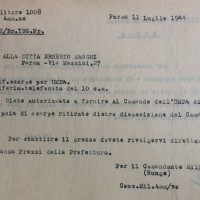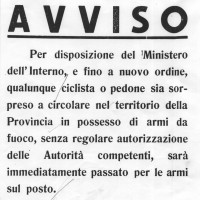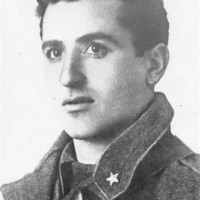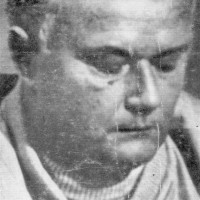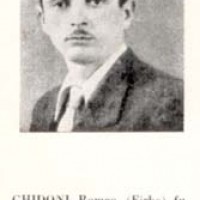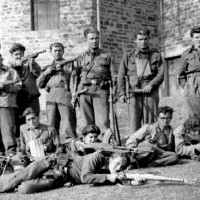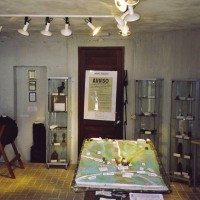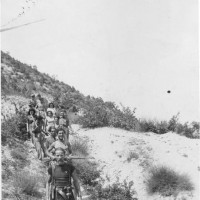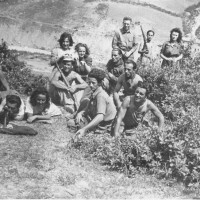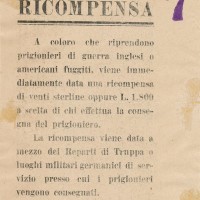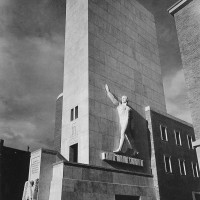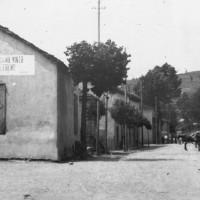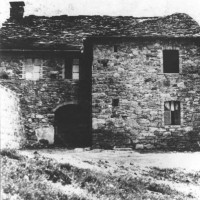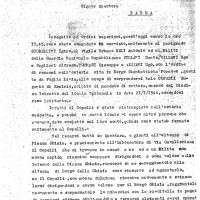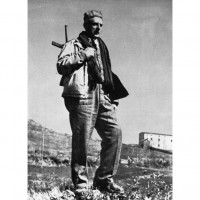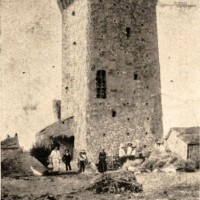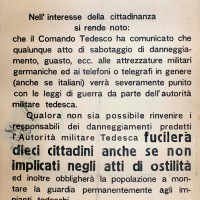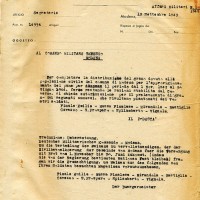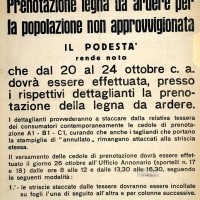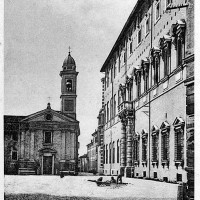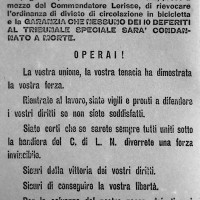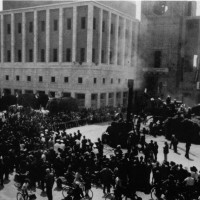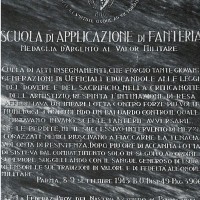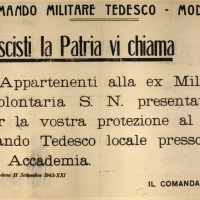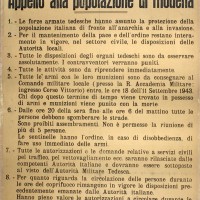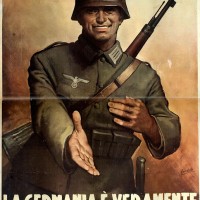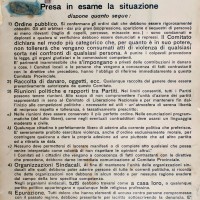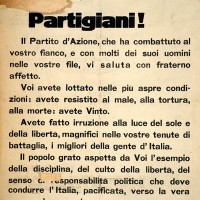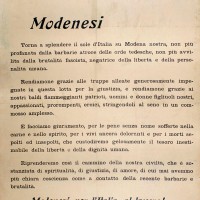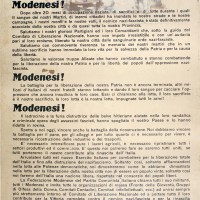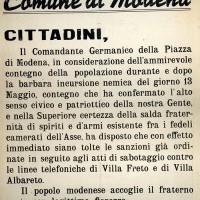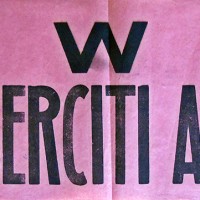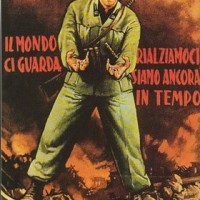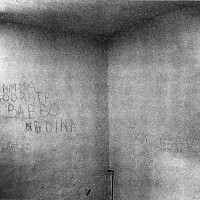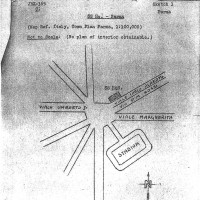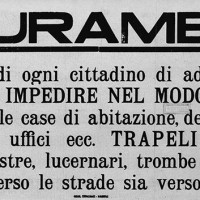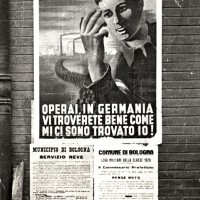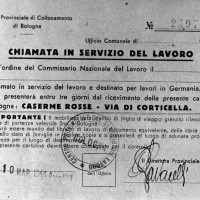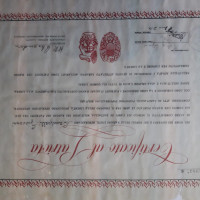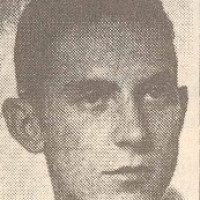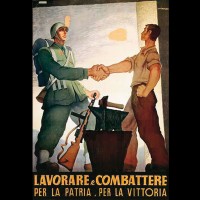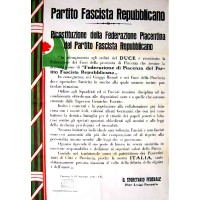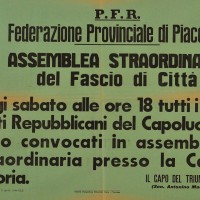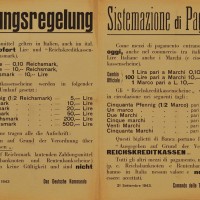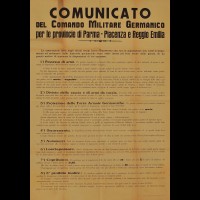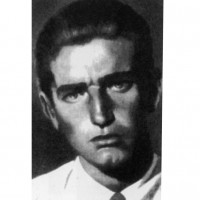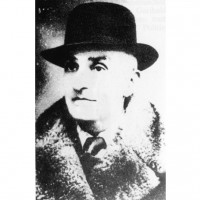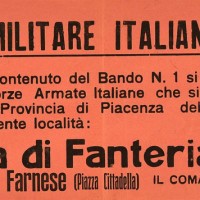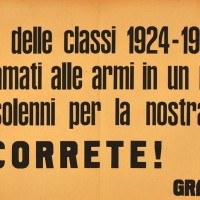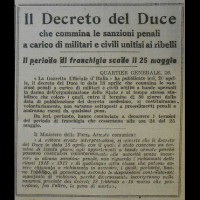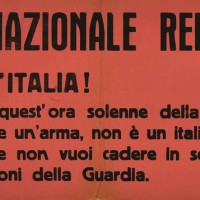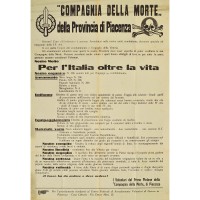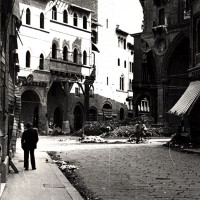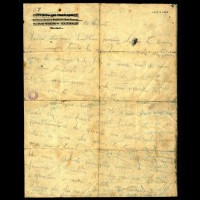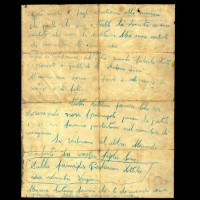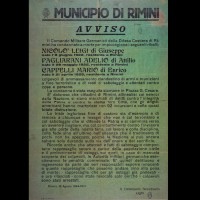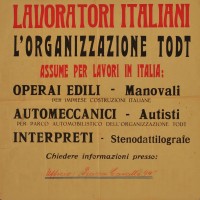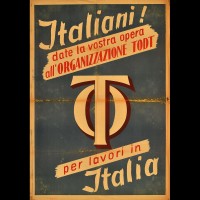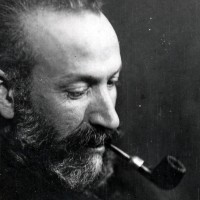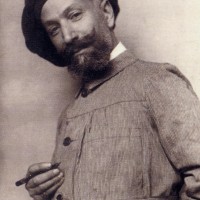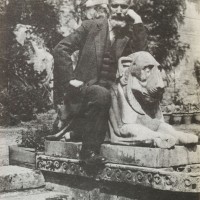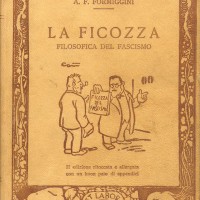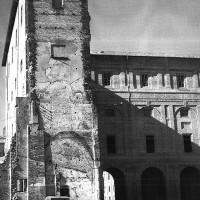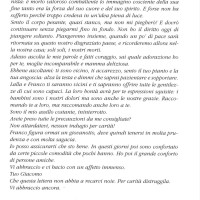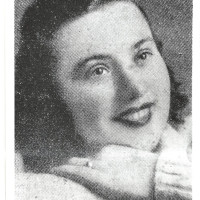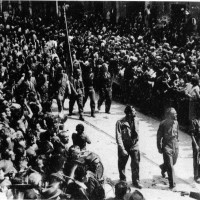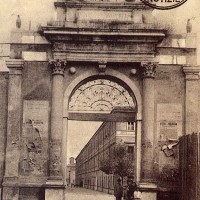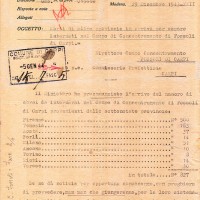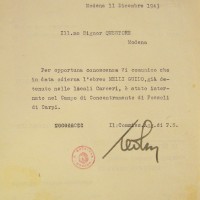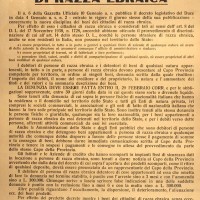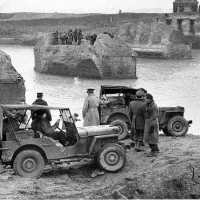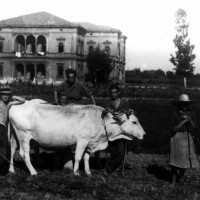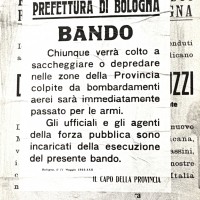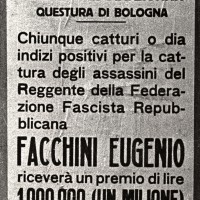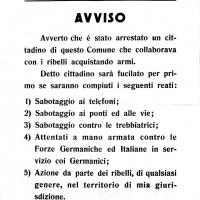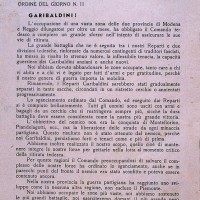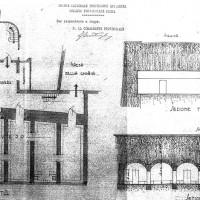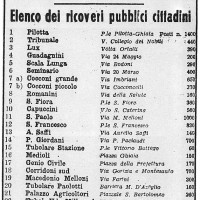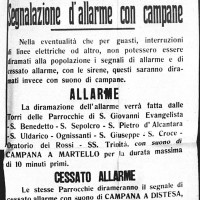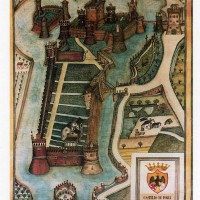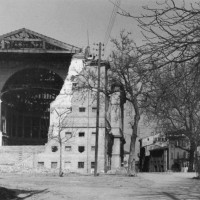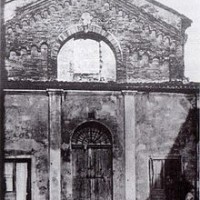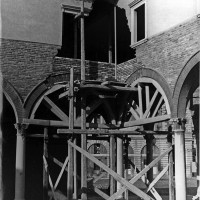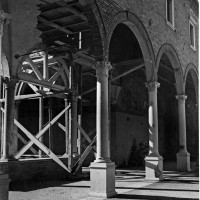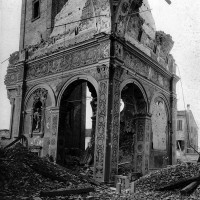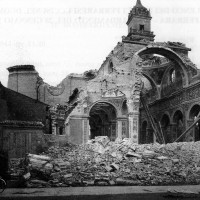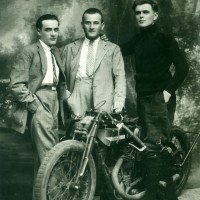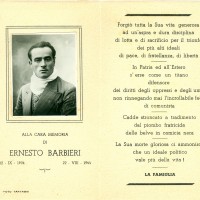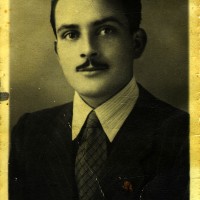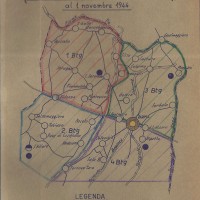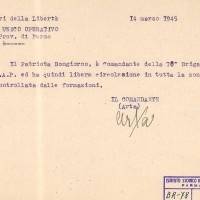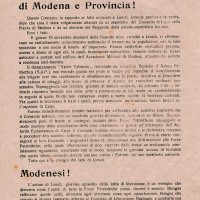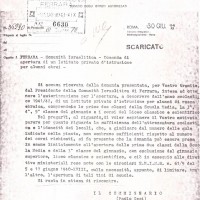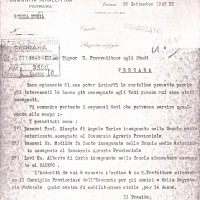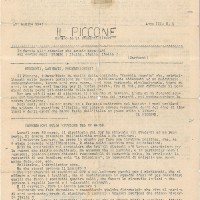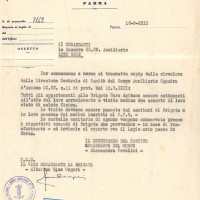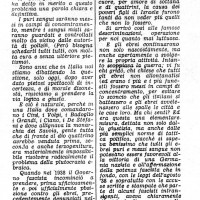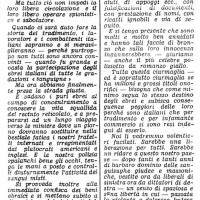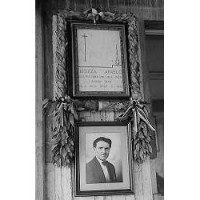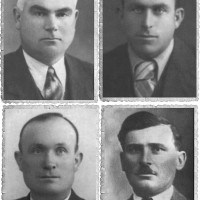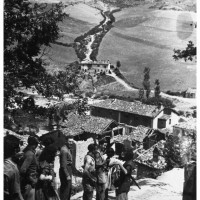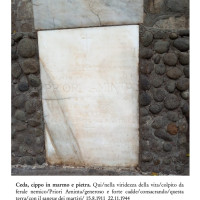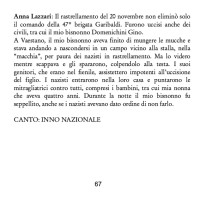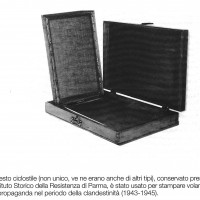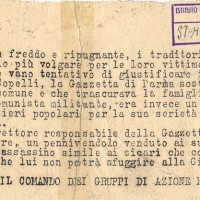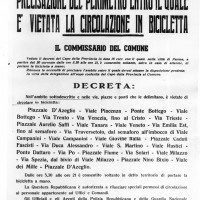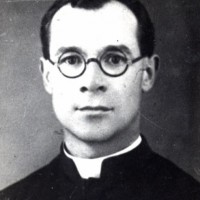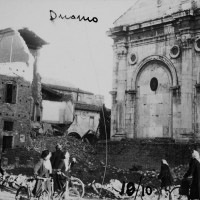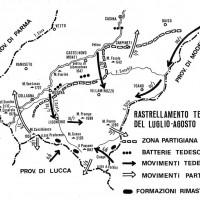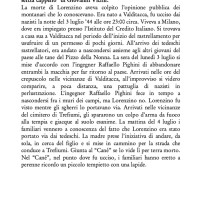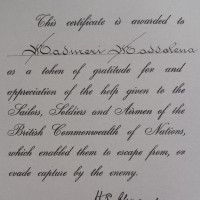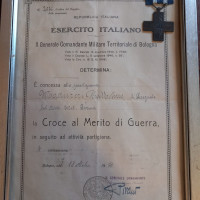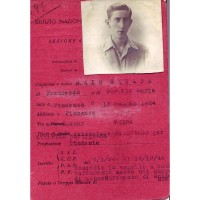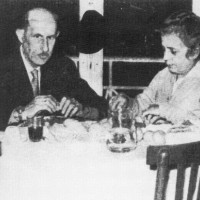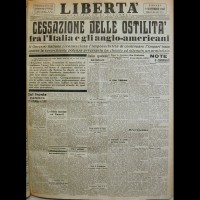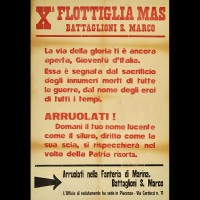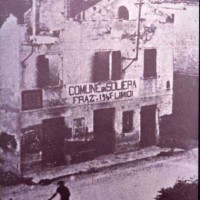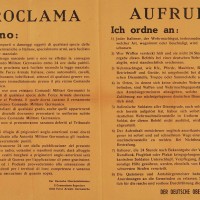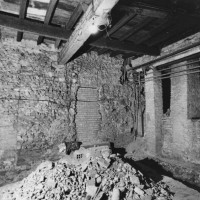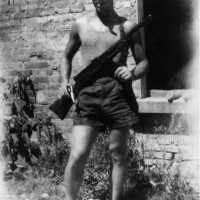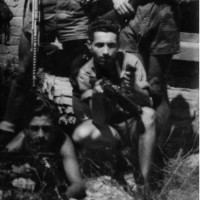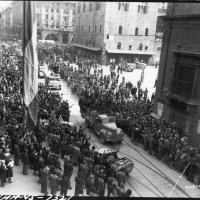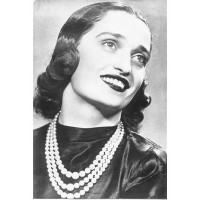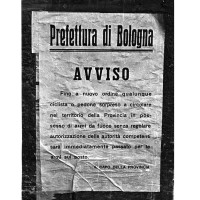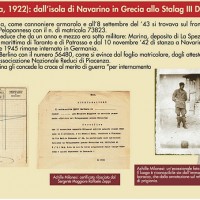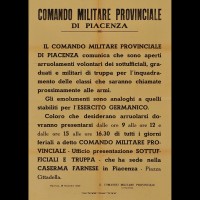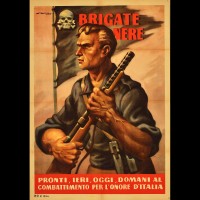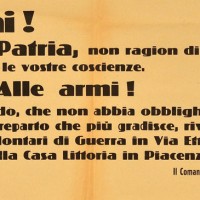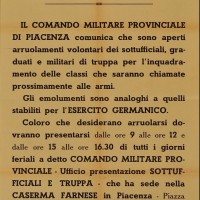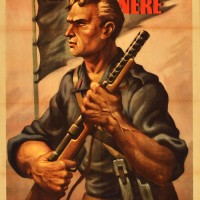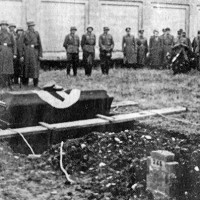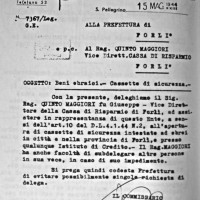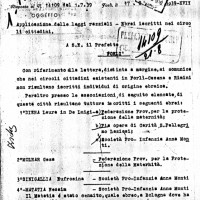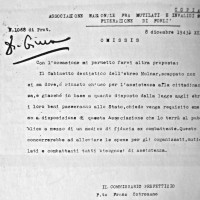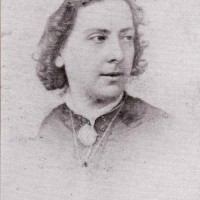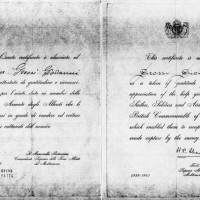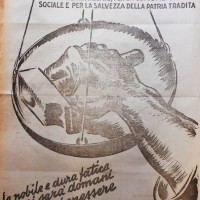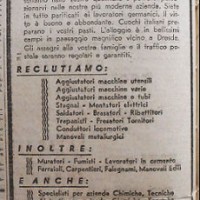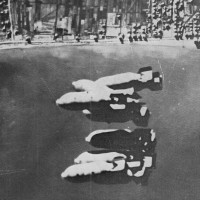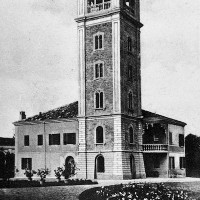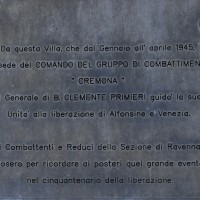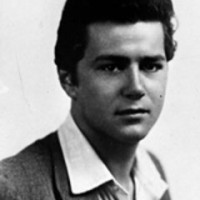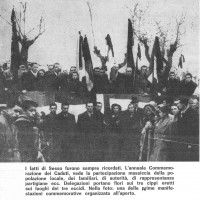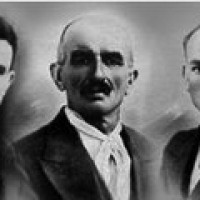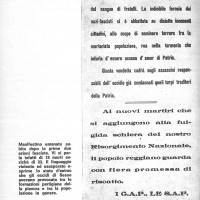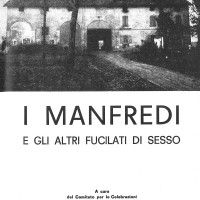Questa pagina raccoglie tutte le gallerie fotografiche del progetto.
(Attenzione: dato l'alto numero delle immagini presenti il caricamento della pagina potrebbe essere lento)
 Abbazia di Santa Maria del Monte, 1910 (BCM Fondo Casalboni, FCP 90)
Abbazia di Santa Maria del Monte, 1910 (BCM Fondo Casalboni, FCP 90) Abbazia di Santa Maria del Monte oggi (foto dell’autore)
Abbazia di Santa Maria del Monte oggi (foto dell’autore)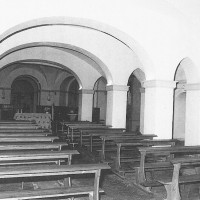 Rifugio antiaereo nella cripta prima dei bombardamenti (P. R. ZUCAL, Clausura violata, Stilgraf Editrice, Cesena, p. 91)
Rifugio antiaereo nella cripta prima dei bombardamenti (P. R. ZUCAL, Clausura violata, Stilgraf Editrice, Cesena, p. 91)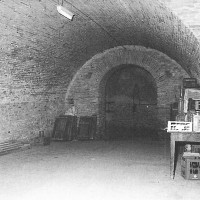 Rifugio antiaereo nella cantina (P. R. ZUCAL, Clausura violata, Stilgraf Editrice, Cesena, p. 101)
Rifugio antiaereo nella cantina (P. R. ZUCAL, Clausura violata, Stilgraf Editrice, Cesena, p. 101) Interno dell’abbazia di Santa Maria del Monte dopo i bombardamenti, 1944 (P. R. ZUCAL, Clausura violata, Stilgraf Editrice, Cesena, p. 103)
Interno dell’abbazia di Santa Maria del Monte dopo i bombardamenti, 1944 (P. R. ZUCAL, Clausura violata, Stilgraf Editrice, Cesena, p. 103) Esterno dell’abbazia di Santa Maria del Monte dopo i bombardamenti, ottobre 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 528)
Esterno dell’abbazia di Santa Maria del Monte dopo i bombardamenti, ottobre 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 528) Particolare dell’esterno dell’abbazia di Santa Maria del Monte dopo i bombardamenti, ottobre 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 531)
Particolare dell’esterno dell’abbazia di Santa Maria del Monte dopo i bombardamenti, ottobre 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 531)
 Agida Cavalli Vandini.
Agida Cavalli Vandini. Articolo su Agida Cavalli Vandini di Renata Viganò (Noi donne).
Articolo su Agida Cavalli Vandini di Renata Viganò (Noi donne).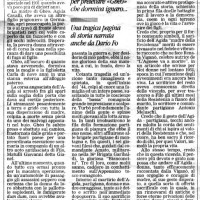 Articolo su Agida Cavalli Vandini (Nuova Ferrara).
Articolo su Agida Cavalli Vandini (Nuova Ferrara). Anita sul Corriere di Ferrara.
Anita sul Corriere di Ferrara. Posa della prima pietra ad Anita.
Posa della prima pietra ad Anita.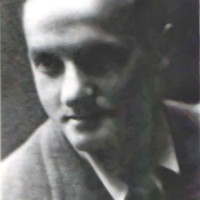 Antonio Meluschi.
Antonio Meluschi. 18 aprile 1945, liberazione di Argenta.
18 aprile 1945, liberazione di Argenta. 18 aprile 1945, liberazione di Argenta.
18 aprile 1945, liberazione di Argenta. Partigiani ad Argenta.
Partigiani ad Argenta. Argenta dopo il 12 aprile 1945.
Argenta dopo il 12 aprile 1945. Interno della cattedrale di San Nicolò ad Argenta bombardata.
Interno della cattedrale di San Nicolò ad Argenta bombardata. Cimitero di Argenta.
Cimitero di Argenta. Casa Vandini Cavalli a Filo.
Casa Vandini Cavalli a Filo.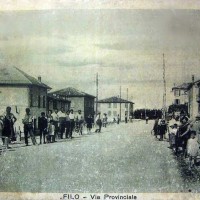 Via Provinciale di Filo, paese di Agida Cavalli Vandini, nell'anteguerra.
Via Provinciale di Filo, paese di Agida Cavalli Vandini, nell'anteguerra. Piazza Garibaldi all'inizio del '900.
Piazza Garibaldi all'inizio del '900. Stele dedicata ad Agida Cavalli Vandini, uccisa da una squadra della Milizia Volontaria della Sicurezza Nazionale nell'atto di difendere il figlio partigiano, Guerriero Vandini.
Stele dedicata ad Agida Cavalli Vandini, uccisa da una squadra della Milizia Volontaria della Sicurezza Nazionale nell'atto di difendere il figlio partigiano, Guerriero Vandini.
 Il Corriere della Sera annuncia l’approvazione delle leggi razziali, riassumendo e ricapitolando le principali misure adottate contro gli ebrei.
Il Corriere della Sera annuncia l’approvazione delle leggi razziali, riassumendo e ricapitolando le principali misure adottate contro gli ebrei.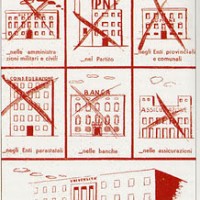 Questa illustrazione, pubblicata su "La difesa della razza", indica gli ambiti nei quali gli ebrei non sono più ammessi al lavoro.
Questa illustrazione, pubblicata su "La difesa della razza", indica gli ambiti nei quali gli ebrei non sono più ammessi al lavoro. Così appaiono i "dintorni di Soliera" in una foto del 1934. Fuori dal centro abitato si aprono strade che portano verso le campagne. I bambini giocano ai margini di un campo, sotto gli occhi di una signora, mentre tre adulti parlano appoggiati al muretto (da Biblioteca Poletti).
Così appaiono i "dintorni di Soliera" in una foto del 1934. Fuori dal centro abitato si aprono strade che portano verso le campagne. I bambini giocano ai margini di un campo, sotto gli occhi di una signora, mentre tre adulti parlano appoggiati al muretto (da Biblioteca Poletti).
 Torello Latini
Torello Latini Torello Latini e la moglie Leda
Torello Latini e la moglie Leda Lapide nella cripta del cimitero monumentale di Cesena che identifica Pietro Maganza come ignoto
Lapide nella cripta del cimitero monumentale di Cesena che identifica Pietro Maganza come ignoto Commemorazione delle vittime con le delegazioni da Sassoferrato e Fabriano, 26 ottobre 2003
Commemorazione delle vittime con le delegazioni da Sassoferrato e Fabriano, 26 ottobre 2003 Commemorazione delle vittime con delegazioni da Sassoferrato e Fabriano, sotto la bandiera blu dell’ANPI Sergio Latini, figlio di Torello, 26 ottobre 2003
Commemorazione delle vittime con delegazioni da Sassoferrato e Fabriano, sotto la bandiera blu dell’ANPI Sergio Latini, figlio di Torello, 26 ottobre 2003 Il cippo oggi
Il cippo oggi Il cippo oggi
Il cippo oggi Casa colonica in via Rovescio, riedificata nelle immediate vicinanze dell’abitazione di Aldo Zamagna
Casa colonica in via Rovescio, riedificata nelle immediate vicinanze dell’abitazione di Aldo Zamagna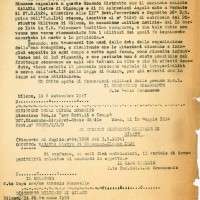 Verbale di irreperibilità di Pietro Maganza
Verbale di irreperibilità di Pietro Maganza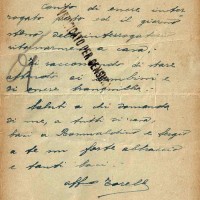 Lettera di Torello Latini inviata alla moglie Leda il 20 giugno 1944 dal carcere di Forl
Lettera di Torello Latini inviata alla moglie Leda il 20 giugno 1944 dal carcere di Forl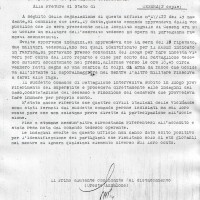 Documento della GNR che informa dell'uccisione del soldato tedesco
Documento della GNR che informa dell'uccisione del soldato tedesco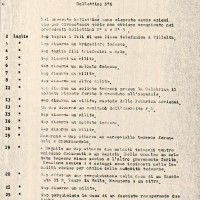 Bollettino n° 6 della 29ª Brigata GAP
Bollettino n° 6 della 29ª Brigata GAP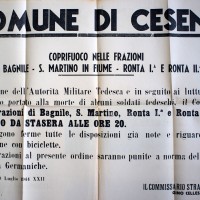 Coprifuoco per le frazioni di Bagnile, Ronta e San Martino in Fiume
Coprifuoco per le frazioni di Bagnile, Ronta e San Martino in Fiume
 Veduta di Bagnile dall’incrocio fra via Pisignano e via Rovescio negli anni ’40. L’edificio sulla sinistra è la Casa del Fascio, mentre la persona seduta è Giulio Berti
Veduta di Bagnile dall’incrocio fra via Pisignano e via Rovescio negli anni ’40. L’edificio sulla sinistra è la Casa del Fascio, mentre la persona seduta è Giulio Berti Disegno della Casa del Fascio ne “Il Popolo di Romagna” del 27 novembre 1934. Si nota l’assenza del balcone
Disegno della Casa del Fascio ne “Il Popolo di Romagna” del 27 novembre 1934. Si nota l’assenza del balcone Persone radunate davanti alla Casa del Fascio dopo la metà degli anni ’30. Da sinistra si riconoscono Romanin (cappello bianco), Pietro Piraccini (Pilacia, in primo piano col cappello scuro), il fabbro di Pisignano, Ernesto Arienti, Giuseppe Calbi (con il fiasco in mano), il segretario del fascio di Bagnile Augusto Gentili (con il gilet grigio) e Ottavio Severi (Tévi, in seconda fila con il cappello scuro)
Persone radunate davanti alla Casa del Fascio dopo la metà degli anni ’30. Da sinistra si riconoscono Romanin (cappello bianco), Pietro Piraccini (Pilacia, in primo piano col cappello scuro), il fabbro di Pisignano, Ernesto Arienti, Giuseppe Calbi (con il fiasco in mano), il segretario del fascio di Bagnile Augusto Gentili (con il gilet grigio) e Ottavio Severi (Tévi, in seconda fila con il cappello scuro) Secondo Fusignani
Secondo Fusignani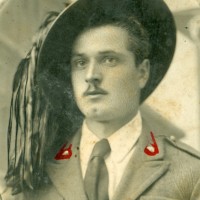 Valentino Morigi
Valentino Morigi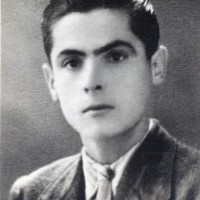 Giorgio Bartolini
Giorgio Bartolini Manifestazione in onore dei caduti di Bagnile durante la Seconda guerra mondiale. Bagnile, 29 aprile 1973
Manifestazione in onore dei caduti di Bagnile durante la Seconda guerra mondiale. Bagnile, 29 aprile 1973 Il Sindaco Leopoldo Lucchi parla alla folla davanti alla ex Casa del Fascio, 29 aprile 1973
Il Sindaco Leopoldo Lucchi parla alla folla davanti alla ex Casa del Fascio, 29 aprile 1973 Arrigo Boldrini (Bulow) sul palco parla al microfono. Con la sigaretta in mano Leopoldo Lucchi accanto ad Anselmo Gasperoni (fratello di Filippo)
Arrigo Boldrini (Bulow) sul palco parla al microfono. Con la sigaretta in mano Leopoldo Lucchi accanto ad Anselmo Gasperoni (fratello di Filippo) L’ex Casa del Fascio oggi
L’ex Casa del Fascio oggi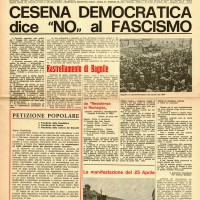 Il “Giornale del Comune” con l’articolo della manifestazione partigiana davanti alla ex Casa del Fascio, 10 giugno 1973
Il “Giornale del Comune” con l’articolo della manifestazione partigiana davanti alla ex Casa del Fascio, 10 giugno 1973
 Cippo a “TORELLO LATINI e PIETRO MAGANZA” a Bagnile di Cesena, Via Rovescio angolo Via Masiera (veduta generale).
Cippo a “TORELLO LATINI e PIETRO MAGANZA” a Bagnile di Cesena, Via Rovescio angolo Via Masiera (veduta generale). Cippo a “TORELLO LATINI e PIETRO MAGANZA” a Bagnile di Cesena, Via Rovescio angolo Via Masiera.
Cippo a “TORELLO LATINI e PIETRO MAGANZA” a Bagnile di Cesena, Via Rovescio angolo Via Masiera. Cippo a “AGAPITO LATINI e VIRGILIO LUCCI” a San Giorgio di Cesena, Via S. Giorgio angolo Via Chiesa di S. Martino (veduta generale).
Cippo a “AGAPITO LATINI e VIRGILIO LUCCI” a San Giorgio di Cesena, Via S. Giorgio angolo Via Chiesa di S. Martino (veduta generale). Cippo a “AGAPITO LATINI e VIRGILIO LUCCI” a San Giorgio di Cesena, Via S. Giorgio angolo Via Chiesa di S. Martino.
Cippo a “AGAPITO LATINI e VIRGILIO LUCCI” a San Giorgio di Cesena, Via S. Giorgio angolo Via Chiesa di S. Martino.
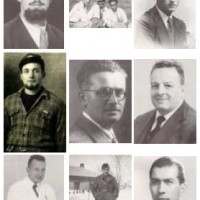 Fotografie di alcuni medici partigiani: Rinaldo Laudi (“Dino”), Piero Cavaciuti, Gaetano Lecce, Carlo Nani, Giovanni Peroni (al centro), Francesco Ricci Oddi, Rino Riggio, Ennio Rizzatti, Ellenio Silva, Giulio Sverzellati, Carlo Tagliani, Enrico Torre, Ettore Valdini.
Fotografie di alcuni medici partigiani: Rinaldo Laudi (“Dino”), Piero Cavaciuti, Gaetano Lecce, Carlo Nani, Giovanni Peroni (al centro), Francesco Ricci Oddi, Rino Riggio, Ennio Rizzatti, Ellenio Silva, Giulio Sverzellati, Carlo Tagliani, Enrico Torre, Ettore Valdini. Preventorio di Bramaiano di Bettola inaugurato nel 1937 e diventato Ospedale Partigiano nel 1944.
Preventorio di Bramaiano di Bettola inaugurato nel 1937 e diventato Ospedale Partigiano nel 1944. Il consorzio agrario di Bettola, sede del Comando unico.
Il consorzio agrario di Bettola, sede del Comando unico. Emilio Canzi, “Enzo Franchi”: anarchico, ardito del popolo, combattente nelle brigate Garibaldi in Spagna, confinato a Ventotene e Comandante unico della XIII Zona partigiana di Piacenza
Emilio Canzi, “Enzo Franchi”: anarchico, ardito del popolo, combattente nelle brigate Garibaldi in Spagna, confinato a Ventotene e Comandante unico della XIII Zona partigiana di Piacenza Rinaldo Laudi “Dino”, motivazione del conferimento della Medaglia d’Oro alla memoria : “Medico ebreo, di elevate qualità umane e civili, nel corso dell’ultimo conflitto mondiale si prodigò, con rischio personale, nella generosa ed infaticabile opera di assistenza e cura dei civili, militari e partigiani in casolari di montagna piacentini. Catturato dai nazifascisti mentre prestava soccorso ad un partigiano ferito fu successivamente prelevato e barbaramente ucciso. Mirabile esempio di umana solidarietà e di altissima dignità.”
Rinaldo Laudi “Dino”, motivazione del conferimento della Medaglia d’Oro alla memoria : “Medico ebreo, di elevate qualità umane e civili, nel corso dell’ultimo conflitto mondiale si prodigò, con rischio personale, nella generosa ed infaticabile opera di assistenza e cura dei civili, militari e partigiani in casolari di montagna piacentini. Catturato dai nazifascisti mentre prestava soccorso ad un partigiano ferito fu successivamente prelevato e barbaramente ucciso. Mirabile esempio di umana solidarietà e di altissima dignità.” Gaetano Lecce, nato a Salerno nel 1906 e laureatosi a Napoli in medicina a 24 anni, nel 1931 vinse il concorso per la condotta medica di Pianello e poi di Pecorara. Dopo l’8 settembre 1943 prestò ripetutamente le sue cure a prigionieri di guerra, inglesi, russi e greci, evasi dai campi di concentramento vicini e ad alcune famiglie di ebrei, ma anche ai primi feriti partigiani. Arrestato dall’UPI nel giugno del 1944, fu trasferito a S. Vittore a Milano e dopo due mesi fu trasferito al lager di Dachau e poi ad Auschwitz, dove giunse il 26 novembre '44. Quando il 18 gennaio 1945 venne l’ordine di evacuazione dal lager, Lecce si salvò nascondendosi con alcuni suoi compagni sotto un mucchio di macerie delle officine Siemens interne al campo.
Gaetano Lecce, nato a Salerno nel 1906 e laureatosi a Napoli in medicina a 24 anni, nel 1931 vinse il concorso per la condotta medica di Pianello e poi di Pecorara. Dopo l’8 settembre 1943 prestò ripetutamente le sue cure a prigionieri di guerra, inglesi, russi e greci, evasi dai campi di concentramento vicini e ad alcune famiglie di ebrei, ma anche ai primi feriti partigiani. Arrestato dall’UPI nel giugno del 1944, fu trasferito a S. Vittore a Milano e dopo due mesi fu trasferito al lager di Dachau e poi ad Auschwitz, dove giunse il 26 novembre '44. Quando il 18 gennaio 1945 venne l’ordine di evacuazione dal lager, Lecce si salvò nascondendosi con alcuni suoi compagni sotto un mucchio di macerie delle officine Siemens interne al campo.
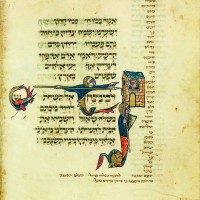 Volume parte della raccolta composta da 1612 di manoscritti ebraici miniati conservati presso la Biblioteca Palatina di Parma
Volume parte della raccolta composta da 1612 di manoscritti ebraici miniati conservati presso la Biblioteca Palatina di Parma Volume parte della raccolta composta da 1612 di manoscritti ebraici miniati conservati presso la Biblioteca Palatina di Parma
Volume parte della raccolta composta da 1612 di manoscritti ebraici miniati conservati presso la Biblioteca Palatina di Parma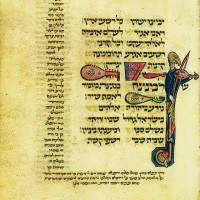 Volume parte della raccolta composta da 1612 di manoscritti ebraici miniati conservati presso la Biblioteca Palatina di Parma
Volume parte della raccolta composta da 1612 di manoscritti ebraici miniati conservati presso la Biblioteca Palatina di Parma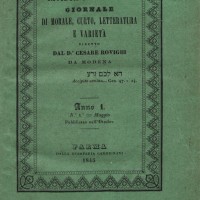 Primo numero della "Rivista israelitica", Parma 1845, conservata presso la Biblioteca Palatina di Parma
Primo numero della "Rivista israelitica", Parma 1845, conservata presso la Biblioteca Palatina di Parma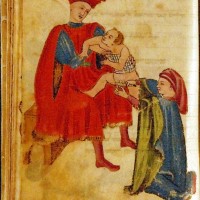 Volume parte della raccolta composta da 1612 di manoscritti ebraici miniati conservati presso la Biblioteca Palatina di Parma
Volume parte della raccolta composta da 1612 di manoscritti ebraici miniati conservati presso la Biblioteca Palatina di Parma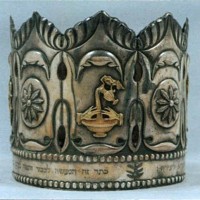
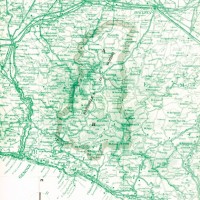 Carta della “Repubblica di Bobbio”.
Carta della “Repubblica di Bobbio”. Il primo numero del “Grido del Popolo” stampato a Bobbio.
Il primo numero del “Grido del Popolo” stampato a Bobbio. Edo Roda editore de “Il Grido del Popolo”.
Edo Roda editore de “Il Grido del Popolo”. Italo Londei.
Italo Londei.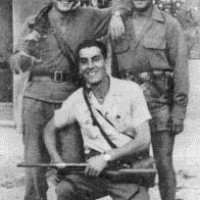 Il comandante Virgilio Guerci (accucciato) con gli amici partigiani G. Levoni (a sinistra) e R. Losi (a destra).
Il comandante Virgilio Guerci (accucciato) con gli amici partigiani G. Levoni (a sinistra) e R. Losi (a destra). Un bella veduta della città di Bobbio in una cartolina d'epoca.
Un bella veduta della città di Bobbio in una cartolina d'epoca.
 Achille Pellizzari, partigiano Poe (seduto al centro), Prefetto del territorio libero del Taro e commissario politico del comando unico, zona ovest, ritratto insieme a (in piedi da sinistra) don Aurelio Giussani (don Carlo), Giuseppe Sidoli (Antonio), Carlo Alberto Devoto (Carlo); (seduti da sinistra) Giovanni Vignali (Bellini, vice comandante Comando regionale), Umberto Pestarini (maggiore Umberto).
Achille Pellizzari, partigiano Poe (seduto al centro), Prefetto del territorio libero del Taro e commissario politico del comando unico, zona ovest, ritratto insieme a (in piedi da sinistra) don Aurelio Giussani (don Carlo), Giuseppe Sidoli (Antonio), Carlo Alberto Devoto (Carlo); (seduti da sinistra) Giovanni Vignali (Bellini, vice comandante Comando regionale), Umberto Pestarini (maggiore Umberto). Partigiano Lucio Caccioli (Gino), 1a Brigata Julia.
Partigiano Lucio Caccioli (Gino), 1a Brigata Julia. Partigiani della 1a Brigata Julia: Rosetta Solari (Rosetta) con Giuseppe Del Nevo (Dragotte), comandante e con il vice comandante Corrado Pellacini (Erok).
Partigiani della 1a Brigata Julia: Rosetta Solari (Rosetta) con Giuseppe Del Nevo (Dragotte), comandante e con il vice comandante Corrado Pellacini (Erok).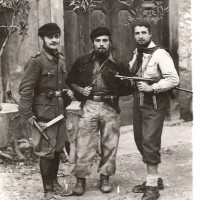 Partigiani della 1a Brigata Julia: Lodovico Stefanini (Carbonaro), Renzo Piscina (Aramis), Lino Perazzi (Lino).
Partigiani della 1a Brigata Julia: Lodovico Stefanini (Carbonaro), Renzo Piscina (Aramis), Lino Perazzi (Lino). Il paese di Cereseto in fiamme durante il rastrellamento del 7-21 luglio 1944 (Operazione Wallenstein II).
Il paese di Cereseto in fiamme durante il rastrellamento del 7-21 luglio 1944 (Operazione Wallenstein II).
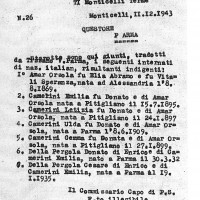 Documento che attesta l’arresto e il trasferimento nel campo di Monticelli di Orsola, Gemma, Letizia, Ulda, Emilia e i suoi due figli. Archivio di Stato di Parma
Documento che attesta l’arresto e il trasferimento nel campo di Monticelli di Orsola, Gemma, Letizia, Ulda, Emilia e i suoi due figli. Archivio di Stato di Parma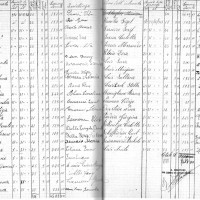 Elenco di prigionieri israeliti detenuti nel campo di concentramento di Monticelli, tra di essi il nucleo di donne e bambini della famiglia Camerini-Della Pergola. Archivio di Stato di Parma
Elenco di prigionieri israeliti detenuti nel campo di concentramento di Monticelli, tra di essi il nucleo di donne e bambini della famiglia Camerini-Della Pergola. Archivio di Stato di Parma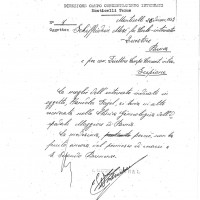 Documento della direzione del campo di concentramento di Monticelli inviato al Questore e al direttore del campo di Scipione, 26 dicembre 1943
Documento della direzione del campo di concentramento di Monticelli inviato al Questore e al direttore del campo di Scipione, 26 dicembre 1943
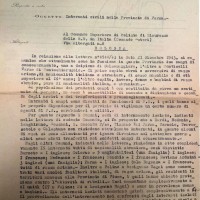 Relazione del Capo della provincia al Comando del servizio di sicurezza tedesco in Italia sui campi di concentramento presenti nel parmense, 7 gennaio 1944. Archivio di Stato di Parma
Relazione del Capo della provincia al Comando del servizio di sicurezza tedesco in Italia sui campi di concentramento presenti nel parmense, 7 gennaio 1944. Archivio di Stato di Parma Relazione del Capo della provincia al Comando del servizio di sicurezza tedesco in Italia sui campi di concentramento presenti nel parmense, 7 gennaio 1944. Archivio di Stato di Parma
Relazione del Capo della provincia al Comando del servizio di sicurezza tedesco in Italia sui campi di concentramento presenti nel parmense, 7 gennaio 1944. Archivio di Stato di Parma
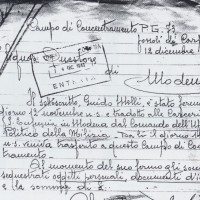 Guido Melli scrive dal Campo di concentramento di Fossoli dopo la detenzione nelle carceri di Sant'Eufemia.
Guido Melli scrive dal Campo di concentramento di Fossoli dopo la detenzione nelle carceri di Sant'Eufemia.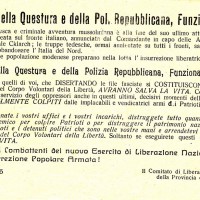 Appello del Comitato di liberazione nazionale agli agenti della questura di Modena.
Appello del Comitato di liberazione nazionale agli agenti della questura di Modena. Il capo di gabinetto della questura di Modena Francesco Vecchione; il suo ruolo fu fondamentale per la salvezza di molti ebrei.
Il capo di gabinetto della questura di Modena Francesco Vecchione; il suo ruolo fu fondamentale per la salvezza di molti ebrei.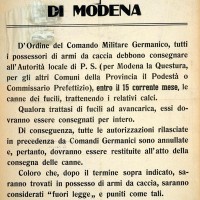 Manifesto della questura repubblicana.
Manifesto della questura repubblicana. Posto di blocco dell'esercito.
Posto di blocco dell'esercito.
 Ufficiali della Compagnia della morte nel cortile della Federazione fascista di Modena.
Ufficiali della Compagnia della morte nel cortile della Federazione fascista di Modena. Funerale di un fascista repubblicano.
Funerale di un fascista repubblicano. Ingresso della federazione fascista di modena con il sacrario ai "martiri fascisti della rivoluzione".
Ingresso della federazione fascista di modena con il sacrario ai "martiri fascisti della rivoluzione".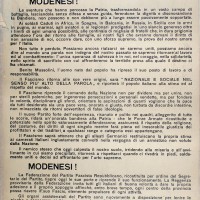 Manifesto che annuncia la costituzione della federazione modenese del partito fascista repubblicano.
Manifesto che annuncia la costituzione della federazione modenese del partito fascista repubblicano. Militi di guardia alla federazione fascista di modena.
Militi di guardia alla federazione fascista di modena.
 La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.
La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.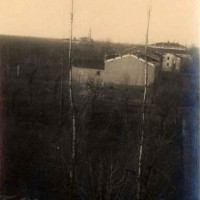 La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.
La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944. La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.
La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944. La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.
La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.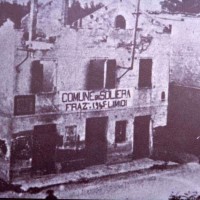 La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.
La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.
 La famiglia Polizzi ripresa negli orti antistanti l’abitazione (da sinistra a destra): Primo detto “Manetto”, Secondo, Lina, Laura e Ida Mussini
La famiglia Polizzi ripresa negli orti antistanti l’abitazione (da sinistra a destra): Primo detto “Manetto”, Secondo, Lina, Laura e Ida Mussini Luigi Porcari tiene un discorso in piazzale Santa Croce durante il suo intervento alla cerimonia di intitolazione di via A. Gramsci, Parma aprile 1947
Luigi Porcari tiene un discorso in piazzale Santa Croce durante il suo intervento alla cerimonia di intitolazione di via A. Gramsci, Parma aprile 1947 Le sorelle Lina e Laura Polizzi dopo il 1945
Le sorelle Lina e Laura Polizzi dopo il 1945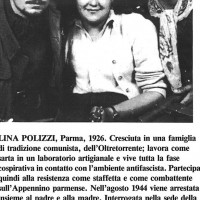 Lina Polizzi con altri due compagni partigiani
Lina Polizzi con altri due compagni partigiani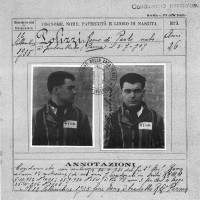 Remo Polizzi. Documento del carcere di Civitavecchia
Remo Polizzi. Documento del carcere di Civitavecchia
 Casa Valla
Casa Valla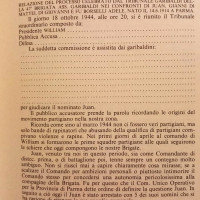 testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso”
testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso”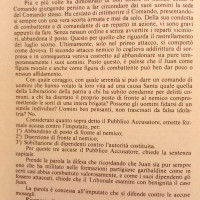 testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso”
testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso”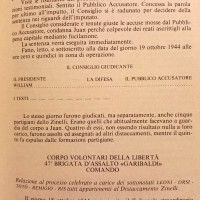 testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso”
testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso”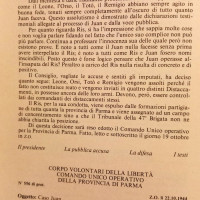 testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso”
testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso”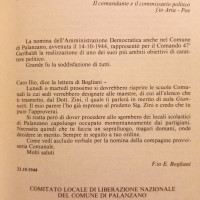 testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso”
testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso”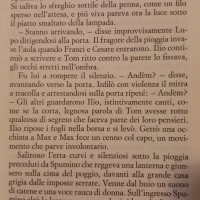 testo Bertoli “La quarantasettesima”
testo Bertoli “La quarantasettesima”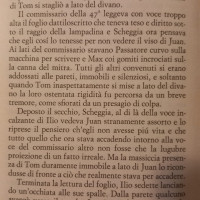 testo Bertoli “La quarantasettesima”
testo Bertoli “La quarantasettesima”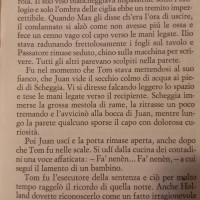 testo Bertoli “La quarantasettesima”
testo Bertoli “La quarantasettesima”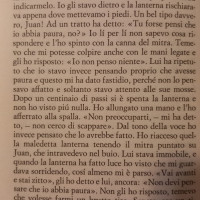 testo Bertoli “La quarantasettesima”
testo Bertoli “La quarantasettesima”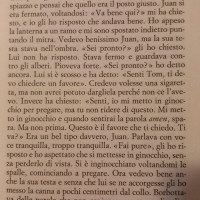 testo Bertoli “La quarantasettesima”
testo Bertoli “La quarantasettesima”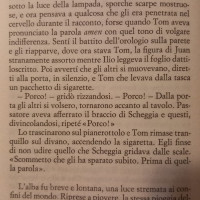 testo Bertoli “La quarantasettesima”
testo Bertoli “La quarantasettesima”
 Municipio di Mezzani
Municipio di Mezzani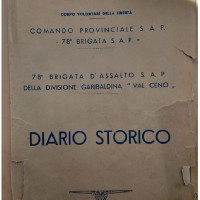 Copertina del Diario storico della 78° Brigata d’Assalto Sap
Copertina del Diario storico della 78° Brigata d’Assalto Sap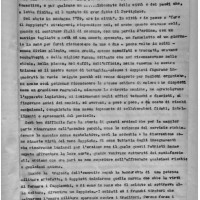 Le attività e le caratteristiche del sappista raccontate nel Diario Storico
Le attività e le caratteristiche del sappista raccontate nel Diario Storico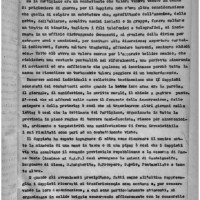 Le attività e le caratteristiche del sappista raccontate nel Diario Storico
Le attività e le caratteristiche del sappista raccontate nel Diario Storico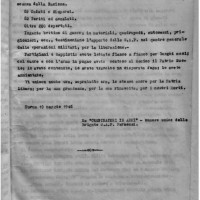 Le attività e le caratteristiche del sappista raccontate nel Diario Storico5
Le attività e le caratteristiche del sappista raccontate nel Diario Storico5 Lapidi in bronzo poste sul Municipio di Mezzani, dove sono riportati tutti i cittadini mezzanesi che hanno avuto la qualifica di “partigiano”, tutti i cittadini che hanno aderito alle Sap e i partigiani inquadrati nel “Distaccamento Po”
Lapidi in bronzo poste sul Municipio di Mezzani, dove sono riportati tutti i cittadini mezzanesi che hanno avuto la qualifica di “partigiano”, tutti i cittadini che hanno aderito alle Sap e i partigiani inquadrati nel “Distaccamento Po”
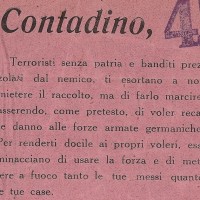 I caseifici sono punti di ritrovo per i lavoratori dei campi, che nella Prima zona partigiana sostengono in gran numero la lotta di Liberazione. La propaganda tedesca e fascista non smette, però, di rivolgersi al “contadino” italiano, esortandolo a opporsi ai “ribelli” per assicurarsi la protezione delle truppe occupanti.
I caseifici sono punti di ritrovo per i lavoratori dei campi, che nella Prima zona partigiana sostengono in gran numero la lotta di Liberazione. La propaganda tedesca e fascista non smette, però, di rivolgersi al “contadino” italiano, esortandolo a opporsi ai “ribelli” per assicurarsi la protezione delle truppe occupanti.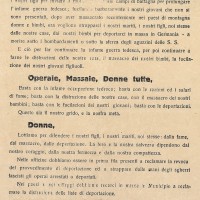 I Gruppi di Difesa della Donna esortano le operaie, le massaie e le "donne tutte" a lottare contro l'occupazione nazista e i fascisti, che spogliano il territorio delle risorse e privano le famiglie dei giovani.
I Gruppi di Difesa della Donna esortano le operaie, le massaie e le "donne tutte" a lottare contro l'occupazione nazista e i fascisti, che spogliano il territorio delle risorse e privano le famiglie dei giovani.
 La via di fuga dalla Cittadella attraverso le fogne.
La via di fuga dalla Cittadella attraverso le fogne.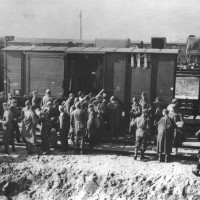 Cattura e trasferimento in Germania di soldati italiani dopo l'8 settembre 1943.
Cattura e trasferimento in Germania di soldati italiani dopo l'8 settembre 1943. Il piazzale principale della caserma della Cittadella. Qui furono trattenuti prigionieri migliaia di soldati italiani.
Il piazzale principale della caserma della Cittadella. Qui furono trattenuti prigionieri migliaia di soldati italiani.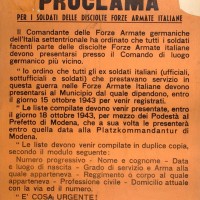 Ordini tedeschi per costringere i soldati e gli ufficiali italiani a ripresentarsi nelle caserme.
Ordini tedeschi per costringere i soldati e gli ufficiali italiani a ripresentarsi nelle caserme.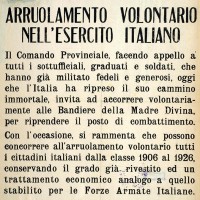 Uno dei primi appelli per la ricostituzione dell'esercito fascista.
Uno dei primi appelli per la ricostituzione dell'esercito fascista.
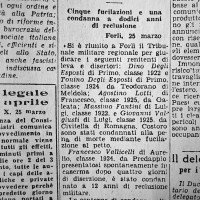 1944 ritaglio articolo condanna renitenti leva
1944 ritaglio articolo condanna renitenti leva Caserma via Ripa
Caserma via Ripa Caserma via Ripa
Caserma via Ripa Caserma via Ripa
Caserma via Ripa Lapide ricordo renitenti fucilati, via Ripa
Lapide ricordo renitenti fucilati, via Ripa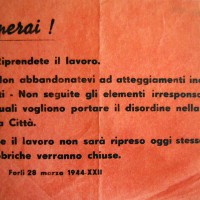 Volantino fascista: Operai riprendete il lavoro
Volantino fascista: Operai riprendete il lavoro Via Ripa, Olivucci, Madonna col bambino
Via Ripa, Olivucci, Madonna col bambino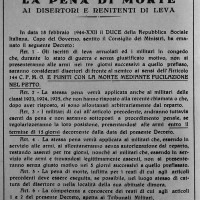 Volantino contro i renitenti la leva
Volantino contro i renitenti la leva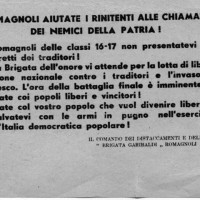 Volantino partigiano contro la leva della Rsi
Volantino partigiano contro la leva della Rsi
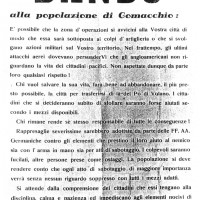 Bando tedesco alla Popolazione di Comacchio (Archivio storico Comacchio)
Bando tedesco alla Popolazione di Comacchio (Archivio storico Comacchio)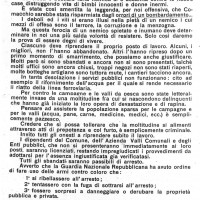 Manifesto pubblico dopo i bombardamenti del 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 luglio 1944. ASC Comacchio
Manifesto pubblico dopo i bombardamenti del 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 luglio 1944. ASC Comacchio Uno degli avamposti occupati e presidiati dalla 28ª Brigata partigiana Garibaldi (20 gennaio 1945). ASDS Ferrara
Uno degli avamposti occupati e presidiati dalla 28ª Brigata partigiana Garibaldi (20 gennaio 1945). ASDS Ferrara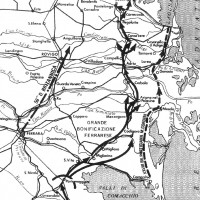 L’avanzata della 28ª Brigata Garibaldi
L’avanzata della 28ª Brigata Garibaldi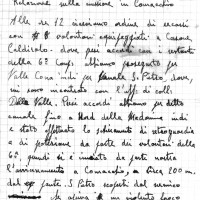 Relazione dell’attività svolta dalla 28ª Brigata Garibaldi, Relazione sulla misisione in Comacchio (manoscritto), 20/4/1945 ISRRA; Diario storico (del Distaccamento “Comacchio”)
Relazione dell’attività svolta dalla 28ª Brigata Garibaldi, Relazione sulla misisione in Comacchio (manoscritto), 20/4/1945 ISRRA; Diario storico (del Distaccamento “Comacchio”)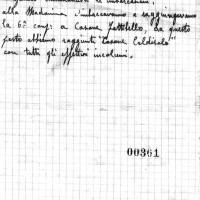 Relazione dell’attività svolta dalla 28ª Brigata Garibaldi, Relazione sulla misisione in Comacchio (manoscritto), 20/4/1945 ISRRA; Diario storico (del Distaccamento “Comacchio”)
Relazione dell’attività svolta dalla 28ª Brigata Garibaldi, Relazione sulla misisione in Comacchio (manoscritto), 20/4/1945 ISRRA; Diario storico (del Distaccamento “Comacchio”)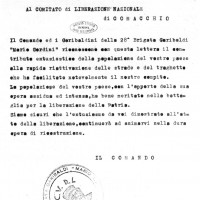 Diario Storico della 28ª Brigata Garibaldi Distaccamento di Comacchio, Boldrini, "Comacchio partigiana"
Diario Storico della 28ª Brigata Garibaldi Distaccamento di Comacchio, Boldrini, "Comacchio partigiana"
 Un Mitragliere e due fucilieri della Compagnia K, 87° Fanteria di Montagna statunitense coprono una squadra di assalto che cerca di snidare i tedeschi asserragliati nella Casa Campolungo, vicino Passo Brasa (Castel d'Aiano).
Un Mitragliere e due fucilieri della Compagnia K, 87° Fanteria di Montagna statunitense coprono una squadra di assalto che cerca di snidare i tedeschi asserragliati nella Casa Campolungo, vicino Passo Brasa (Castel d'Aiano). Genieri della 10° Divisione di Montagna riposano mell'ultima fila di un distruttore di carri che offre loro un po' di protezione dal fuoco dei franchi tiratori sulla strada durante l'assalto della 10° Divisione da Montagna della 5° Armata.
Genieri della 10° Divisione di Montagna riposano mell'ultima fila di un distruttore di carri che offre loro un po' di protezione dal fuoco dei franchi tiratori sulla strada durante l'assalto della 10° Divisione da Montagna della 5° Armata.
 Fioritura davanti al Castello Campori. Nella prima metà del Novecento gli alberi – e le campagne – giungono fino a ridosso del palazzo monumentale.
Fioritura davanti al Castello Campori. Nella prima metà del Novecento gli alberi – e le campagne – giungono fino a ridosso del palazzo monumentale. Questa cartolina di inizio Novecento mostra l’abitato di Soliera completamente racchiuso entro il tracciato delle mura difensive.
Questa cartolina di inizio Novecento mostra l’abitato di Soliera completamente racchiuso entro il tracciato delle mura difensive. Negli anni della Seconda guerra mondiale, per accedere al centro storico di Soliera, bisogna oltrepassare la vecchia porta, che è parte delle strutture del Castello Campori. L’ingresso è poi stato mantenuto pressoché identico fino all’epoca presente.
Negli anni della Seconda guerra mondiale, per accedere al centro storico di Soliera, bisogna oltrepassare la vecchia porta, che è parte delle strutture del Castello Campori. L’ingresso è poi stato mantenuto pressoché identico fino all’epoca presente. Un’auto d’epoca si avvicina alle persone che sostano davanti alla porta della città. Si tratta di un “evento”: nella Soliera degli anni Trenta e della Seconda guerra mondiale il traffico dei veicoli civili a motore rimane infatti piuttosto limitato.
Un’auto d’epoca si avvicina alle persone che sostano davanti alla porta della città. Si tratta di un “evento”: nella Soliera degli anni Trenta e della Seconda guerra mondiale il traffico dei veicoli civili a motore rimane infatti piuttosto limitato. Via Roma parte dal Castello Campori (sullo sfondo) e si apre verso le campagne del forese. All’inizio del Novecento il Comune fa costruire lungo quest’importante strada le nuove scuole elementari (sulla sinistra in primo piano). Durante la Seconda guerra mondiale i sotterranei dell’edificio vengono utilizzati come rifugio antiaereo (da Biblioteca Poletti).
Via Roma parte dal Castello Campori (sullo sfondo) e si apre verso le campagne del forese. All’inizio del Novecento il Comune fa costruire lungo quest’importante strada le nuove scuole elementari (sulla sinistra in primo piano). Durante la Seconda guerra mondiale i sotterranei dell’edificio vengono utilizzati come rifugio antiaereo (da Biblioteca Poletti).
 Cattedrale di San Giovanni Battista, dopo il 1892 (BCM Fondo Casalboni, FCP 104)
Cattedrale di San Giovanni Battista, dopo il 1892 (BCM Fondo Casalboni, FCP 104) Cattedrale di San Giovanni Battista oggi (foto dell’autore)
Cattedrale di San Giovanni Battista oggi (foto dell’autore) Campanile della cattedrale di San Giovanni Battista oggi (foto dell’autore)
Campanile della cattedrale di San Giovanni Battista oggi (foto dell’autore) Madonna del Popolo (www.corrierecesenate.com - 18/09/2017)
Madonna del Popolo (www.corrierecesenate.com - 18/09/2017)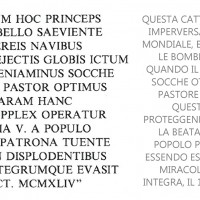 Targa commemorativa (rielaborazione dell'autore, da C. SIROTTI, Cesena diciotto secoli di storia. Dall’arrivo del Cristianesimo alla Cattedrale odierna, Stilgraf Editrice, Cesena, 1982, p. 181)
Targa commemorativa (rielaborazione dell'autore, da C. SIROTTI, Cesena diciotto secoli di storia. Dall’arrivo del Cristianesimo alla Cattedrale odierna, Stilgraf Editrice, Cesena, 1982, p. 181)
 Borgo e chiesa di San Rocco, 1905 (BCM Fondo Dellamore, FDP 787)
Borgo e chiesa di San Rocco, 1905 (BCM Fondo Dellamore, FDP 787) Campanile della Chiesa di San Rocco oggi (foto dell'autore)
Campanile della Chiesa di San Rocco oggi (foto dell'autore) Esterno della chiesa di San Rocco dopo i bombardamenti, primavera 1945 (BCM Fondo Bacchi, FBP 566)
Esterno della chiesa di San Rocco dopo i bombardamenti, primavera 1945 (BCM Fondo Bacchi, FBP 566) Interno della chiesa di San Rocco dopo i bombardamenti, primavera 1945 (BCM Fondo Bacchi, FBP 567)
Interno della chiesa di San Rocco dopo i bombardamenti, primavera 1945 (BCM Fondo Bacchi, FBP 567)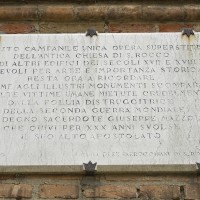 Targa commemorativa della chiesa di San Rocco oggi (foto dell’autore)
Targa commemorativa della chiesa di San Rocco oggi (foto dell’autore) Lavori per la sistemazione del Ponte Vecchio, ottobre 1944 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1228)
Lavori per la sistemazione del Ponte Vecchio, ottobre 1944 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1228)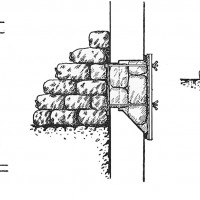 Esempio di tamponatura delle aperture nei locali adibiti a rifugio antiaereo (C. RIZZOLI, La protezione antiaerea nella tecnica edilizia, Edizioni Tecniche-Utilitarie, Bologna, 1937, p. 135)
Esempio di tamponatura delle aperture nei locali adibiti a rifugio antiaereo (C. RIZZOLI, La protezione antiaerea nella tecnica edilizia, Edizioni Tecniche-Utilitarie, Bologna, 1937, p. 135)
 Cupola e campanile della chiesa di Santa Cristina (www.facebook.com/Cesena di una volta - 18/09/2017)
Cupola e campanile della chiesa di Santa Cristina (www.facebook.com/Cesena di una volta - 18/09/2017) Chiesa di Santa Cristina oggi (foto dell’autore)
Chiesa di Santa Cristina oggi (foto dell’autore) Cupola e campanile della chiesa di Santa Cristina oggi (foto dell’autore)
Cupola e campanile della chiesa di Santa Cristina oggi (foto dell’autore) Cupola della chiesa di Santa Cristina oggi (M. MENGOZZI (a cura di), La chiesa di Santa Cristina, Stilgraf Editrice, Cesena, 2012, p. 117)
Cupola della chiesa di Santa Cristina oggi (M. MENGOZZI (a cura di), La chiesa di Santa Cristina, Stilgraf Editrice, Cesena, 2012, p. 117)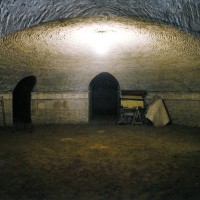 Cripta della chiesa di Santa Cristina, prima del restauro del 2010 (M. MENGOZZI (a cura di), La chiesa di Santa Cristina, Stilgraf Editrice, Cesena, 2012, p. 107)
Cripta della chiesa di Santa Cristina, prima del restauro del 2010 (M. MENGOZZI (a cura di), La chiesa di Santa Cristina, Stilgraf Editrice, Cesena, 2012, p. 107) Ingresso della cripta della chiesa di Santa Cristina, dopo il restauro del 2010 (foto dell’autore)
Ingresso della cripta della chiesa di Santa Cristina, dopo il restauro del 2010 (foto dell’autore) Cripta della chiesa di Santa Cristina, dopo il restauro del 2010 (foto dell’autore)
Cripta della chiesa di Santa Cristina, dopo il restauro del 2010 (foto dell’autore)
 Chiesa dell'Osservanza, tra 1882-1912 (G. BONI, D. SAVOIA (a cura di), Augusto Casalboni “più che fotografo, artista ed appassionato studioso”, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2002, p. 59)
Chiesa dell'Osservanza, tra 1882-1912 (G. BONI, D. SAVOIA (a cura di), Augusto Casalboni “più che fotografo, artista ed appassionato studioso”, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2002, p. 59) Chiesa dell’Osservanza oggi (foto dell’autore)
Chiesa dell’Osservanza oggi (foto dell’autore) Ingresso della chiesa dell'Osservanza oggi (foto dell'autore)
Ingresso della chiesa dell'Osservanza oggi (foto dell'autore) Catacombe della chiesa dell'Osservanza oggi 1di3 (foto dell'autore)
Catacombe della chiesa dell'Osservanza oggi 1di3 (foto dell'autore) Catacombe della chiesa dell'Osservanza oggi 2di3 (foto dell'autore)
Catacombe della chiesa dell'Osservanza oggi 2di3 (foto dell'autore) Catacombe della chiesa dell'Osservanza oggi 3di3 (foto dell'autore)
Catacombe della chiesa dell'Osservanza oggi 3di3 (foto dell'autore) Lapide affissa dedicata a padre C. Bosoni nelle catacombe oggi (foto dell'autore
Lapide affissa dedicata a padre C. Bosoni nelle catacombe oggi (foto dell'autore
 La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.
La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944. La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.
La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944. La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.
La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944. La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.
La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944. La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.
La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.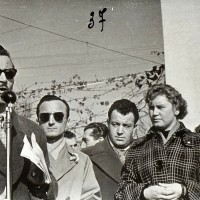 Discorso alla commemorazione dei caduti partigiani tenutasi nel 1954 a Limidi.
Discorso alla commemorazione dei caduti partigiani tenutasi nel 1954 a Limidi.
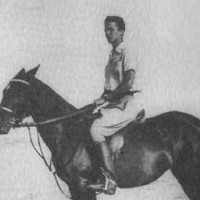 Ludovico Ticchioni (Tredicino).
Ludovico Ticchioni (Tredicino). Gino Villa (Volpino).
Gino Villa (Volpino). Palazzo Comunale di Codigoro: a sinistra l'ingresso delle carceri dette le Fasanare.
Palazzo Comunale di Codigoro: a sinistra l'ingresso delle carceri dette le Fasanare. Palazzo della ex-Pretura a Codigoro.
Palazzo della ex-Pretura a Codigoro. Piazza Municipale di Codigoro.
Piazza Municipale di Codigoro. Olga Fabbri.
Olga Fabbri. Palazzo della Pretura a Codigoro.
Palazzo della Pretura a Codigoro. Carlo De Sanctis (al centro, con baffi e occhiali) e la sua “banda” durante il processo.
Carlo De Sanctis (al centro, con baffi e occhiali) e la sua “banda” durante il processo. La piazza nell'Ottocento.
La piazza nell'Ottocento. La piazza nel 1937.
La piazza nel 1937. Piazza Municipale e Caffè Centrale (anni '50).
Piazza Municipale e Caffè Centrale (anni '50). Piazza Municipale di Codigoro.
Piazza Municipale di Codigoro.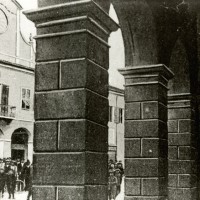 Piazza Municipale di Codigoro.
Piazza Municipale di Codigoro. Piazza Municipale (anni '20).
Piazza Municipale (anni '20). Piazza Municipale di Codigoro.
Piazza Municipale di Codigoro.
 Viale Mazzoni, il Parco della Rimembranza e la Rocca Malatestiana, 1924 (BCM Fondo Dellamore, FDP 2829)
Viale Mazzoni, il Parco della Rimembranza e la Rocca Malatestiana, 1924 (BCM Fondo Dellamore, FDP 2829) Paraschegge dell'ingresso adiacente al Monumento ai Caduti oggi (foto dell'autore)
Paraschegge dell'ingresso adiacente al Monumento ai Caduti oggi (foto dell'autore) Parasoffio interno dell'ingresso adiacente al Monumento ai Caduti oggi (foto dell'autore)
Parasoffio interno dell'ingresso adiacente al Monumento ai Caduti oggi (foto dell'autore) Galleria principale oggi (foto dell'autore)
Galleria principale oggi (foto dell'autore) Ingresso del locale del capo-ricovero e dei Vigili del Fuoco oggi (foto dell'autore)
Ingresso del locale del capo-ricovero e dei Vigili del Fuoco oggi (foto dell'autore) Ingresso del locale d'infermeria e fontana dell'acqua oggi (foto dell'autore)
Ingresso del locale d'infermeria e fontana dell'acqua oggi (foto dell'autore) Ingresso delle latrine oggi (foto dell’autore)
Ingresso delle latrine oggi (foto dell’autore) Camino di aerazione oggi (foto dell'autore)
Camino di aerazione oggi (foto dell'autore) Camino di aerazione nel Parco della Rimembranza oggi (foto dell'autore)
Camino di aerazione nel Parco della Rimembranza oggi (foto dell'autore)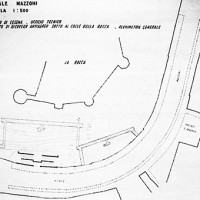 Ipotesi di ampliamento, 1944 (GIORDANO, CONTI - Tra guerra e dopoguerra, distruzione e ricostruzione di una città, in A. D’ALTRI (a cura di), Cesena e Forlì dalla guerra alla ricostruzione, Il Ponte Vecchio, Cesena, 1995, p.161)
Ipotesi di ampliamento, 1944 (GIORDANO, CONTI - Tra guerra e dopoguerra, distruzione e ricostruzione di una città, in A. D’ALTRI (a cura di), Cesena e Forlì dalla guerra alla ricostruzione, Il Ponte Vecchio, Cesena, 1995, p.161) Abitazioni su viale Mazzoni interrotte a causa del sopraggiungere del fronte a Cesena, primavera 1945 (BCM Fondo Bacchi, FBP 569)
Abitazioni su viale Mazzoni interrotte a causa del sopraggiungere del fronte a Cesena, primavera 1945 (BCM Fondo Bacchi, FBP 569)
 Il capitano scozzese “Mack” (Arcibald Mackenzie ) e l'irlandese “Ganna” (Freschen Gregg) fuggiti dal campo di prigionia di Veano e rimasti a combattere nella Divisione val Nure
Il capitano scozzese “Mack” (Arcibald Mackenzie ) e l'irlandese “Ganna” (Freschen Gregg) fuggiti dal campo di prigionia di Veano e rimasti a combattere nella Divisione val Nure Disertori della Wehrmacht entrati nella brigata del “Valoroso” (Lino Vescovi)
Disertori della Wehrmacht entrati nella brigata del “Valoroso” (Lino Vescovi) Milih Dusan (il “Montenegrino”) e Arcibald Mackenzie con alcune ragazze
Milih Dusan (il “Montenegrino”) e Arcibald Mackenzie con alcune ragazze
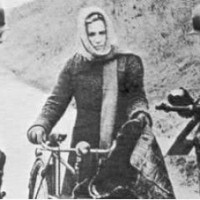 Una scena dal film: L'Agnese va a morire.
Una scena dal film: L'Agnese va a morire. Antonio Meluschi.
Antonio Meluschi. Valle Campo.
Valle Campo. Valle con lavoriero.
Valle con lavoriero. Tramonto nella valle Zavelea.
Tramonto nella valle Zavelea. Stazione Foce.
Stazione Foce. Articolo su Renata Viganò, (Repubblica, 17/01/2013).
Articolo su Renata Viganò, (Repubblica, 17/01/2013). Renata Viganò.
Renata Viganò. Porto Garibaldi, Via 5 maggio: muro antisbarco.
Porto Garibaldi, Via 5 maggio: muro antisbarco. Parco del Delta del Po.
Parco del Delta del Po. Parco del Delta del Po.
Parco del Delta del Po. Casone di valle (foto G. Ardizzoni).
Casone di valle (foto G. Ardizzoni). Comacchio, casone dell'Agnese.
Comacchio, casone dell'Agnese. Comacchio, casone dell'Agnese.
Comacchio, casone dell'Agnese. Porto Garibaldi bombardata.
Porto Garibaldi bombardata. Comacchio, Via Cavour bombardata.
Comacchio, Via Cavour bombardata. Locandina del film.
Locandina del film. Carri anfibi nelle valli.
Carri anfibi nelle valli. Truppe in movimento in località Prato Pozzo.
Truppe in movimento in località Prato Pozzo. Truppe inglesi lungo l'argine Agosta.
Truppe inglesi lungo l'argine Agosta. Valli di Comacchio.
Valli di Comacchio.
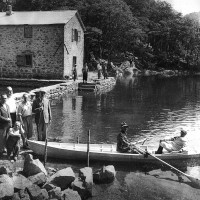 Rifugio “Mariotti”, Lago Santo (1.500m), secondo in piedi da sinistra, l’on.le Giuseppe Micheli.
Rifugio “Mariotti”, Lago Santo (1.500m), secondo in piedi da sinistra, l’on.le Giuseppe Micheli.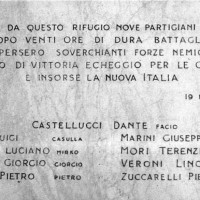 Lapide posta sul rifugio “Mariotti”, Lago Santo.
Lapide posta sul rifugio “Mariotti”, Lago Santo. Gino Menconi, partigiano “Renzi”, comandante della piazza di Parma.
Gino Menconi, partigiano “Renzi”, comandante della piazza di Parma. Gino Menconi, partigiano “Renzi”, comandante della piazza di Parma.
Gino Menconi, partigiano “Renzi”, comandante della piazza di Parma. Albergo Ghirardini, sede del comando unico ( autunno 1944). Ferruccio Parri commemora il comandante “Pablo”.
Albergo Ghirardini, sede del comando unico ( autunno 1944). Ferruccio Parri commemora il comandante “Pablo”.
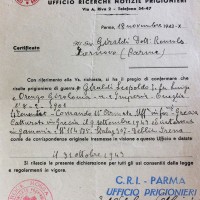 Certificato dell'Ufficio ricerche notizie prigionieri della Croce Rossa
Certificato dell'Ufficio ricerche notizie prigionieri della Croce Rossa Militi della Croce Rossa e dell’Assistenza Pubblica negli anni ’30
Militi della Croce Rossa e dell’Assistenza Pubblica negli anni ’30 Mussolini davanti alla sede della Croce Rossa e dell’Assistenza pubblica durante la visita a Parma, 10 agosto 1941
Mussolini davanti alla sede della Croce Rossa e dell’Assistenza pubblica durante la visita a Parma, 10 agosto 1941 Mussolini davanti alla sede della Croce Rossa e dell’Assistenza pubblica durante la visita a Parma, 10 agosto 1941
Mussolini davanti alla sede della Croce Rossa e dell’Assistenza pubblica durante la visita a Parma, 10 agosto 1941
 Vista aerea dell'area occupata dall'Arrigoni, stabilimenti A, zona stazione (ANPI-Cesena)
Vista aerea dell'area occupata dall'Arrigoni, stabilimenti A, zona stazione (ANPI-Cesena) Cesena, Arrigoni, stabilimenti B, zona Cavalcavia (ANPI-Cesena)
Cesena, Arrigoni, stabilimenti B, zona Cavalcavia (ANPI-Cesena) Benito Mussolini visita uno stabilimento Arrigoni, Anni 30 (ANPI-Cesena)
Benito Mussolini visita uno stabilimento Arrigoni, Anni 30 (ANPI-Cesena) Cesena, manifestazione Arrigoni nell'attuale piazza del Popolo, anni 40
Cesena, manifestazione Arrigoni nell'attuale piazza del Popolo, anni 40 Gerarchi fascisti all'Arrigoni (ANPI-Cesena)
Gerarchi fascisti all'Arrigoni (ANPI-Cesena) Cesena, esterno dello Stabilimento Arrigoni, 1950-1955 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 911)
Cesena, esterno dello Stabilimento Arrigoni, 1950-1955 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 911) Cesena, l'Arrigoni durante la dismissione (Servizio Urbanistica Cesena)
Cesena, l'Arrigoni durante la dismissione (Servizio Urbanistica Cesena) Gli ex spazi Arrigoni oggi occupati da scuole e università
Gli ex spazi Arrigoni oggi occupati da scuole e università L' Arrigoni oggi (l'unico superstite dei tre camini)
L' Arrigoni oggi (l'unico superstite dei tre camini) Targa alla base della ciminiera a ricordo degli scioperi del marzo 1944
Targa alla base della ciminiera a ricordo degli scioperi del marzo 1944 Manifesto pubblicitario dei prodotti Arrigoni (ANPI-Cesena)
Manifesto pubblicitario dei prodotti Arrigoni (ANPI-Cesena)
 Cesena, visita di Benito Mussolini all’Arrigoni, 1935 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 912)
Cesena, visita di Benito Mussolini all’Arrigoni, 1935 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 912) Cesena, Interni dello Stabilimento Arrigoni, visita di importatori tedeschi privati e militari, 1940-1941 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 1534)
Cesena, Interni dello Stabilimento Arrigoni, visita di importatori tedeschi privati e militari, 1940-1941 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 1534) Cesena, Interni dello Stabilimento Arrigoni, visita di importatori tedeschi privati e militari, 1940-1941 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 1533)
Cesena, Interni dello Stabilimento Arrigoni, visita di importatori tedeschi privati e militari, 1940-1941 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 1533) Giorgio Merk Ricordi mostra le produzioni Arrigoni ad ufficiali tedeschi (ANPI-Cesena)
Giorgio Merk Ricordi mostra le produzioni Arrigoni ad ufficiali tedeschi (ANPI-Cesena) Giorgio Sanguinetti incontra Rachele Guidi Mussolini (in mezzo Anna Maria Mussolini), fine anni '30 (ANPI-Cesena)
Giorgio Sanguinetti incontra Rachele Guidi Mussolini (in mezzo Anna Maria Mussolini), fine anni '30 (ANPI-Cesena)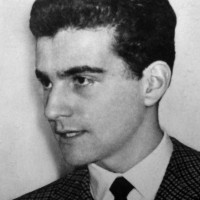 Ferruccio Merk - Ricordi (Teddy Reno)
Ferruccio Merk - Ricordi (Teddy Reno)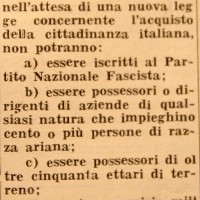 Estratto di articolo di giornale con il divieto per gli ebrei di possedere aziende
Estratto di articolo di giornale con il divieto per gli ebrei di possedere aziende
 Piazza del Popolo in una cartolina del 1901
Piazza del Popolo in una cartolina del 1901 Araldo Dellamore
Araldo Dellamore Chino Bellagamba
Chino Bellagamba Palazzo Albornoz sede del Comune di Cesena
Palazzo Albornoz sede del Comune di Cesena La prima pagina del Popolo di Romagna del 12 novembre 1938
La prima pagina del Popolo di Romagna del 12 novembre 1938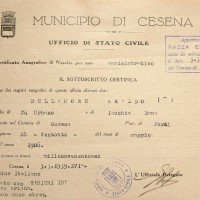 Documento attestante che Araldo Dellamore risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune)
Documento attestante che Araldo Dellamore risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune)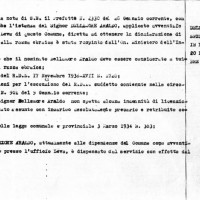 Documento di licenziamento di Araldo Dellamore
Documento di licenziamento di Araldo Dellamore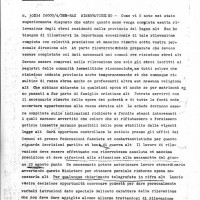 Documento inviato ai Comuni che contiene l'ordine di censimento degli ebrei
Documento inviato ai Comuni che contiene l'ordine di censimento degli ebrei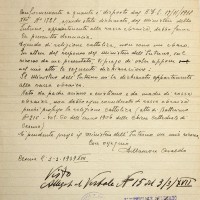 Il ricorso di Araldo Dellamore contro la sua classificazione come ebreo
Il ricorso di Araldo Dellamore contro la sua classificazione come ebreo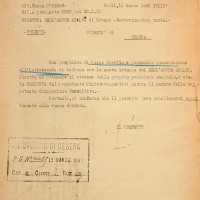 Respingimento del ricorso di Araldo Dellamore
Respingimento del ricorso di Araldo Dellamore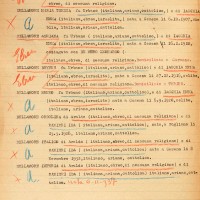 Elenco delle famiglie miste di Cesena - seconda facciata (Archivio di Stato)
Elenco delle famiglie miste di Cesena - seconda facciata (Archivio di Stato)
 Cesena, panorama del Monte Sterlino con vista della Chiesa e del Convento dei frati dell’Osservanza, 1900-1910 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 614)
Cesena, panorama del Monte Sterlino con vista della Chiesa e del Convento dei frati dell’Osservanza, 1900-1910 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 614) Facciata della Chiesa dell'Osservanza
Facciata della Chiesa dell'Osservanza Ingresso al chiostro dell'Osservanza
Ingresso al chiostro dell'Osservanza Il chiostro dell'Osservanza
Il chiostro dell'Osservanza Catacombe del convento dell'Osservanza. Vani delle vecchie tombe
Catacombe del convento dell'Osservanza. Vani delle vecchie tombe Catacombe del convento dell'Osservanza
Catacombe del convento dell'Osservanza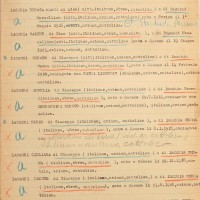 Elenco delle famiglie miste di Cesena - prima facciata (Archivio di Stato)
Elenco delle famiglie miste di Cesena - prima facciata (Archivio di Stato)
 Corrado Saralvo, fine anni '60
Corrado Saralvo, fine anni '60 Il cimitero ebraico di Lugo (RA)
Il cimitero ebraico di Lugo (RA) Tomba di Corrado Saralvo a Lugo (RA)
Tomba di Corrado Saralvo a Lugo (RA) Via carbonari oggi. Uno dei luoghi di Cesena nel quale abitò Corrado Saralvo
Via carbonari oggi. Uno dei luoghi di Cesena nel quale abitò Corrado Saralvo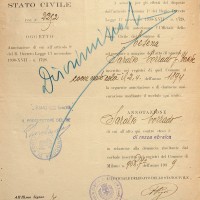 Certificato di razza ebraica di Corrado Saralvo
Certificato di razza ebraica di Corrado Saralvo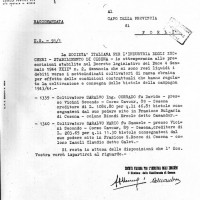 Congelamento di crediti di Corrado Saralvo
Congelamento di crediti di Corrado Saralvo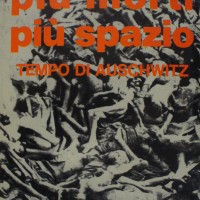 Copertina del libro di Corrado Saralvo - edizione Baldini e Castoldi, 1969
Copertina del libro di Corrado Saralvo - edizione Baldini e Castoldi, 1969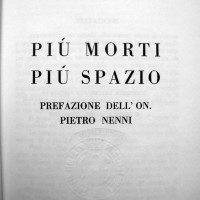 Controcopertina del libro di Corrado Saralvo - edizione Baldini e Castoldi, 1969
Controcopertina del libro di Corrado Saralvo - edizione Baldini e Castoldi, 1969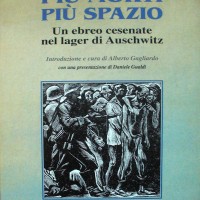 Copertina della riedizione del libro di Corrado Saralvo - Il Ponte Vecchio, 2009
Copertina della riedizione del libro di Corrado Saralvo - Il Ponte Vecchio, 2009
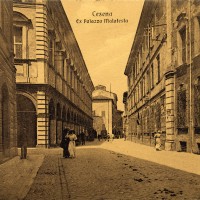 Cesena, ex Palazzo Malatesta (Corso Garibaldi), ante 1913 (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 889)
Cesena, ex Palazzo Malatesta (Corso Garibaldi), ante 1913 (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 889) Cesena, Corso Garibaldi, 1925-1936 circa (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 891)
Cesena, Corso Garibaldi, 1925-1936 circa (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 891)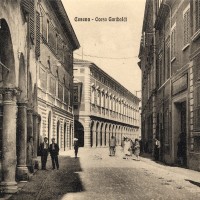 Cesena, Corso Garibaldi, Anni ’40 circa (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 908)
Cesena, Corso Garibaldi, Anni ’40 circa (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 908) Cesena, Palazzo Mori (ex Venturelli) in Corso Garibaldi, demolito fra il 1950-1960, 1910 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 1029)
Cesena, Palazzo Mori (ex Venturelli) in Corso Garibaldi, demolito fra il 1950-1960, 1910 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 1029)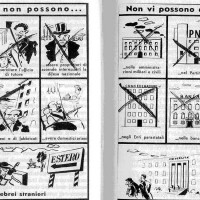 Sintesi dei Provvedimenti di Difesa della Razza del 1938
Sintesi dei Provvedimenti di Difesa della Razza del 1938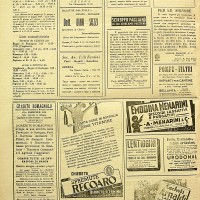 Pubblicità dello studio Balazs sul giornale cattolico "Il Risveglio"
Pubblicità dello studio Balazs sul giornale cattolico "Il Risveglio"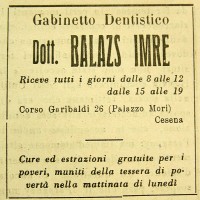 Pubblicità Balazs (dettaglio)
Pubblicità Balazs (dettaglio)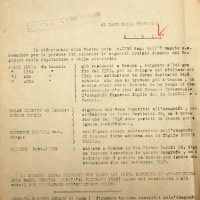 Documento del 1944 attestante l'allontanamento di Balazs da Cesena (Archivio di Stato)
Documento del 1944 attestante l'allontanamento di Balazs da Cesena (Archivio di Stato)
 Cesena, Piazzetta della Concordia e Corso Umberto, 1925- 1930 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 574)
Cesena, Piazzetta della Concordia e Corso Umberto, 1925- 1930 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 574) Cesena, il Duomo, 1935-1940 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 596)
Cesena, il Duomo, 1935-1940 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 596) Cesena, Piazza Pia e Banca d'Italia, 1955 (BCM Fondo Dellamore, FDP 579)
Cesena, Piazza Pia e Banca d'Italia, 1955 (BCM Fondo Dellamore, FDP 579)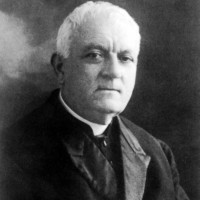 Ritratto di don Giovanni Ravaglia
Ritratto di don Giovanni Ravaglia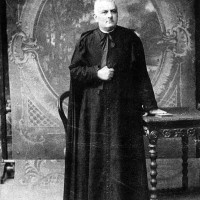 Don Giovanni Ravaglia
Don Giovanni Ravaglia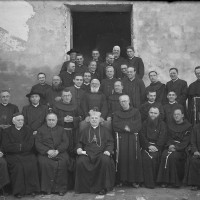 Religiosi e sacerdoti cesenati con il vescovo mons. Beniamino Socche. Il secondo seduto da sinistra è don Giovanni Ravaglia, 1938-1946 circa
Religiosi e sacerdoti cesenati con il vescovo mons. Beniamino Socche. Il secondo seduto da sinistra è don Giovanni Ravaglia, 1938-1946 circa Cesena, il Duomo oggi
Cesena, il Duomo oggi
 Cesena, Corso Umberto I nei primi anni del 1900, 1900-1905 circa (BCM Biblioteca Malatestiana, FDP 582)
Cesena, Corso Umberto I nei primi anni del 1900, 1900-1905 circa (BCM Biblioteca Malatestiana, FDP 582) Particolare veduta dell'abitazione dei Mondolfo, dovuta alla demolizione dell'edificio adiacente, anni 60 (Servizio Urbanistica Cesena)
Particolare veduta dell'abitazione dei Mondolfo, dovuta alla demolizione dell'edificio adiacente, anni 60 (Servizio Urbanistica Cesena) Dora De Semo in Mondolfo
Dora De Semo in Mondolfo Emanuele Hayon Mondolfo
Emanuele Hayon Mondolfo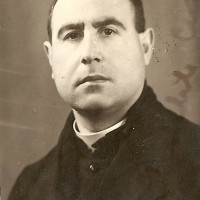 Don Odo Contestabile all'età di 30 anni
Don Odo Contestabile all'età di 30 anni L' attuale ingresso del palazzo abitato dalla famiglia Mondolfo
L' attuale ingresso del palazzo abitato dalla famiglia Mondolfo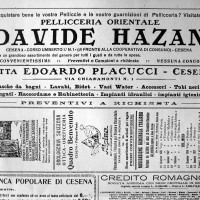 Pubblicità della pellicceria Hazan sul giornale cattolico "Il Risveglio" del 1926
Pubblicità della pellicceria Hazan sul giornale cattolico "Il Risveglio" del 1926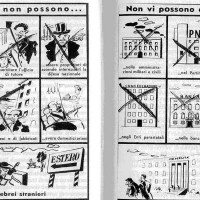 Sintesi dei Provvedimenti di Difesa della Razza del 1938
Sintesi dei Provvedimenti di Difesa della Razza del 1938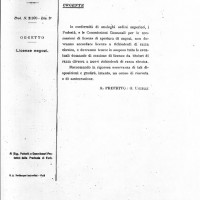 Documento che prescrive il divieto licenze per negozi ebrei (Archivio di Stato)
Documento che prescrive il divieto licenze per negozi ebrei (Archivio di Stato)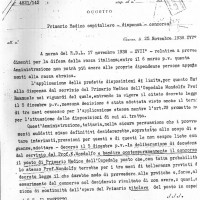 Documento di licenziamento del prof. Mondolfo dall'ospedale (Archivio di Stato)
Documento di licenziamento del prof. Mondolfo dall'ospedale (Archivio di Stato)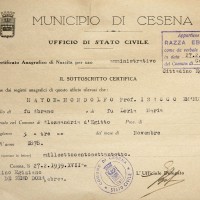 Documento attestante che Emanuele Mondolfo risulta di razza ebraica (Archivio Anagrafico del Comune)
Documento attestante che Emanuele Mondolfo risulta di razza ebraica (Archivio Anagrafico del Comune)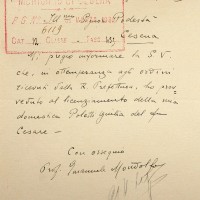 Dichiarazione autografa del prof. Mondolfo dell'avvenuto licenziamento della sua domestica ariana (Archivio di Stato)
Dichiarazione autografa del prof. Mondolfo dell'avvenuto licenziamento della sua domestica ariana (Archivio di Stato)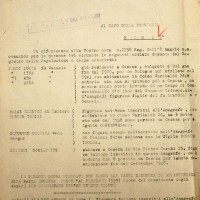 Documento del 1944 attestante l'allontanamento di Hazan da Cesena (Archivio di Stato)
Documento del 1944 attestante l'allontanamento di Hazan da Cesena (Archivio di Stato)
 Cesena, portici in Piazza Vittorio Emanuele, 1900-1905 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 1065)
Cesena, portici in Piazza Vittorio Emanuele, 1900-1905 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 1065) Casa Saralvo interno
Casa Saralvo interno Amalia Levi e Giorgio Saralvo
Amalia Levi e Giorgio Saralvo Giorgio Saralvo (terzo da sinistra) in una scherzosa seduta spiritica. Alla sua destra Cino Pedrelli
Giorgio Saralvo (terzo da sinistra) in una scherzosa seduta spiritica. Alla sua destra Cino Pedrelli Casa Saralvo (esterno, dettaglio)
Casa Saralvo (esterno, dettaglio) La casa dei Saralvo in piazza del Popolo
La casa dei Saralvo in piazza del Popolo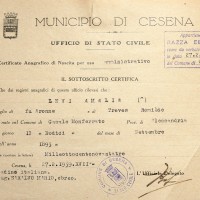 Documento attestante che Amalia Levi risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune)
Documento attestante che Amalia Levi risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune) Documento attestante che Giorgio Saralvo risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune)
Documento attestante che Giorgio Saralvo risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune)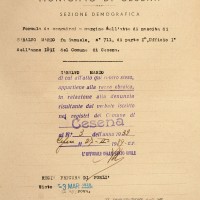 Documento attestante che Mario Saralvo risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune)
Documento attestante che Mario Saralvo risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune)
 L'Istituto Sacra Famiglia negli anni '39-'40 circa
L'Istituto Sacra Famiglia negli anni '39-'40 circa Il cortile dell'Istituto Sacra Famiglia negli anni '39-'40 circa
Il cortile dell'Istituto Sacra Famiglia negli anni '39-'40 circa Don Odo Contestabile e suo padre con un gruppo di alunne avviate all'Istituto della Sacra Famiglia
Don Odo Contestabile e suo padre con un gruppo di alunne avviate all'Istituto della Sacra Famiglia Don Odo Contestabile davanti al cimitero di Cunardo (VA)
Don Odo Contestabile davanti al cimitero di Cunardo (VA) Don Odo e i Lerher verso il confine svizzero (disegno di G. Cappelli)
Don Odo e i Lerher verso il confine svizzero (disegno di G. Cappelli)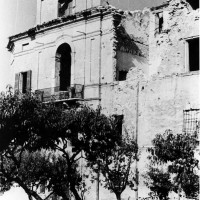 Cesena, l'Abbazia del Monte dopo i bombardamenti dell'ottobre del 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 527)
Cesena, l'Abbazia del Monte dopo i bombardamenti dell'ottobre del 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 527) Cesena, l'Abbazia del Monte dopo i bombardamenti dell'ottobre del 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 529)
Cesena, l'Abbazia del Monte dopo i bombardamenti dell'ottobre del 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 529)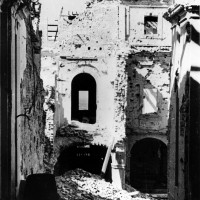 Cesena, l'Abbazia del Monte dopo i bombardamenti dell'ottobre del 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 530)
Cesena, l'Abbazia del Monte dopo i bombardamenti dell'ottobre del 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 530) Cesena, l'Abbazia del Monte dopo i bombardamenti dell'ottobre del 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 531)
Cesena, l'Abbazia del Monte dopo i bombardamenti dell'ottobre del 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 531) L'Istituto Sacra Famiglia oggi
L'Istituto Sacra Famiglia oggi L'abbazia di Santa Maria del Monte oggi
L'abbazia di Santa Maria del Monte oggi
 Cesena, chiesa già “Casa di Dio” in Corso Ubaldo Comandini, 1976-1979 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 2275)
Cesena, chiesa già “Casa di Dio” in Corso Ubaldo Comandini, 1976-1979 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 2275) La casa delle sorelle Jacchia in corso Comandini
La casa delle sorelle Jacchia in corso Comandini L'ingresso della casa delle Jacchia
L'ingresso della casa delle Jacchia Forlì, ex-Albergo Commercio in corso Diaz
Forlì, ex-Albergo Commercio in corso Diaz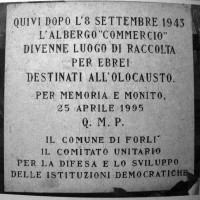 La lapide posta sull'edificio dove sorgeva l'Albergo Commercio in corso Diaz a Forlì
La lapide posta sull'edificio dove sorgeva l'Albergo Commercio in corso Diaz a Forlì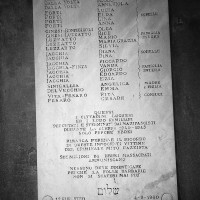 Lapide nel cimitero ebraico di Lugo (RA)
Lapide nel cimitero ebraico di Lugo (RA)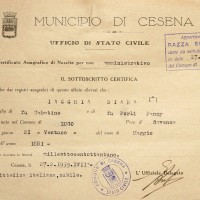 Documento attestante che Diana Jacchia risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune)
Documento attestante che Diana Jacchia risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune)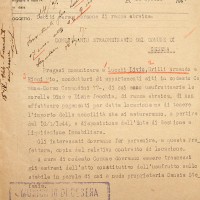 Documento di confisca della casa delle sorelle Jacchia (Archivio di Stato)
Documento di confisca della casa delle sorelle Jacchia (Archivio di Stato)
 Cesena, Corso Cavour, 1900-1910 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 884)
Cesena, Corso Cavour, 1900-1910 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 884) Mario Guidazzi
Mario Guidazzi Mario Guidazzi con le figlie
Mario Guidazzi con le figlie Il luogo dove fu ucciso Mario Guidazzi come si presenta oggi
Il luogo dove fu ucciso Mario Guidazzi come si presenta oggi La lapide dedicata a Mario Guidazzi posta nel luogo dove fu assassinato
La lapide dedicata a Mario Guidazzi posta nel luogo dove fu assassinato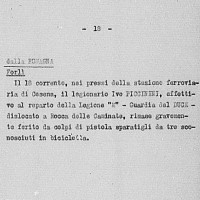 Estratto del Bollettino GNR_27 gennaio 1944-1
Estratto del Bollettino GNR_27 gennaio 1944-1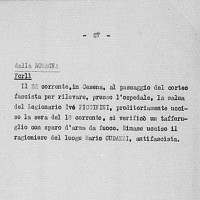 Estratto del Bollettino GNR_ 27 gennaio 1944-2
Estratto del Bollettino GNR_ 27 gennaio 1944-2
 Cesena, Piazza Vittorio Emanuele II, 1895-1905 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 1047)
Cesena, Piazza Vittorio Emanuele II, 1895-1905 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 1047) Cesena, Albergo Leon D'Oro, 1905-1910 circa. Dopo la liberazione fu trasformato in un luogo di svago per gli Alleati (BCM Fondo Dellamore, FDP 1066)
Cesena, Albergo Leon D'Oro, 1905-1910 circa. Dopo la liberazione fu trasformato in un luogo di svago per gli Alleati (BCM Fondo Dellamore, FDP 1066) Manifestazione di solidarietà con la Russia dei Soviet, Cesena, Piazza del Popolo, 1920 (BCM Fondo Casaboni, FCP 547)
Manifestazione di solidarietà con la Russia dei Soviet, Cesena, Piazza del Popolo, 1920 (BCM Fondo Casaboni, FCP 547) Cesena, la cerimonia, in Municipio, dell'insediamento del primo Podestà di Cesena, A. Biagini, 1927 (BCM Fondo Dellamore, FDP 709)
Cesena, la cerimonia, in Municipio, dell'insediamento del primo Podestà di Cesena, A. Biagini, 1927 (BCM Fondo Dellamore, FDP 709)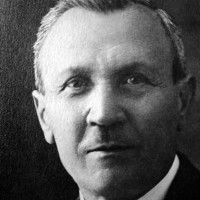 Enrico Franchini, ultimo sindaco di Cesena prima dell'occupazione del Comune da parte dei fascisti (30 ottobre 1922)
Enrico Franchini, ultimo sindaco di Cesena prima dell'occupazione del Comune da parte dei fascisti (30 ottobre 1922) 1928. Antonio Manuzzi a 26 anni (Foto archivio Bruno Evangelisti)
1928. Antonio Manuzzi a 26 anni (Foto archivio Bruno Evangelisti)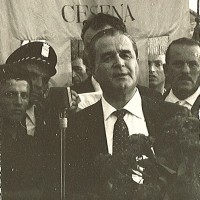 27 agosto 1963. Antonio Manuzzi commemora Cino Macrelli al Cimitero di Cesena
27 agosto 1963. Antonio Manuzzi commemora Cino Macrelli al Cimitero di Cesena Sigfrido Sozzi, primo sindaco di Cesena liberata
Sigfrido Sozzi, primo sindaco di Cesena liberata Cino Macrelli (Sarsina, 21 gennaio 1887 - Roma, 25 agosto 1963)
Cino Macrelli (Sarsina, 21 gennaio 1887 - Roma, 25 agosto 1963) Il sindaco Leopoldo Lucchi commemorava il 20 ottobre deponendo una corona sotto la lapide dei martiri partigiani
Il sindaco Leopoldo Lucchi commemorava il 20 ottobre deponendo una corona sotto la lapide dei martiri partigiani Leopoldo Lucchi (anni '70)
Leopoldo Lucchi (anni '70) Studenti davanti alla lapide di Gastone Sozzi. Li osserva l'ex-partigiano Adriano Benini sul ciglio della vecchia sede ANPI
Studenti davanti alla lapide di Gastone Sozzi. Li osserva l'ex-partigiano Adriano Benini sul ciglio della vecchia sede ANPI Palazzo Albornoz, sede del Comune, oggi
Palazzo Albornoz, sede del Comune, oggi Il loggiato del Comune oggi
Il loggiato del Comune oggi Loggiato comunale, la lapide che riporta la motivazione della medaglia d'argento data alla città di Cesena
Loggiato comunale, la lapide che riporta la motivazione della medaglia d'argento data alla città di Cesena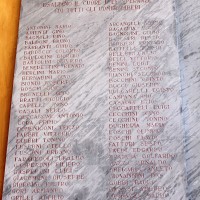 Loggiato comunale, la lapide dedicata alla memoria dei martiri della Resistenza- 1
Loggiato comunale, la lapide dedicata alla memoria dei martiri della Resistenza- 1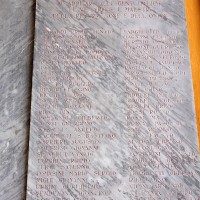 Loggiato comunale, la lapide dedicata alla memoria dei martiri per la Resistenza- 2
Loggiato comunale, la lapide dedicata alla memoria dei martiri per la Resistenza- 2 Loggiato comunale, la lapide dedicata alla memoria di Gastone Sozzi
Loggiato comunale, la lapide dedicata alla memoria di Gastone Sozzi Loggiato comunale, la lapide dedicata alla memoria di Giovanni Merloni
Loggiato comunale, la lapide dedicata alla memoria di Giovanni Merloni Una lapide del loggiato con i segni delle pallottole della Seconda Guerra mondiale
Una lapide del loggiato con i segni delle pallottole della Seconda Guerra mondiale
 Cesena, Palazzo del Ridotto, 1893 circa (BCM Fondo Casalboni, FCP 53)
Cesena, Palazzo del Ridotto, 1893 circa (BCM Fondo Casalboni, FCP 53) Cesena, Palazzo del Ridotto, 1905-1915 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 1075)
Cesena, Palazzo del Ridotto, 1905-1915 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 1075) Bernhard Brumer (Archivio fotografico CDEC)
Bernhard Brumer (Archivio fotografico CDEC) Bernhard Brumer a Cesenatico
Bernhard Brumer a Cesenatico Don Adamo Carloni
Don Adamo Carloni Forlì, cimitero monumentale
Forlì, cimitero monumentale Il Palazzo del Ridotto oggi
Il Palazzo del Ridotto oggi La lapide sul Palazzo del Ridotto
La lapide sul Palazzo del Ridotto
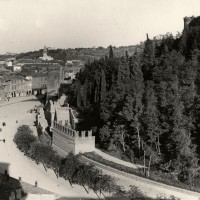 Cesena, vista di viale Mazzoni dal campanile della chiesa di S. Domenico, 1925 (BCM Fondo Dellamore, FDP 766
Cesena, vista di viale Mazzoni dal campanile della chiesa di S. Domenico, 1925 (BCM Fondo Dellamore, FDP 766 Cesena, manifestazione pubblica in viale Mazzoni davanti al Monumento ai caduti, Anni '30 circa (BCM Fondo Manuzzi, FMN 2886
Cesena, manifestazione pubblica in viale Mazzoni davanti al Monumento ai caduti, Anni '30 circa (BCM Fondo Manuzzi, FMN 2886 Viale Mazzoni, il muro protettivo antischegge oggi (fronte)
Viale Mazzoni, il muro protettivo antischegge oggi (fronte) Viale Mazzoni, il muro protettivo antischegge oggi (lato)
Viale Mazzoni, il muro protettivo antischegge oggi (lato) L'interno del rifugio come si presenta oggi
L'interno del rifugio come si presenta oggi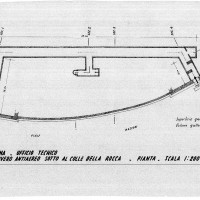 Ricovero Antiaereo - Pianta
Ricovero Antiaereo - Pianta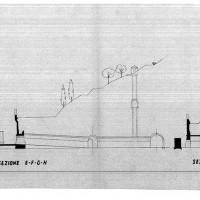 Progetto di ampliamento del Ricovero Antiaereo- Sezione
Progetto di ampliamento del Ricovero Antiaereo- Sezione Prima pagina del libro del Comune in cui si registravano gli allarmi aerei (1940-1944)
Prima pagina del libro del Comune in cui si registravano gli allarmi aerei (1940-1944)
 Cesena, una rara fotografia della Rocca Malatestiana risalente agli anni 1880-1885 (BCM Fondo Dellamore, FDP 113)
Cesena, una rara fotografia della Rocca Malatestiana risalente agli anni 1880-1885 (BCM Fondo Dellamore, FDP 113) Cesena, Rocca Malatestiana, 1910-1915 circa (BCM Fondo Lelli Mami, FCP 476)
Cesena, Rocca Malatestiana, 1910-1915 circa (BCM Fondo Lelli Mami, FCP 476) Cesena, la Rocca Malatestiana vista all’interno del muro di cinta, 1900-1915 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 120)
Cesena, la Rocca Malatestiana vista all’interno del muro di cinta, 1900-1915 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 120) Ezio Casadei, liberato nell'azione gappista del febbraio 1944
Ezio Casadei, liberato nell'azione gappista del febbraio 1944 Werther Ricchi, "suicidato" dai fascisti nel carcere della Rocca nell'aprile 1944
Werther Ricchi, "suicidato" dai fascisti nel carcere della Rocca nell'aprile 1944 Le torri della Rocca oggi
Le torri della Rocca oggi L'ingresso alla Rocca oggi
L'ingresso alla Rocca oggi Il muro dove è avvenuta la fucilazione del 4 settembre 1944
Il muro dove è avvenuta la fucilazione del 4 settembre 1944 La cella dove furono rinchiusi Ezio Casadei e Primo Pasolini, liberati nel primo assalto alla Rocca
La cella dove furono rinchiusi Ezio Casadei e Primo Pasolini, liberati nel primo assalto alla Rocca La casa sulla Diavolessa, da dove partirono i gappisti per il primo assalto alla Rocca
La casa sulla Diavolessa, da dove partirono i gappisti per il primo assalto alla Rocca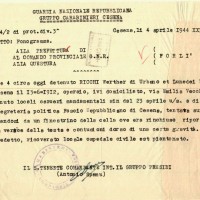 Comunicazione sulle condizioni fisiche di Ricchi Werther
Comunicazione sulle condizioni fisiche di Ricchi Werther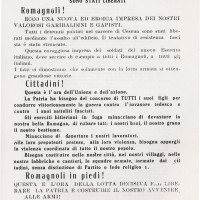 Il volantino del PCd'I del giugno '44, che inneggia all'azione gappista
Il volantino del PCd'I del giugno '44, che inneggia all'azione gappista
 Cesena, Corso Umberto I, 1920-1922 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 888)
Cesena, Corso Umberto I, 1920-1922 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 888) Cesena, Corso Umberto I. Palazzo Fantaguzzi sede della Banca Popolare e Palazzo Ghini, Anni '40 circa (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 1132)
Cesena, Corso Umberto I. Palazzo Fantaguzzi sede della Banca Popolare e Palazzo Ghini, Anni '40 circa (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 1132) Cesena, il palazzo della Banca Popolare, già Palazzo Fantaguzzi, 1956 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 723)
Cesena, il palazzo della Banca Popolare, già Palazzo Fantaguzzi, 1956 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 723) Cesena, il palazzo dei conti Fantaguzzi in Corso Sozzi, 1978 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1011)
Cesena, il palazzo dei conti Fantaguzzi in Corso Sozzi, 1978 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1011) Palazzo Fantaguzzi, sede della Banca Popolare di Cesena come appare oggi
Palazzo Fantaguzzi, sede della Banca Popolare di Cesena come appare oggi
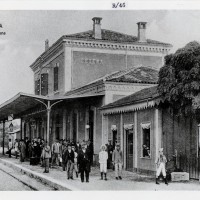 Cesena, Stazione, 1905-1910 circa, (BCM Fondo Dellamore, FDP 1242)
Cesena, Stazione, 1905-1910 circa, (BCM Fondo Dellamore, FDP 1242) Cesena, corteo delle Autorità diretto al cantiere della nuova stazione ferroviaria per la cerimonia della posa della prima pietra, 1925 (BC)
Cesena, corteo delle Autorità diretto al cantiere della nuova stazione ferroviaria per la cerimonia della posa della prima pietra, 1925 (BC) Cesena, autorità e cittadini presenti alla posa della prima pietra della nuova stazione, 1925 (BCM Fondo Dellamore, FDP 699)
Cesena, autorità e cittadini presenti alla posa della prima pietra della nuova stazione, 1925 (BCM Fondo Dellamore, FDP 699) Cesena, Stazione, 1925-1935 circa (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 1219)
Cesena, Stazione, 1925-1935 circa (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 1219) Cesena, la nuova stazione ferroviaria, 1928-1930 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1245)
Cesena, la nuova stazione ferroviaria, 1928-1930 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1245)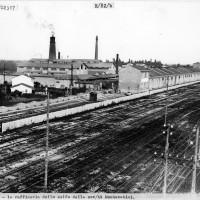 Cesena, la raffineria dello zolfo della società Montecatini, 1926 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1446)
Cesena, la raffineria dello zolfo della società Montecatini, 1926 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1446) Cesena, guerra 1940-1941: il bombardamento dello scalo ferroviario, prima ondata, 24 giugno 1944 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1198)
Cesena, guerra 1940-1941: il bombardamento dello scalo ferroviario, prima ondata, 24 giugno 1944 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1198) La stazione di Cesena oggi
La stazione di Cesena oggi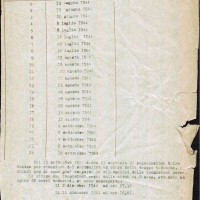 Elenco dei bombardamenti su Cesena
Elenco dei bombardamenti su Cesena
 Eleuterio Massari con la moglie
Eleuterio Massari con la moglie Romualdi (in prima fila quarto da sinistra) con ufficiali della Brigata Nera nel cortile del comando
Romualdi (in prima fila quarto da sinistra) con ufficiali della Brigata Nera nel cortile del comando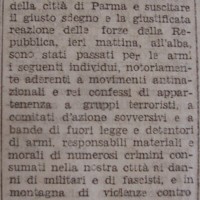 Articolo di giornale che riporta la notizia dell'eccidio
Articolo di giornale che riporta la notizia dell'eccidio Il corpo di Eleuterio Massari viene riportato a casa dalla moglie (“Oltretorrente 1 settembre 1944”, Remo Gaibazzi)
Il corpo di Eleuterio Massari viene riportato a casa dalla moglie (“Oltretorrente 1 settembre 1944”, Remo Gaibazzi)
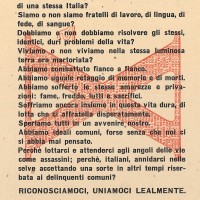 Nella prima fase dell’occupazione nazista i fascisti della Repubblica Sociale Italiana rivolgono appelli agli italiani affinché si ricompattino nella lotta contro gli Alleati. I loro sforzi propagandistici non ottengono, tuttavia, un seguito di massa.
Nella prima fase dell’occupazione nazista i fascisti della Repubblica Sociale Italiana rivolgono appelli agli italiani affinché si ricompattino nella lotta contro gli Alleati. I loro sforzi propagandistici non ottengono, tuttavia, un seguito di massa. Il manifesto mostra un esempio della propaganda anti-sovietica fascista. La Repubblica Sociale Italiana cavalca le paure nei confronti del bolscevismo per dipingere una minaccia incombente sull’Europa, arrestabile soltanto con l’intervento armato dell’Asse.
Il manifesto mostra un esempio della propaganda anti-sovietica fascista. La Repubblica Sociale Italiana cavalca le paure nei confronti del bolscevismo per dipingere una minaccia incombente sull’Europa, arrestabile soltanto con l’intervento armato dell’Asse.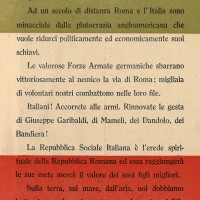 Per incitare gli italiani a riunirsi nella lotta contro gli anglo-americani, la propaganda fascista recupera alcuni momenti della storia risorgimentale, collegando gli esempi del patriottismo alla fedeltà nei confronti dei nazisti. In questo volantino anche il tricolore viene utilizzato per rimarcare l’unica “italianità” che i fascisti ritengono possibile, ovvero quella subalterna all’occupazione nazista.
Per incitare gli italiani a riunirsi nella lotta contro gli anglo-americani, la propaganda fascista recupera alcuni momenti della storia risorgimentale, collegando gli esempi del patriottismo alla fedeltà nei confronti dei nazisti. In questo volantino anche il tricolore viene utilizzato per rimarcare l’unica “italianità” che i fascisti ritengono possibile, ovvero quella subalterna all’occupazione nazista.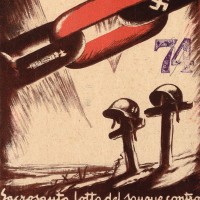 La propaganda della Repubblica Sociale Italiana recupera l’avversione alle democrazie occidentali contrapponendo alla loro ricchezza l’esaltazione della razza.
La propaganda della Repubblica Sociale Italiana recupera l’avversione alle democrazie occidentali contrapponendo alla loro ricchezza l’esaltazione della razza.
 Casa del mutilato, esterni
Casa del mutilato, esterni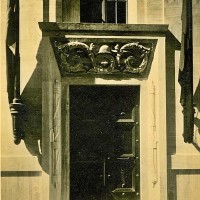 Casa del mutilato, esterni
Casa del mutilato, esterni Casa del mutilato, esterni
Casa del mutilato, esterni Casa del mutilato, esterni
Casa del mutilato, esterni Casa del mutilato, esterni
Casa del mutilato, esterni Casa del mutilato, esterni
Casa del mutilato, esterni Casa del mutilato, esterni
Casa del mutilato, esterni Casa del mutilato, esterni
Casa del mutilato, esterni Casa del mutilato, interni
Casa del mutilato, interni Casa del mutilato, interni
Casa del mutilato, interni Casa del mutilato, interni
Casa del mutilato, interni Manifestazione invalidi di guerra, anni '20
Manifestazione invalidi di guerra, anni '20
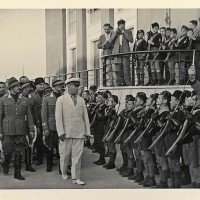 Inaugurazione della Casa della Gioventù italiana del littorio (1936)
Inaugurazione della Casa della Gioventù italiana del littorio (1936) Casa della Gioventù italiana del littorio, interni
Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014
Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014 Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014
Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014 Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014
Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014 Ex Casa della Gioventù italiana del littorio prima dei recenti lavori
Ex Casa della Gioventù italiana del littorio prima dei recenti lavori Casa della Gioventù italiana del littorio, interni
Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Casa della Gioventù italiana del littorio, interni
Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Casa della Gioventù italiana del littorio, interni
Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014
Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014 Casa della Gioventù italiana del littorio, interni
Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Casa della Gioventù italiana del littorio, interni
Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Casa della Gioventù italiana del littorio, interni
Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Casa della Gioventù italiana del littorio, interni
Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Casa della Gioventù italiana del littorio, interni
Casa della Gioventù italiana del littorio, interni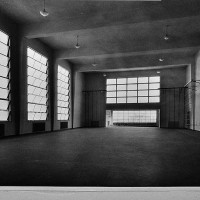 Casa della Gioventù italiana del littorio, interni
Casa della Gioventù italiana del littorio, interni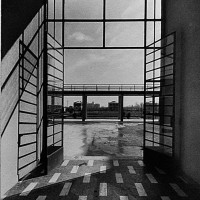 Casa della Gioventù italiana del littorio, interni
Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014
Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014 Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014
Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014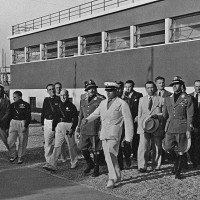 Inaugurazione della Casa della Gioventù italiana del littorio (1936)
Inaugurazione della Casa della Gioventù italiana del littorio (1936) Casa della Gioventù italiana del littorio
Casa della Gioventù italiana del littorio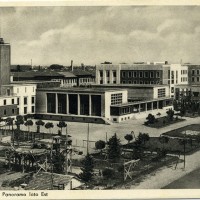 Casa della Gioventù italiana del littorio
Casa della Gioventù italiana del littorio Casa della Gioventù italiana del littorio
Casa della Gioventù italiana del littorio Casa della Gioventù italiana del littorio
Casa della Gioventù italiana del littorio Casa della Gioventù italiana del littorio
Casa della Gioventù italiana del littorio Casa della Gioventù italiana del littorio
Casa della Gioventù italiana del littorio Casa della Gioventù italiana del littorio
Casa della Gioventù italiana del littorio Casa della Gioventù italiana del littorio
Casa della Gioventù italiana del littorio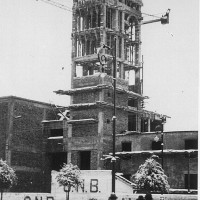 Casa della Gioventù italiana del littorio durante la costruzione
Casa della Gioventù italiana del littorio durante la costruzione Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014
Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014 Casa della Gioventù italiana del littorio
Casa della Gioventù italiana del littorio Casa della Gioventù italiana del littorio
Casa della Gioventù italiana del littorio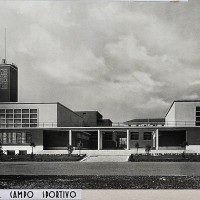 Casa della Gioventù italiana del littorio, veduta verso il campo sportivo
Casa della Gioventù italiana del littorio, veduta verso il campo sportivo Casa della Gioventù italiana del littorio, lato esterno della piscina
Casa della Gioventù italiana del littorio, lato esterno della piscina Casa della Gioventù italiana del littorio, portico di collegamento
Casa della Gioventù italiana del littorio, portico di collegamento Casa della Gioventù italiana del littorio, portico e palestra scoperta
Casa della Gioventù italiana del littorio, portico e palestra scoperta Casa della Gioventù italiana del littorio in un'immagine dell'Archivio privato C. Valle
Casa della Gioventù italiana del littorio in un'immagine dell'Archivio privato C. Valle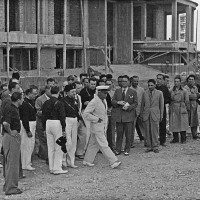 Mussolini visita il cantiere della Casa della Gioventù italiana del littorio
Mussolini visita il cantiere della Casa della Gioventù italiana del littorio
 Tre giovani donne passeggiano a braccetto fuori dalle mura del Castello Campori, nell’attuale piazza Lusvardi. Durante l’occupazione tedesca i momenti di svago diventano sempre più precari. I ragazzi renitenti alla leva escono il meno possibile e si concedono un pomeriggio di divertimento solo quando non resistono alla tentazione. Per diversi di loro, l’8 giugno 1944, il bisogno di evasione diventa però una trappola.
Tre giovani donne passeggiano a braccetto fuori dalle mura del Castello Campori, nell’attuale piazza Lusvardi. Durante l’occupazione tedesca i momenti di svago diventano sempre più precari. I ragazzi renitenti alla leva escono il meno possibile e si concedono un pomeriggio di divertimento solo quando non resistono alla tentazione. Per diversi di loro, l’8 giugno 1944, il bisogno di evasione diventa però una trappola. Un gruppo di giostrai in posa davanti alle proprie strutture, collocate fuori dalle mura del Castello Campori, nell’attuale piazza Lusvardi. Durante la Seconda guerra mondiale molti comuni inaspriscono le misure di sicurezza per il timore di attacchi aerei e per non ostacolare i soccorsi con strutture voluminose sul suolo pubblico. Anche le autorizzazioni per l’impianto di giostre diventano più rare e caratterizzano periodi più brevi.
Un gruppo di giostrai in posa davanti alle proprie strutture, collocate fuori dalle mura del Castello Campori, nell’attuale piazza Lusvardi. Durante la Seconda guerra mondiale molti comuni inaspriscono le misure di sicurezza per il timore di attacchi aerei e per non ostacolare i soccorsi con strutture voluminose sul suolo pubblico. Anche le autorizzazioni per l’impianto di giostre diventano più rare e caratterizzano periodi più brevi.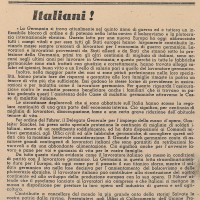 Questo manifesto del "Plenipotenziario generale per l'impiego della mano d'opera della Provincia di Bologna" mostra come i nazisti tentano di reclutare con la propaganda lavoratori italiani per le industrie di guerra in Germania.
Questo manifesto del "Plenipotenziario generale per l'impiego della mano d'opera della Provincia di Bologna" mostra come i nazisti tentano di reclutare con la propaganda lavoratori italiani per le industrie di guerra in Germania.
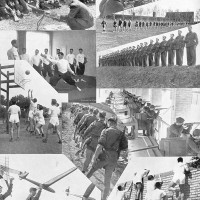 Attività allievi collegio
Attività allievi collegio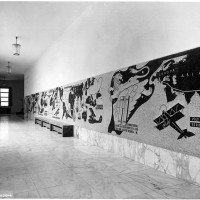 Mosaici interni
Mosaici interni Ex Collegio aeronautico “B. Mussolini”, Lapide esterna 1943-1983
Ex Collegio aeronautico “B. Mussolini”, Lapide esterna 1943-1983 Il Popolo di Romagna, n. 49, a. XVII, Forlì 10 dic 1938, XVII
Il Popolo di Romagna, n. 49, a. XVII, Forlì 10 dic 1938, XVII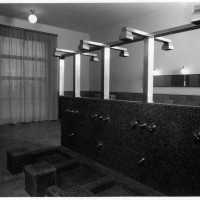 Interni, bagni
Interni, bagni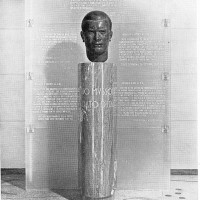 Interni, sala Mussolini
Interni, sala Mussolini Interni, sala Mussolini
Interni, sala Mussolini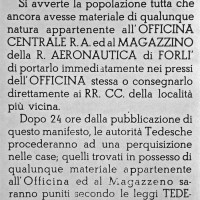 Manifesto Comando tedesco aeronautico Forlì
Manifesto Comando tedesco aeronautico Forlì Mosaici interni
Mosaici interni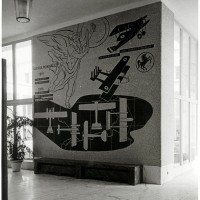 Mosaici interni
Mosaici interni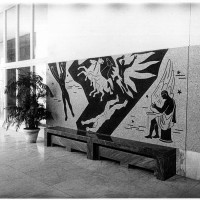 Mosaici interni
Mosaici interni Mosaici interni
Mosaici interni Ex Collegio aeronautico “B. Mussolini”, 2014
Ex Collegio aeronautico “B. Mussolini”, 2014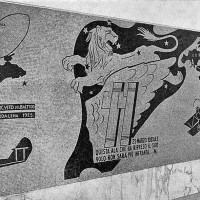 Mosaici interni
Mosaici interni Mosaici interni
Mosaici interni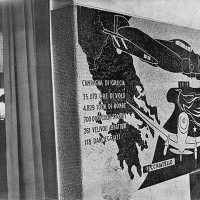 Mosaici interni
Mosaici interni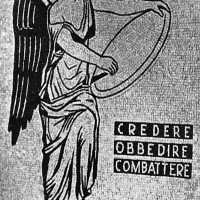 Mosaici interni
Mosaici interni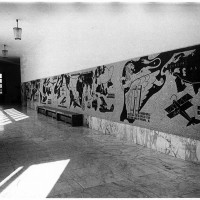 Mosaici interni
Mosaici interni Mosaici interni
Mosaici interni Mosaici pavimenti esterni scale ingresso
Mosaici pavimenti esterni scale ingresso Mosaici pavimenti esterni scale ingresso
Mosaici pavimenti esterni scale ingresso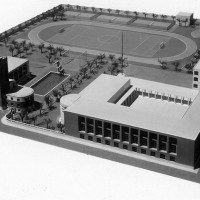 Plastico del progetto Collegio aeronautico “B. Mussolini”
Plastico del progetto Collegio aeronautico “B. Mussolini” Ex Collegio aeronautico “B. Mussolini”, 2014
Ex Collegio aeronautico “B. Mussolini”, 2014 Ex Collegio aeronautico “B. Mussolini”, 2014
Ex Collegio aeronautico “B. Mussolini”, 2014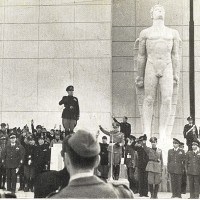 Collegio aeronautico “B. Mussolini”, Cerimonia fascista
Collegio aeronautico “B. Mussolini”, Cerimonia fascista Collegio aeronautico “B. Mussolini”, inaugurazione
Collegio aeronautico “B. Mussolini”, inaugurazione Collegio aeronautico “B. Mussolini”, statua di Icaro
Collegio aeronautico “B. Mussolini”, statua di Icaro Collegio aeronautico “B. Mussolini”, statua di Icaro oggi
Collegio aeronautico “B. Mussolini”, statua di Icaro oggi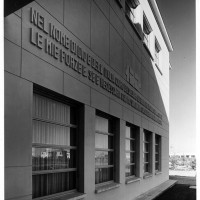 Collegio aeronautico “B. Mussolini”, esterni
Collegio aeronautico “B. Mussolini”, esterni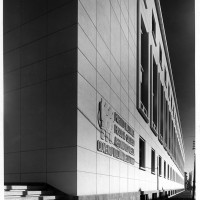 Collegio aeronautico “B. Mussolini”, esterni
Collegio aeronautico “B. Mussolini”, esterni Collegio aeronautico “B. Mussolini”, esterni
Collegio aeronautico “B. Mussolini”, esterni Collegio aeronautico “B. Mussolini”, in costruzione
Collegio aeronautico “B. Mussolini”, in costruzione Collegio aeronautico “B. Mussolini”, inaugurazione
Collegio aeronautico “B. Mussolini”, inaugurazione Collegio aeronautico “B. Mussolini”, inaugurazione
Collegio aeronautico “B. Mussolini”, inaugurazione Collegio aeronautico “B. Mussolini”, inaugurazione
Collegio aeronautico “B. Mussolini”, inaugurazione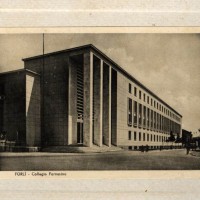 Collegio Farnesina
Collegio Farnesina Ex Collegio aeronautico “B. Mussolini”, 2014
Ex Collegio aeronautico “B. Mussolini”, 2014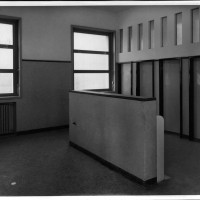 Collegio, interni
Collegio, interni Collegio, interni
Collegio, interni Collegio, interni
Collegio, interni Collegio, interni
Collegio, interni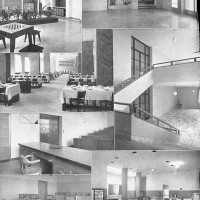 Collegio, interni
Collegio, interni Collegio, interni
Collegio, interni Collegio, interni
Collegio, interni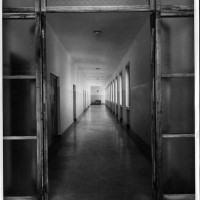 Collegio, interni
Collegio, interni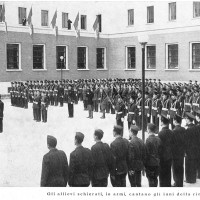 Cortile interno
Cortile interno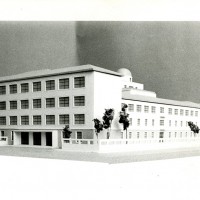 Plastico del progetto Collegio aeronautico “B. Mussolini”
Plastico del progetto Collegio aeronautico “B. Mussolini”
 Le lapidi riunite all'ex Ippodromo.
Le lapidi riunite all'ex Ippodromo.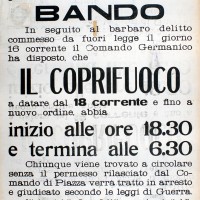 A seguito dell'uccisione di Bocchi viene introdotto il coprifuoco a Modena.
A seguito dell'uccisione di Bocchi viene introdotto il coprifuoco a Modena.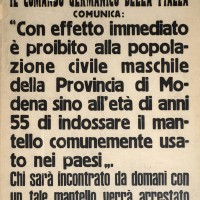 Divieto di indossare il mantello (in inverno!) per timore che così fossero nascoste armi.
Divieto di indossare il mantello (in inverno!) per timore che così fossero nascoste armi.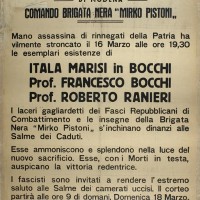 Manifesto che ricorda la morte di Francesco Bocchi. I partigiani intendevano catturarlo per portarlo a Monchio, perché era considerato il principale responsabile della strage.
Manifesto che ricorda la morte di Francesco Bocchi. I partigiani intendevano catturarlo per portarlo a Monchio, perché era considerato il principale responsabile della strage. Una delle rappresaglie invernali che utilizza partigiani prigionieri in carcere a Modena. Bettolino di Vignola 13 febbraio 1945.
Una delle rappresaglie invernali che utilizza partigiani prigionieri in carcere a Modena. Bettolino di Vignola 13 febbraio 1945.
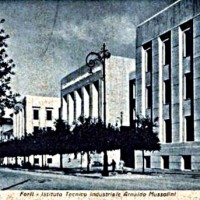 Cartolina Istituto Tecnico Industriale A. Mussolini
Cartolina Istituto Tecnico Industriale A. Mussolini Istituto Tecnico A. Mussolini, danni di guerra
Istituto Tecnico A. Mussolini, danni di guerra Istituto Tecnico A. Mussolini, danni di guerra
Istituto Tecnico A. Mussolini, danni di guerra Istituto Tecnico A. Mussolini, danni di guerra
Istituto Tecnico A. Mussolini, danni di guerra Istituto Tecnico A. Mussolini, danni di guerra
Istituto Tecnico A. Mussolini, danni di guerra Esterno Istituto Tecnico A. Mussolini
Esterno Istituto Tecnico A. Mussolini Istituto tecnico A. Mussolini, interni
Istituto tecnico A. Mussolini, interni Istituto tecnico A. Mussolini, interni
Istituto tecnico A. Mussolini, interni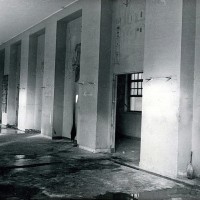 Istituto tecnico A. Mussolini, interni
Istituto tecnico A. Mussolini, interni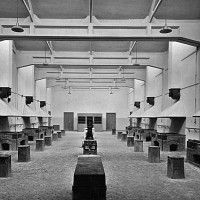 Istituto tecnico A. Mussolini, interni
Istituto tecnico A. Mussolini, interni Istituto tecnico A. Mussolini, interni
Istituto tecnico A. Mussolini, interni Istituto tecnico A. Mussolini, interni
Istituto tecnico A. Mussolini, interni Istituto tecnico A. Mussolini, interni
Istituto tecnico A. Mussolini, interni Istituto Tecnico A. Mussolini
Istituto Tecnico A. Mussolini Istituto tecnico A. Mussolini, interni
Istituto tecnico A. Mussolini, interni L'istituto tecnico A. Mussolini in costruzione
L'istituto tecnico A. Mussolini in costruzione
 Palazzo degli Studi e piazza Bufalini, 1893 (BCM Fondo Dellamore, FDP 482)
Palazzo degli Studi e piazza Bufalini, 1893 (BCM Fondo Dellamore, FDP 482) Biblioteca Malatestiana oggi (foto dell'autore)
Biblioteca Malatestiana oggi (foto dell'autore)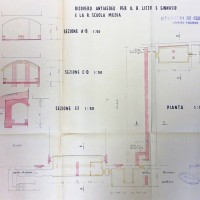 Planimetria del primo rifugio, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28)
Planimetria del primo rifugio, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28) Locali del primo rifugio oggi (foto dell'autore)
Locali del primo rifugio oggi (foto dell'autore) Locali del secondo rifugio oggi (foto dell'autore)
Locali del secondo rifugio oggi (foto dell'autore) Planimetria del terzo rifugio, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28)
Planimetria del terzo rifugio, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28) Planimetria del quarto rifugio, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28)
Planimetria del quarto rifugio, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28) Planimetria dei ricoveri scolastici a Cesena, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28)
Planimetria dei ricoveri scolastici a Cesena, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28)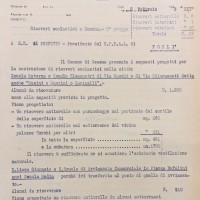 Elenco dei ricoveri scolastici a Cesena 1di3, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28)
Elenco dei ricoveri scolastici a Cesena 1di3, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28)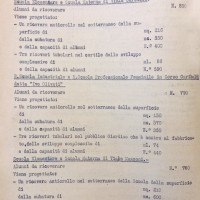 Elenco dei ricoveri scolastici a Cesena 2di3, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28)
Elenco dei ricoveri scolastici a Cesena 2di3, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28)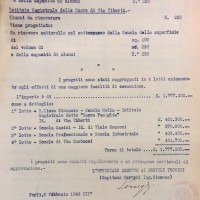 Elenco dei ricoveri scolastici a Cesena 3di3, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28)
Elenco dei ricoveri scolastici a Cesena 3di3, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28)
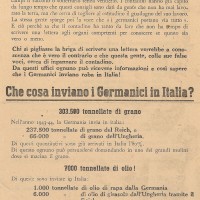 La propaganda fascista tenta a più riprese di negare che i nazisti compiono razzie e accaparrano le risorse alimentari. Questo manifestino respinge le accuse ai tedeschi, attribuendo loro un sostegno materiale alla vita quotidiana degli italiani che è molto distante dalla realtà della guerra.
La propaganda fascista tenta a più riprese di negare che i nazisti compiono razzie e accaparrano le risorse alimentari. Questo manifestino respinge le accuse ai tedeschi, attribuendo loro un sostegno materiale alla vita quotidiana degli italiani che è molto distante dalla realtà della guerra.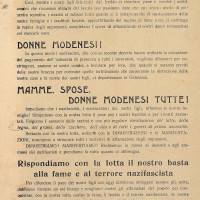 Questo manifestino, firmato dai Gruppi di Difesa della Donna, denuncia le razzie e le spoliazioni alimentari dei tedeschi, esortando le donne a ribellarsi nei loro confronti.
Questo manifestino, firmato dai Gruppi di Difesa della Donna, denuncia le razzie e le spoliazioni alimentari dei tedeschi, esortando le donne a ribellarsi nei loro confronti.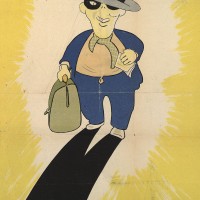 I fascisti stampano manifesti per mettere alla berlina i protagonisti del mercato nero. In realtà, tuttavia, la propaganda cerca di nascondere uno tra i più evidenti fallimenti del regime. Già all’inizio della Seconda guerra mondiale chi può si rifornisce al mercato nero, poiché la tessera annonaria non copre il fabbisogno di cibo. Dopo l’occupazione nazista il problema si aggrava: le contrattazioni sommerse diventano spesso l’unico modo di procurarsi il necessario per vivere.
I fascisti stampano manifesti per mettere alla berlina i protagonisti del mercato nero. In realtà, tuttavia, la propaganda cerca di nascondere uno tra i più evidenti fallimenti del regime. Già all’inizio della Seconda guerra mondiale chi può si rifornisce al mercato nero, poiché la tessera annonaria non copre il fabbisogno di cibo. Dopo l’occupazione nazista il problema si aggrava: le contrattazioni sommerse diventano spesso l’unico modo di procurarsi il necessario per vivere.
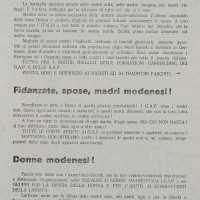 Nella tarda estate del 1944 le organizzazioni della Resistenza modenese esortano le donne e i civili a collaborare quanto più possibile con i partigiani, lasciando “tutte le porte aperte” ai gappisti.
Nella tarda estate del 1944 le organizzazioni della Resistenza modenese esortano le donne e i civili a collaborare quanto più possibile con i partigiani, lasciando “tutte le porte aperte” ai gappisti.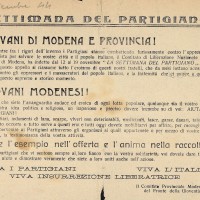 Fra il 12 e il 19 novembre 1944 le organizzazioni della Resistenza modenese indicono la “Settimana del partigiano”. I militanti del Fronte della Gioventù vengono incitati a mobilitarsi per raccogliere quanti più viveri, indumenti e mezzi di sostegno possibili per i combattenti.
Fra il 12 e il 19 novembre 1944 le organizzazioni della Resistenza modenese indicono la “Settimana del partigiano”. I militanti del Fronte della Gioventù vengono incitati a mobilitarsi per raccogliere quanti più viveri, indumenti e mezzi di sostegno possibili per i combattenti.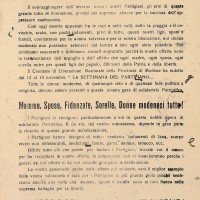 Fra il 12 e il 19 novembre 1944 le organizzazioni della Resistenza modenese indicono la “Settimana del partigiano”. I Gruppi di Difesa della Donna invitano le militanti a mobilitarsi per raccogliere quanti più viveri, indumenti e mezzi di sostegno possibili per i combattenti.
Fra il 12 e il 19 novembre 1944 le organizzazioni della Resistenza modenese indicono la “Settimana del partigiano”. I Gruppi di Difesa della Donna invitano le militanti a mobilitarsi per raccogliere quanti più viveri, indumenti e mezzi di sostegno possibili per i combattenti.
 Aeroporto di Forlì
Aeroporto di Forlì Aeroporto di Forlì, 1936
Aeroporto di Forlì, 1936 Cimitero di Forlì, Monumento a ricordo delle vittime uccise all'aeroporto di Forlì nel settembre 1944
Cimitero di Forlì, Monumento a ricordo delle vittime uccise all'aeroporto di Forlì nel settembre 1944 Cimitero di Forlì, aprile 2007, Inaugurazione del nuovo monumento dedicato alle vittime ebree della strage dell'aeroporto
Cimitero di Forlì, aprile 2007, Inaugurazione del nuovo monumento dedicato alle vittime ebree della strage dell'aeroporto Il primo monumento, in granaglia, a ricordo delle vittime della strage dell'aeroporto collocato nel 1946 in via Seganti
Il primo monumento, in granaglia, a ricordo delle vittime della strage dell'aeroporto collocato nel 1946 in via Seganti
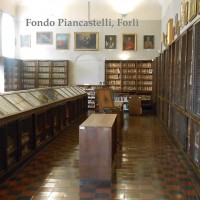 Biblioteca comunale di Forlì, Raccolte Piancastelli
Biblioteca comunale di Forlì, Raccolte Piancastelli Contratto matrimoniale (ketubà), Lugo, 1740 (Biblioteca comunale A. Saffi di Forlì, Collezione Piancastelli, Sezione stampe e disegni, cassetto 7)
Contratto matrimoniale (ketubà), Lugo, 1740 (Biblioteca comunale A. Saffi di Forlì, Collezione Piancastelli, Sezione stampe e disegni, cassetto 7) Palazzo del Merenda
Palazzo del Merenda Palazzo del Merenda (Foto F. Blaco)
Palazzo del Merenda (Foto F. Blaco) Palazzo del Merenda, Modellino
Palazzo del Merenda, Modellino Palazzo del Merenda, scalone monumentale di Raimondo Compagnoni
Palazzo del Merenda, scalone monumentale di Raimondo Compagnoni
 Palazzo Serughi, sede della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Palazzo Serughi, sede della Camera di Commercio di Forlì-Cesena Palazzo Serughi, interno
Palazzo Serughi, interno Palazzo Serughi oggi
Palazzo Serughi oggi Camera di Commercio di Forlì-Cesena, ingresso
Camera di Commercio di Forlì-Cesena, ingresso Palazzo Serughi
Palazzo Serughi Palazzo Serughi, sede Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Palazzo Serughi, sede Camera di Commercio di Forlì-Cesena Palazzo Serughi, vista da Piazza Saffi
Palazzo Serughi, vista da Piazza Saffi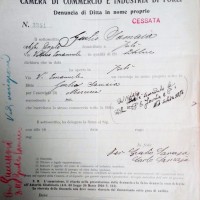 Registro ditte 1911-1925,Giulio Samaia (CCIAA)
Registro ditte 1911-1925,Giulio Samaia (CCIAA) Registro ditte 1911-1925, Archivio storico della Camera di Commercio di Forlì
Registro ditte 1911-1925, Archivio storico della Camera di Commercio di Forlì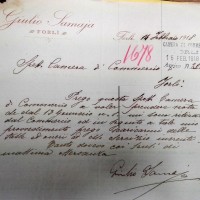 Registro ditte 1911-1925, Cessazione attività Giulio Samaia (CCIAA)
Registro ditte 1911-1925, Cessazione attività Giulio Samaia (CCIAA)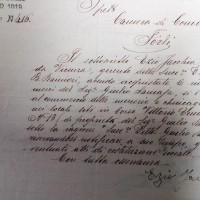 Registro ditte 1911-1925, Ezio Jacchia da Vicenza (CCIAA)
Registro ditte 1911-1925, Ezio Jacchia da Vicenza (CCIAA)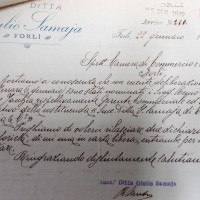 Registro ditte 1911-1925, Remo Jacchia (CCIAA)
Registro ditte 1911-1925, Remo Jacchia (CCIAA) Registro ditte 1911-1925, Sabatino Del Vecchio (CCIAA)
Registro ditte 1911-1925, Sabatino Del Vecchio (CCIAA)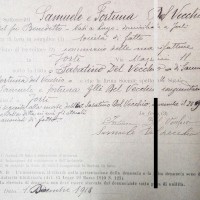 Registro ditte 1911-1925, Samuele e Fortuna Del Vecchio (CCIAA)
Registro ditte 1911-1925, Samuele e Fortuna Del Vecchio (CCIAA) Registro ditte 1911-1925, Parassiani & Guardigli (CCIAA)
Registro ditte 1911-1925, Parassiani & Guardigli (CCIAA) Regitro ditte1911-1925, Parassiani - Guardigli (CCIAA)
Regitro ditte1911-1925, Parassiani - Guardigli (CCIAA)
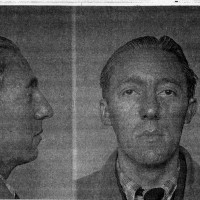 Alfred Lewin (fucilato il 5 settembre 1944)
Alfred Lewin (fucilato il 5 settembre 1944)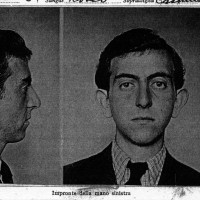 Arthur Amsterdam (fucilato il 5 settembre 1944)
Arthur Amsterdam (fucilato il 5 settembre 1944)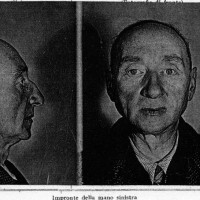 Carl Paecht (fucilato il 5 settembre 1944)
Carl Paecht (fucilato il 5 settembre 1944)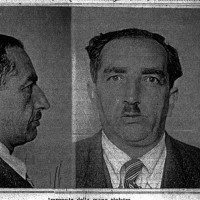 Giorgio Gottesmann (fucilato il 5 settembre 1944)
Giorgio Gottesmann (fucilato il 5 settembre 1944)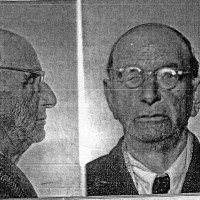 Israel Goldberg (fucilato il 5 settembre 1944)
Israel Goldberg (fucilato il 5 settembre 1944)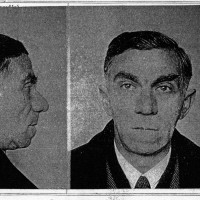 Joseph Timan (fucilato il 5 settembre 1944)
Joseph Timan (fucilato il 5 settembre 1944)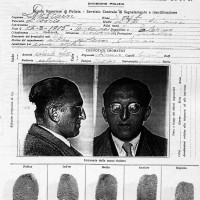 Joseph Lowestein (fucilato il 5 settembre 1944)
Joseph Lowestein (fucilato il 5 settembre 1944) Le "casermette" di Via Roma
Le "casermette" di Via Roma
 Duomo (Biblioteca comunale di Forlì, Collezione Piancastelli, Cartoline)
Duomo (Biblioteca comunale di Forlì, Collezione Piancastelli, Cartoline) Duomo (Biblioteca comunale di Forlì, Collezione Piancastelli, cartoline) (1)
Duomo (Biblioteca comunale di Forlì, Collezione Piancastelli, cartoline) (1) Duomo di Forli, Interno
Duomo di Forli, Interno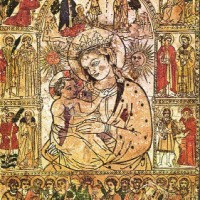 Duomo di Forlì, Madonna del Fuoco
Duomo di Forlì, Madonna del Fuoco Duomo di Forlì, dettaglio dell'altare maggiore
Duomo di Forlì, dettaglio dell'altare maggiore Duomo di Forlì, dipinto di San Sebastiano
Duomo di Forlì, dipinto di San Sebastiano Duomodi Forlì, Crocifisso
Duomodi Forlì, Crocifisso Duomo di Forlì
Duomo di Forlì Duomo di Forlì
Duomo di Forlì Duomo di Forlì
Duomo di Forlì Duomo di Forlì
Duomo di Forlì Duomo di Forlì
Duomo di Forlì Duomo di Forlì
Duomo di Forlì Duomo di Forlì
Duomo di Forlì
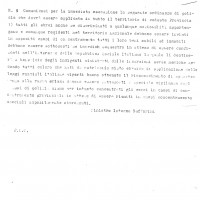 Ordine di istituzione dei campi di concentramento provinciali (ASFo)
Ordine di istituzione dei campi di concentramento provinciali (ASFo)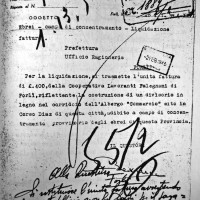 Fattura per la costruzione di un divisorio nell'Albergo Commercio, campo di concentramento provinciale, 28.01.1944 (ASFo)
Fattura per la costruzione di un divisorio nell'Albergo Commercio, campo di concentramento provinciale, 28.01.1944 (ASFo)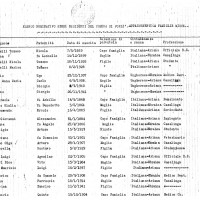 Elenco nominativo ebrei residenti nel Comune di Forlì appartenenti a famiglie miste,1943 - 1 parte (ASFo) (1 parte)
Elenco nominativo ebrei residenti nel Comune di Forlì appartenenti a famiglie miste,1943 - 1 parte (ASFo) (1 parte)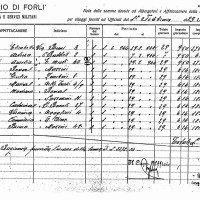 Elenco soldati alloggiati presso l'Albergo Commercio, 1944 (ASFo)
Elenco soldati alloggiati presso l'Albergo Commercio, 1944 (ASFo)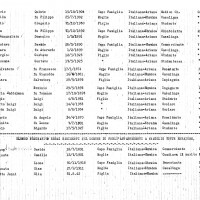 Elenco nominativo ebrei residenti nel Comune di Forlì appartenenti a famiglie miste e famiglie tutte ebraiche, 1943 - 2 parte (ASFo)
Elenco nominativo ebrei residenti nel Comune di Forlì appartenenti a famiglie miste e famiglie tutte ebraiche, 1943 - 2 parte (ASFo) Albergo Commercio oggi
Albergo Commercio oggi Albergo Commercio
Albergo Commercio Lapide commemorativa presso Albergo Commercio
Lapide commemorativa presso Albergo Commercio Lapide commemorativa
Lapide commemorativa
 Ex Brefotrofio di Viale Salinatore
Ex Brefotrofio di Viale Salinatore Ex Brefotrofio, oggi
Ex Brefotrofio, oggi Ex Brefotrofio, oggi
Ex Brefotrofio, oggi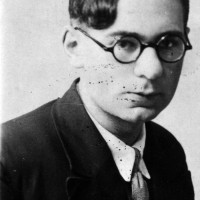 Karl Schutz, comandante del distaccamento del Sicherheitsdienst di Forlì. A Roma, in via Tasso, era stato il vice di Herbert Kappler
Karl Schutz, comandante del distaccamento del Sicherheitsdienst di Forlì. A Roma, in via Tasso, era stato il vice di Herbert Kappler Piano interrato dell'Ex Brefotrofio, interno, finestra di una delle celle
Piano interrato dell'Ex Brefotrofio, interno, finestra di una delle celle Piano interrato dell'Ex Brefotrofio, interno, il corridoio su cui si affacciavano le celle
Piano interrato dell'Ex Brefotrofio, interno, il corridoio su cui si affacciavano le celle Piano interrato dell'Ex Brefotrofio, interno, una delle ex-celle
Piano interrato dell'Ex Brefotrofio, interno, una delle ex-celle Piano interrato dell'edificio, le ex-celle
Piano interrato dell'edificio, le ex-celle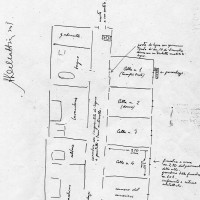 Piantina del carcere di Viale Salinatore disegnata dalla magistratura nel 1945 su indicazioni dell'avvocato Oreste Casaglia, detenuto nella cella n. 1 nell'agosto 1944
Piantina del carcere di Viale Salinatore disegnata dalla magistratura nel 1945 su indicazioni dell'avvocato Oreste Casaglia, detenuto nella cella n. 1 nell'agosto 1944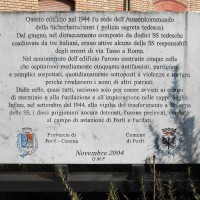 Targa commemorativa
Targa commemorativa Via Oreste Casaglia, avvocato, membro della Resistenza, fu incarcerato nell'agosto 1944. Ha raccontato in un diario le torture a cui erano sottoposti i prigionieri dell'Ex Brefotrofio
Via Oreste Casaglia, avvocato, membro della Resistenza, fu incarcerato nell'agosto 1944. Ha raccontato in un diario le torture a cui erano sottoposti i prigionieri dell'Ex Brefotrofio
 Cessazione attività di Giuseppe Saralvo, 1918 (CCIAA)
Cessazione attività di Giuseppe Saralvo, 1918 (CCIAA)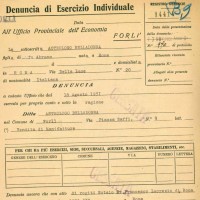 Ditta Astrologo Belladonna, 1931 (CCIAA)
Ditta Astrologo Belladonna, 1931 (CCIAA)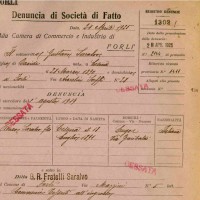 Ditta G. R Fratelli Saralvo (CCIAA)
Ditta G. R Fratelli Saralvo (CCIAA)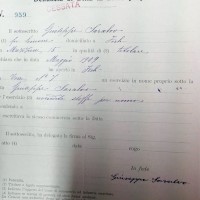 Giuseppe Saralvo, Rivendita stoffe per uomo via delle Torri (CCIAA)
Giuseppe Saralvo, Rivendita stoffe per uomo via delle Torri (CCIAA)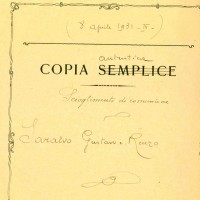 Saralvo Gustavo e Renzo, Scioglimento di comunione, 1931 (CCIAA)
Saralvo Gustavo e Renzo, Scioglimento di comunione, 1931 (CCIAA)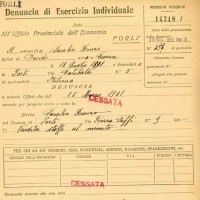 Saralvo Renzo, Vendita stoffe al minuto, Piazza Saffi 9, 1931 (CCIAA)
Saralvo Renzo, Vendita stoffe al minuto, Piazza Saffi 9, 1931 (CCIAA)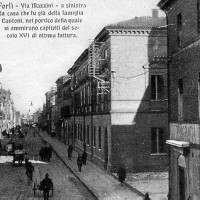 Via Mazzini (Biblioteca A. Saffi di Forlì, Raccolte Piancastelli)
Via Mazzini (Biblioteca A. Saffi di Forlì, Raccolte Piancastelli)
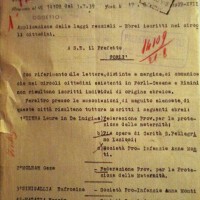 Cancellazione del socio Geza Molnar dalla Federazione provinciale per la protezione della maternità (ASFo)
Cancellazione del socio Geza Molnar dalla Federazione provinciale per la protezione della maternità (ASFo)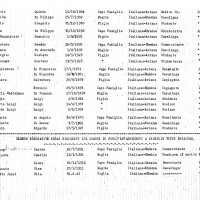 Elenco nominativo ebrei residenti nel Comune di Forlì - 2 parte (ASFo)
Elenco nominativo ebrei residenti nel Comune di Forlì - 2 parte (ASFo)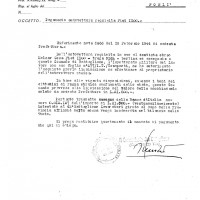 Requisizione Fiat 1100 di proprietà di Geza Molnar (ASFo)
Requisizione Fiat 1100 di proprietà di Geza Molnar (ASFo)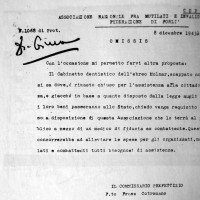 Richiesta requisizione del Gabinetto dentistico di Geza Molnar (ASFo)
Richiesta requisizione del Gabinetto dentistico di Geza Molnar (ASFo) Via Lazzarini
Via Lazzarini Via Lazzarini, oggi
Via Lazzarini, oggi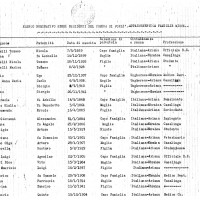 Elenco nominativo ebrei residenti nel Comune di Forlì - 1 parte (ASFo)
Elenco nominativo ebrei residenti nel Comune di Forlì - 1 parte (ASFo)
 Palazzo comunale, oggi
Palazzo comunale, oggi Il balcone della Prefettura (Archivio Zoli)
Il balcone della Prefettura (Archivio Zoli) Facciata del Palazzo comunale (coll. privata)
Facciata del Palazzo comunale (coll. privata)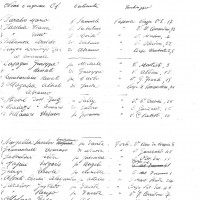 Censimento ebrei del 22.08. 1938 - 1 parte (ASFo)
Censimento ebrei del 22.08. 1938 - 1 parte (ASFo)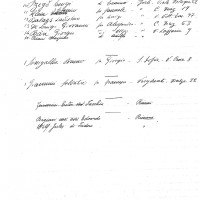 Censimento ebrei del 22.08. 1938 - 2 parte (ASFo)
Censimento ebrei del 22.08. 1938 - 2 parte (ASFo)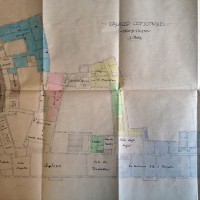 Piantina interna del primo piano del Comune di Forli, la Divisione III occupava l'ala sinistra, 1943 (ASFo)
Piantina interna del primo piano del Comune di Forli, la Divisione III occupava l'ala sinistra, 1943 (ASFo)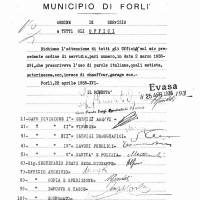 I servizi demografici affidati alla Divisione III (ASFo)
I servizi demografici affidati alla Divisione III (ASFo)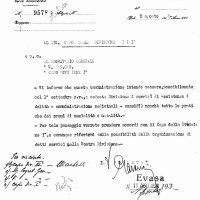 Ampliamento competenze Divisione III (ASFo)
Ampliamento competenze Divisione III (ASFo)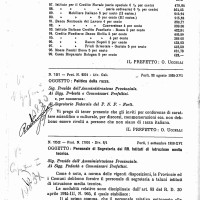 Divieto di partecipazione a conferenze per gli ebrei (ASFo)
Divieto di partecipazione a conferenze per gli ebrei (ASFo)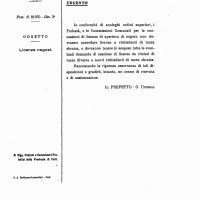 Divieto di accordare licenze negozi a ebrei (ASFo)
Divieto di accordare licenze negozi a ebrei (ASFo)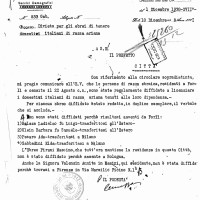 Divieto di tenere domestici ariani (ASFo)
Divieto di tenere domestici ariani (ASFo)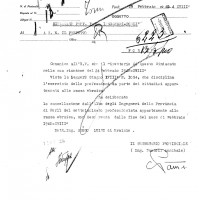 Cancellazione albo ingegneri Szego Luigi (ASFo)
Cancellazione albo ingegneri Szego Luigi (ASFo)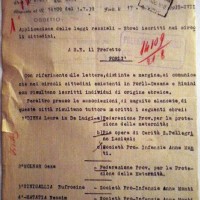 Cancellazione ebrei dalle opere pie e associazioni (ASFo)
Cancellazione ebrei dalle opere pie e associazioni (ASFo)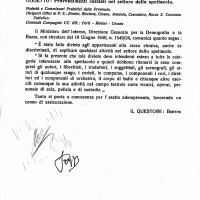 Divieto di svolgere attività nel settore dello spettacolo (ASFo)
Divieto di svolgere attività nel settore dello spettacolo (ASFo)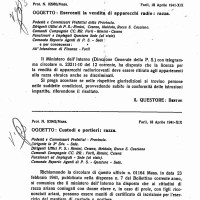 Divieto di vendita apparecchi radio (ASFo)
Divieto di vendita apparecchi radio (ASFo)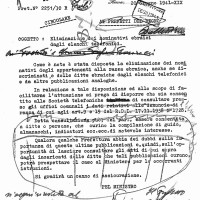 Eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici (ASFo)
Eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici (ASFo)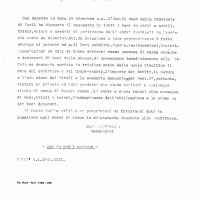 Sequestro beni degli ebrei (ASFo)
Sequestro beni degli ebrei (ASFo)
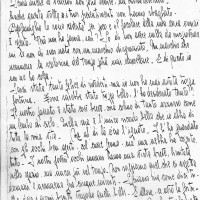 Commuovente lettera di Camelia Matatia scritta poco prima di essere arrestata, nel dicembre 1943 (Roberto Matatia)
Commuovente lettera di Camelia Matatia scritta poco prima di essere arrestata, nel dicembre 1943 (Roberto Matatia)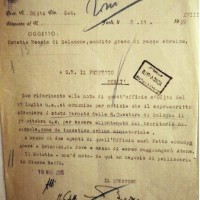 All’attuale civico n. 3 di Piazza Saffi si trovava la “Pellicceria Matatia di Nissim e Leone Matatia” originari di Corfù e giunti in Italia nel 1920
All’attuale civico n. 3 di Piazza Saffi si trovava la “Pellicceria Matatia di Nissim e Leone Matatia” originari di Corfù e giunti in Italia nel 1920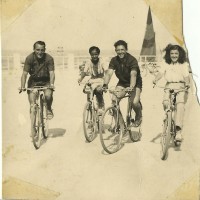 Estate 1940, Riccione. Camelia Matatia (a destra), il fratello Beniamino e due amici (foto di Roberto Matatia)
Estate 1940, Riccione. Camelia Matatia (a destra), il fratello Beniamino e due amici (foto di Roberto Matatia)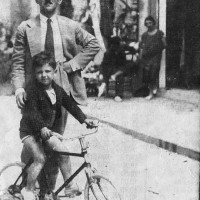 Nissim Matatia con il figlio Roberto (foto di Roberto Matatia)
Nissim Matatia con il figlio Roberto (foto di Roberto Matatia)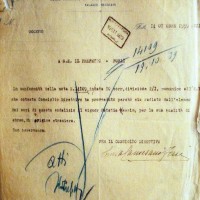 Radiazione di Nissim Matatia dalla Opera Pia Pro Infanzia "Anna Monti" (ASFo)
Radiazione di Nissim Matatia dalla Opera Pia Pro Infanzia "Anna Monti" (ASFo) Piazza Saffi n. 3, portone originale in legno della Pellicceria Matatia
Piazza Saffi n. 3, portone originale in legno della Pellicceria Matatia Porticato di Piazza Saffi, sulla sinistra il portone in legno della Pelliceria Matatia
Porticato di Piazza Saffi, sulla sinistra il portone in legno della Pelliceria Matatia
 Targa Teatro comunale
Targa Teatro comunale Piazza XC Pacifici, Teatro ( Collezione Piancastelli, Biblioteca A. Saffi, Forlì)
Piazza XC Pacifici, Teatro ( Collezione Piancastelli, Biblioteca A. Saffi, Forlì) Targa Torre civica
Targa Torre civica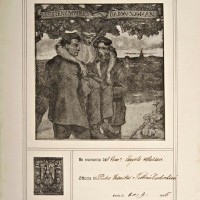 Targa commemorativa di Angelo Masini con offerta devoluta a Dam una man
Targa commemorativa di Angelo Masini con offerta devoluta a Dam una man Targa soci fondatori Dam una man
Targa soci fondatori Dam una man Targhe soci Dam una man
Targhe soci Dam una man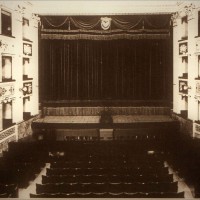 Teatro comunale, palcoscenico (Biblioteca A. Saffi, Arch. Fotografico)
Teatro comunale, palcoscenico (Biblioteca A. Saffi, Arch. Fotografico) Torre Civica (Bibl. A. Saffi Arch. Fot. 1945-50)
Torre Civica (Bibl. A. Saffi Arch. Fot. 1945-50) Torre civica (fonte Internet)
Torre civica (fonte Internet) Torre dell'orologio
Torre dell'orologio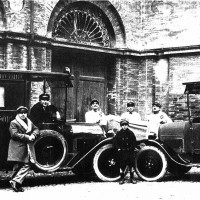 Assistenza pubblica di Forlì (Fondo Piancastelli, Biblioteca comunale A. Saffi, Forlì)
Assistenza pubblica di Forlì (Fondo Piancastelli, Biblioteca comunale A. Saffi, Forlì) Assistenza pubblica di Forlì (Fondo Piancastelli, Biblioteca A. Saffi, Forlì)
Assistenza pubblica di Forlì (Fondo Piancastelli, Biblioteca A. Saffi, Forlì)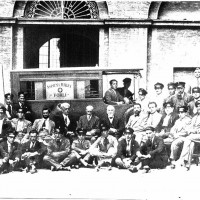 Assistenza pubblica di Forlì (Fondo Piancastelli, Biblioteca A. Saffi, Forlì)
Assistenza pubblica di Forlì (Fondo Piancastelli, Biblioteca A. Saffi, Forlì) Assistenza pubblica di Forlì (Fondo Piancastelli, Biblioteca A. Saffi, Forlì)
Assistenza pubblica di Forlì (Fondo Piancastelli, Biblioteca A. Saffi, Forlì)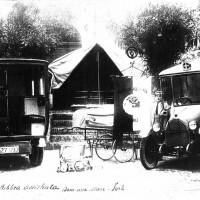 Assistenza pubblica di Forlì (Fondo Piancastelli, Biblioteca comunale A. Saffi, Forlì)
Assistenza pubblica di Forlì (Fondo Piancastelli, Biblioteca comunale A. Saffi, Forlì)
 Foro della Diavolessa, primi anni del '900 (www.facebook.com/Cesena di una volta - 18/09/2017)
Foro della Diavolessa, primi anni del '900 (www.facebook.com/Cesena di una volta - 18/09/2017) Foro della Diavolessa oggi (foto dell'autore)
Foro della Diavolessa oggi (foto dell'autore) Esempio di paraschegge delle aperture di un tunnel urbano (G. STELLINGWERFF, Note sui ricoveri antiaerei di fortuna, Industrie Grafiche Italiane stucchi, Milano, 1940, p. 10, in AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 48)
Esempio di paraschegge delle aperture di un tunnel urbano (G. STELLINGWERFF, Note sui ricoveri antiaerei di fortuna, Industrie Grafiche Italiane stucchi, Milano, 1940, p. 10, in AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 48)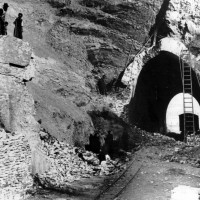 Foro della Diavolessa dopo i bombardamenti, primavera 1945 (BCM Fondo Bacchi, FBP 556)
Foro della Diavolessa dopo i bombardamenti, primavera 1945 (BCM Fondo Bacchi, FBP 556)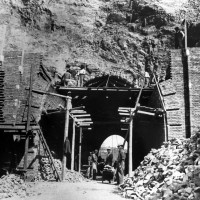 Lavori per la sistemazione del foro della Diavolessa, primavera 1945 (BCM Fondo Bacchi, FBP 557)
Lavori per la sistemazione del foro della Diavolessa, primavera 1945 (BCM Fondo Bacchi, FBP 557) Segni dei proiettili sull'ingresso del foro della Diavolessa oggi (foto dell’autore)
Segni dei proiettili sull'ingresso del foro della Diavolessa oggi (foto dell’autore)
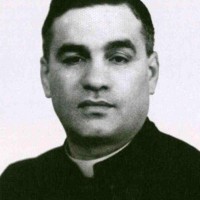 Don Pietro Burchi
Don Pietro Burchi Menotti Primo Targhini
Menotti Primo Targhini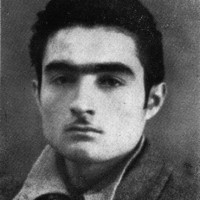 Renato Medri
Renato Medri Chiesa di Gattolino, anni 50
Chiesa di Gattolino, anni 50 La chiesa di Gattolino oggi, fronte
La chiesa di Gattolino oggi, fronte La chiesa di Gattolino oggi, retro
La chiesa di Gattolino oggi, retro Cippo in ricordo di Medri e Targhini, via Renato Medri
Cippo in ricordo di Medri e Targhini, via Renato Medri Gente attorno al cippo di Medri e Targhini in occasione della Festa del Partigiano, 17 aprile 2016
Gente attorno al cippo di Medri e Targhini in occasione della Festa del Partigiano, 17 aprile 2016 Il cippo che ricorda tutte le vittime di Gattolino, sullo sfondo la Chiesa, oggi
Il cippo che ricorda tutte le vittime di Gattolino, sullo sfondo la Chiesa, oggi Il cippo che ricorda tutte le vittime di Gattolino, oggi
Il cippo che ricorda tutte le vittime di Gattolino, oggi Il Diario di don Pietro Burchi
Il Diario di don Pietro Burchi
 Una veduta del territorio di Gemmano.
Una veduta del territorio di Gemmano. Un carro Sherman del 44° Recce colpito dal caporale Weber sotto le mura di gemmano. Sullo sfondo la Valle del Conca.
Un carro Sherman del 44° Recce colpito dal caporale Weber sotto le mura di gemmano. Sullo sfondo la Valle del Conca.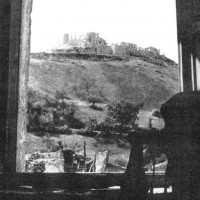 Gemmano, la nuova Cassino.
Gemmano, la nuova Cassino. Da Montefiore mortai sparano su Gemmano.
Da Montefiore mortai sparano su Gemmano. Le rovine dells chiesa di Gemmano.
Le rovine dells chiesa di Gemmano. Mitragliatrici del 6° Cheshire sparano su Gemmano dal Santuario della Madonna di Bonora.
Mitragliatrici del 6° Cheshire sparano su Gemmano dal Santuario della Madonna di Bonora. Gemmano, il Museo Multimediale Polifunzionale, realizzato in collaborazione con il centro Te.M.P.L.A. del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di Bologna.
Gemmano, il Museo Multimediale Polifunzionale, realizzato in collaborazione con il centro Te.M.P.L.A. del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di Bologna.
 Il muro di barricata con la porta aperta su Largo Garibaldi.
Il muro di barricata con la porta aperta su Largo Garibaldi. Cittadini seguono l'evolversi dei combattimenti dietro una trincea in Via Emilia.
Cittadini seguono l'evolversi dei combattimenti dietro una trincea in Via Emilia. Combattimenti in Largo Garibaldi, di fronte all'albergo Roma sede di comando tedesco.
Combattimenti in Largo Garibaldi, di fronte all'albergo Roma sede di comando tedesco. L'arrivo delle truppe americane a Modena.
L'arrivo delle truppe americane a Modena. Soldati tedeschi fatti prigionieri in zona Largo Garibaldi.
Soldati tedeschi fatti prigionieri in zona Largo Garibaldi.
 Alcuni dei partigiani della 60ª brigata d’assalto Garibaldi caduti ai Guselli nell'imboscata del dicembre 1944. Al centro, in piedi, il comandante Giacomo Callegari.
Alcuni dei partigiani della 60ª brigata d’assalto Garibaldi caduti ai Guselli nell'imboscata del dicembre 1944. Al centro, in piedi, il comandante Giacomo Callegari. Luisa Calzetta, la “Tigrona”, militante in diverse formazioni del piacentino. Nata a New York nel 1919, maestra. Le venne conferita la medaglia d’argento al valor militare alla memoria, con la seguente motivazione: “Indomita partigiana, nel nobile tentativo di portare al sicuro un componente della propria formazione che era rimasto ferito in combattimento, veniva circondata da un folto numero di nemici. Impugnata la pistola, si difendeva con eroica fermezza fin tanto che, sopraffatta, veniva trucidata. Fulgido esempio di abnegazione e di attaccamento alla Causa”.
Luisa Calzetta, la “Tigrona”, militante in diverse formazioni del piacentino. Nata a New York nel 1919, maestra. Le venne conferita la medaglia d’argento al valor militare alla memoria, con la seguente motivazione: “Indomita partigiana, nel nobile tentativo di portare al sicuro un componente della propria formazione che era rimasto ferito in combattimento, veniva circondata da un folto numero di nemici. Impugnata la pistola, si difendeva con eroica fermezza fin tanto che, sopraffatta, veniva trucidata. Fulgido esempio di abnegazione e di attaccamento alla Causa”.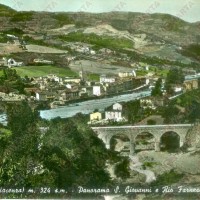 Bettola e Rio Farnese. La mattina del 28 gennaio 1945 i tedeschi prelevano dalla scuola di Bettola 21 partigiani scelti tra i 40 catturati nel corso del rastrellamento invernale effettuato dalla divisione Turkestan nella Val Nure. 21 scelti a caso vengono condotti sul greto del torrente Rio Farnese e sono uccisi con un colpo di pistola alla nuca da un sottufficiale. Non ci sono giustificazioni per l’eccidio, non è stata una rappresaglia, l’unica spiegazione data è stata la causa della mancanza di spazio sull’automezzo che doveva provvedere al trasporto dei prigionieri. Di questi 21 partigiani ne sono stati identificati solo dodici gli altri sono rimasti senza nome.
Bettola e Rio Farnese. La mattina del 28 gennaio 1945 i tedeschi prelevano dalla scuola di Bettola 21 partigiani scelti tra i 40 catturati nel corso del rastrellamento invernale effettuato dalla divisione Turkestan nella Val Nure. 21 scelti a caso vengono condotti sul greto del torrente Rio Farnese e sono uccisi con un colpo di pistola alla nuca da un sottufficiale. Non ci sono giustificazioni per l’eccidio, non è stata una rappresaglia, l’unica spiegazione data è stata la causa della mancanza di spazio sull’automezzo che doveva provvedere al trasporto dei prigionieri. Di questi 21 partigiani ne sono stati identificati solo dodici gli altri sono rimasti senza nome. Il Museo della Resistenza di Sperongia di Morfasso: l'esterno.
Il Museo della Resistenza di Sperongia di Morfasso: l'esterno. Il Museo della Resistenza di Sperongia di Morfasso: alcuni cimeli esposti.
Il Museo della Resistenza di Sperongia di Morfasso: alcuni cimeli esposti. Il Museo della Resistenza di Sperongia di Morfasso: alcuni cimeli esposti.
Il Museo della Resistenza di Sperongia di Morfasso: alcuni cimeli esposti.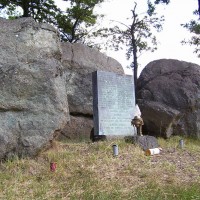 Lapide al passo dei Guselli di Morfasso.
Lapide al passo dei Guselli di Morfasso.
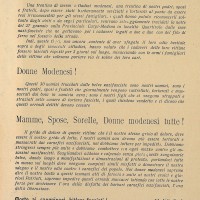 La minaccia della rappresaglia è un’arma potente nei confronti dei civili. L’organizzazione della Resistenza si adopera dunque per incitarli a non rassegnarsi alle violenze: ribellandosi contro le ingiustizie, potranno a loro volta intimorire tedeschi e fascisti, rendendoli meno inclini alle vendette e alle stragi.
La minaccia della rappresaglia è un’arma potente nei confronti dei civili. L’organizzazione della Resistenza si adopera dunque per incitarli a non rassegnarsi alle violenze: ribellandosi contro le ingiustizie, potranno a loro volta intimorire tedeschi e fascisti, rendendoli meno inclini alle vendette e alle stragi.
 L'Isola degli Spinaroni oggi.
L'Isola degli Spinaroni oggi. L'Isola degli Spinaroni oggi.
L'Isola degli Spinaroni oggi. L'Isola degli Spinaroni oggi.
L'Isola degli Spinaroni oggi. L'Isola degli Spinaroni oggi.
L'Isola degli Spinaroni oggi. Scolaresche in visita all’isola sul nuovo battello ecologico.
Scolaresche in visita all’isola sul nuovo battello ecologico. Vegetazione dell’isola.
Vegetazione dell’isola. Vegetazione dell’isola.
Vegetazione dell’isola. Estate 1944, partigiani del distaccamento Terzo Lori sull’isola.
Estate 1944, partigiani del distaccamento Terzo Lori sull’isola.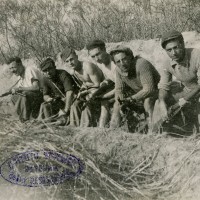 Estate 1944, partigiani del distaccamento Terzo Lori sull’isola.
Estate 1944, partigiani del distaccamento Terzo Lori sull’isola. La lapide che ricorda le gesta partigiane.
La lapide che ricorda le gesta partigiane. Vecchio approdo all’isola.
Vecchio approdo all’isola. La nuova sede del centro visite con aula didattica.
La nuova sede del centro visite con aula didattica. Mappa dell'Isola degli Spinaroni.
Mappa dell'Isola degli Spinaroni.
 la centrale oggi
la centrale oggi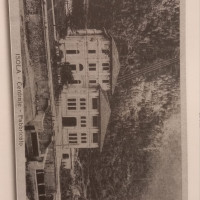 la centrale negli anni ‘40
la centrale negli anni ‘40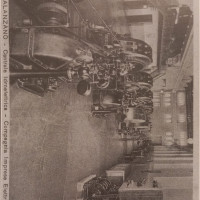 la centrale negli anni ‘40
la centrale negli anni ‘40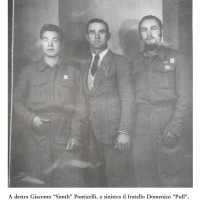 Giacomo e Domenico Ponticelli con il padre Michele
Giacomo e Domenico Ponticelli con il padre Michele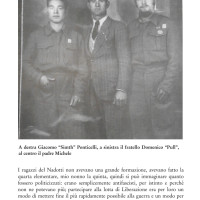 Giacomo Ponticelli nel ricordo di Leonardo Tarantini (Gazzetta di Parma)
Giacomo Ponticelli nel ricordo di Leonardo Tarantini (Gazzetta di Parma) partigiani del distaccamento Folgore
partigiani del distaccamento Folgore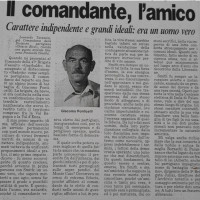 testimonianza sui partigiani del distaccamento Nadotti in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)
testimonianza sui partigiani del distaccamento Nadotti in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/) testimonianza sui partigiani del distaccamento Nadotti in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)
testimonianza sui partigiani del distaccamento Nadotti in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)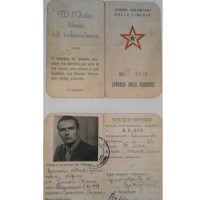 testimonianza sui partigiani del distaccamento Nadotti in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)
testimonianza sui partigiani del distaccamento Nadotti in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)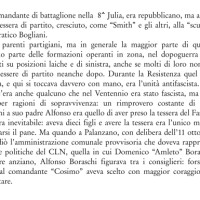 testimonianza sui partigiani del distaccamento Nadotti in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)
testimonianza sui partigiani del distaccamento Nadotti in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)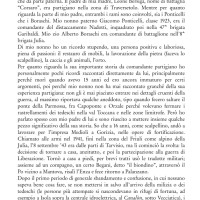 testimonianza sui partigiani del distaccamento Nadotti in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)
testimonianza sui partigiani del distaccamento Nadotti in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/) testimonianza sui partigiani del distaccamento Nadotti in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)
testimonianza sui partigiani del distaccamento Nadotti in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/) testimonianza sui partigiani del distaccamento Nadotti in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)
testimonianza sui partigiani del distaccamento Nadotti in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)
 Piazza Mazzini e la sinagoga di Modena agli inizi del Novecento.
Piazza Mazzini e la sinagoga di Modena agli inizi del Novecento.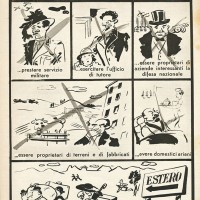 Alcuni dei divieti imposti agli ebrei italiani.
Alcuni dei divieti imposti agli ebrei italiani.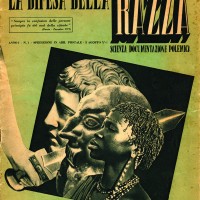 Copertina de "La Difesa della Razza", strumento di propaganda antisemita utilizzato dal regime fascista.
Copertina de "La Difesa della Razza", strumento di propaganda antisemita utilizzato dal regime fascista.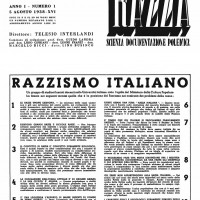 Il manifesto degli scienziati razzisti.
Il manifesto degli scienziati razzisti. Lapide esposta nella Sinagoga di Modena a ricordo degli ebrei modenesi morti durante il secondo conflitto mondiale.
Lapide esposta nella Sinagoga di Modena a ricordo degli ebrei modenesi morti durante il secondo conflitto mondiale.
 Comandanti partigiani sul balcone del Palazzo Merlato
Comandanti partigiani sul balcone del Palazzo Merlato Gli alleati in Piazza del Popolo. Dicembre 1944
Gli alleati in Piazza del Popolo. Dicembre 1944 Partigiani in Piazza del Popolo il giorno della Liberazione
Partigiani in Piazza del Popolo il giorno della Liberazione Piazza del Popolo nei primi giorni della Liberazione
Piazza del Popolo nei primi giorni della Liberazione Soldati tedeschi fatti prigionieri dai partigiani e consegnati agli alleati in Piazza del Popolo
Soldati tedeschi fatti prigionieri dai partigiani e consegnati agli alleati in Piazza del Popolo
 Centrale idroelettrica di Ligonchio
Centrale idroelettrica di Ligonchio Foto aerea storica della centrale di Ligonchio
Foto aerea storica della centrale di Ligonchio Ligonchio Passo Pradarena
Ligonchio Passo Pradarena Ligonchio Passo Pradarena
Ligonchio Passo Pradarena Ligonchio Passo Pradarena
Ligonchio Passo Pradarena Ligonchio Passo Pradarena
Ligonchio Passo Pradarena Ligonchio Presa Alta Cane Azzurro
Ligonchio Presa Alta Cane Azzurro Ligonchio Presa Alta Cane Azzurro
Ligonchio Presa Alta Cane Azzurro Targa in ricordo della battaglia per la difesa della centrale di Ligonchio
Targa in ricordo della battaglia per la difesa della centrale di Ligonchio
 20 maggio 1945_Il banchetto offerto dall'UDI il giorno della smobilitazione della 28a Brigata partigiana
20 maggio 1945_Il banchetto offerto dall'UDI il giorno della smobilitazione della 28a Brigata partigiana 20 maggio 1945_La folla in Piazza del Mercato il giorno della smobilitazione della 28a Brigata
20 maggio 1945_La folla in Piazza del Mercato il giorno della smobilitazione della 28a Brigata 20 maggio 1945_La smobilitazione della 28a Brigata Garibaldi Mario Gordini
20 maggio 1945_La smobilitazione della 28a Brigata Garibaldi Mario Gordini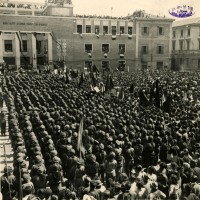 20 maggio 1945_Piazza del Mercato il giorno della smobilitazione della Brigata partigiana
20 maggio 1945_Piazza del Mercato il giorno della smobilitazione della Brigata partigiana Discorso di Zaccagnini e Boldrini il 10 dicembre 1944
Discorso di Zaccagnini e Boldrini il 10 dicembre 1944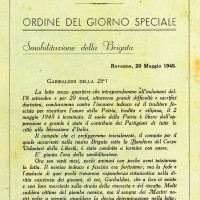 Ordine del Giorno Smobilitazione 28a Brigata Garibaldi Mario Gordini
Ordine del Giorno Smobilitazione 28a Brigata Garibaldi Mario Gordini
 Guglielmo Urbini
Guglielmo Urbini Otello Gino Fusconi
Otello Gino Fusconi Giovanni Barbanti
Giovanni Barbanti Lapide nella cripta del cimitero monumentale di Cesena oggi
Lapide nella cripta del cimitero monumentale di Cesena oggi Sede del PRI nei primi anni del Novecento poi divenuta Casa del Fascio e nel dopoguerra tornata ai repubblicani, senza data
Sede del PRI nei primi anni del Novecento poi divenuta Casa del Fascio e nel dopoguerra tornata ai repubblicani, senza data Ex sede del PRI oggi
Ex sede del PRI oggi Ex sede del PRI oggi
Ex sede del PRI oggi Foto del cippo oggi
Foto del cippo oggi Foto del cippo oggi
Foto del cippo oggi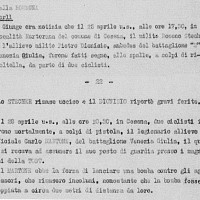 Estratto del Bollettino GNR 5 maggio 1944
Estratto del Bollettino GNR 5 maggio 1944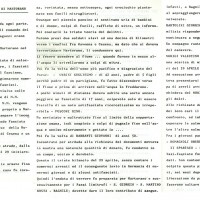 Relazione del CLN
Relazione del CLN
 L’ingresso di via Mazzini dopo un bombardamento degli Alleati
L’ingresso di via Mazzini dopo un bombardamento degli Alleati Via Mazzini oggi, dopo gli interventi urbanistici del dopoguerra
Via Mazzini oggi, dopo gli interventi urbanistici del dopoguerra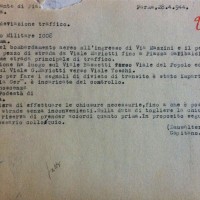 Ordinanza del comando militare germanico per la chiusura di via Mazzini e altre strade dopo i bombardamenti alleati, 28 aprile 1944
Ordinanza del comando militare germanico per la chiusura di via Mazzini e altre strade dopo i bombardamenti alleati, 28 aprile 1944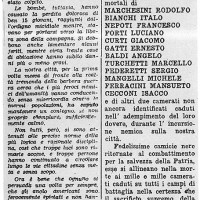 La “Gazzetta di Parma” dà notizia del primo bombardamento alleato sulla città, 24 aprile 1944
La “Gazzetta di Parma” dà notizia del primo bombardamento alleato sulla città, 24 aprile 1944 L’imbocco di via Mazzini colpita dalle bombe degli Alleati, 13 maggio 1944
L’imbocco di via Mazzini colpita dalle bombe degli Alleati, 13 maggio 1944
 Bunker nella Pineta delle Motte.
Bunker nella Pineta delle Motte. Bunker (fortino) di sbarramento.
Bunker (fortino) di sbarramento. Bunker (fortino) di sbarramento.
Bunker (fortino) di sbarramento. Bunker (fortino) di sbarramento.
Bunker (fortino) di sbarramento. I bunker della linea Gengis Khan.
I bunker della linea Gengis Khan. Monumento commemorativo dell'eccidio.
Monumento commemorativo dell'eccidio.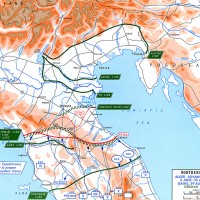 La linea difensiva Gengis Khan tra Bologna e Comacchio.
La linea difensiva Gengis Khan tra Bologna e Comacchio. Immagine storica del castello estense.
Immagine storica del castello estense. Walter Feggi.
Walter Feggi. Delizia del Verginese, torre colombaia.
Delizia del Verginese, torre colombaia. Delizia del Verginese, castello estense che durante il secondo conflitto mondiale fu occupato prima da truppe militari poi da sfollati.
Delizia del Verginese, castello estense che durante il secondo conflitto mondiale fu occupato prima da truppe militari poi da sfollati.
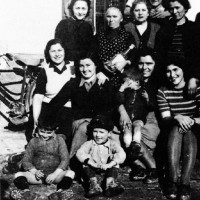 Un gruppo di confinate ebree di Belgrado assieme ad abitanti di Mezzani. Il secondo bambino seduto (da sinistra verso destra) è Josif Isakovic
Un gruppo di confinate ebree di Belgrado assieme ad abitanti di Mezzani. Il secondo bambino seduto (da sinistra verso destra) è Josif Isakovic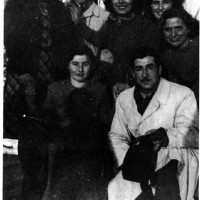 Un gruppo di confinati ebrei a Mezzani
Un gruppo di confinati ebrei a Mezzani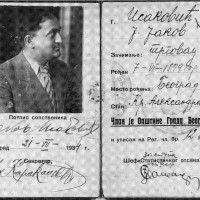 Documento di Jacob Isakovic
Documento di Jacob Isakovic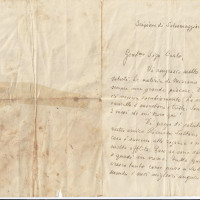 Lettera inviata dal campo di Scipione (Salsomaggiore) da Giuseppe Alcalaj, ebreo jugoslavo precedentemente internato a Mezzani.
Lettera inviata dal campo di Scipione (Salsomaggiore) da Giuseppe Alcalaj, ebreo jugoslavo precedentemente internato a Mezzani.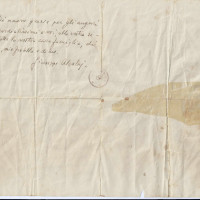 Lettera inviata dal campo di Scipione (Salsomaggiore) da Giuseppe Alcalaj, ebreo jugoslavo precedentemente internato a Mezzani.
Lettera inviata dal campo di Scipione (Salsomaggiore) da Giuseppe Alcalaj, ebreo jugoslavo precedentemente internato a Mezzani.
 Anche nella bassa modenese, aggregati all'esercito tedesco, c'erano anche soldati turcomanni, i cosiddetti 'mongoli'.
Anche nella bassa modenese, aggregati all'esercito tedesco, c'erano anche soldati turcomanni, i cosiddetti 'mongoli'.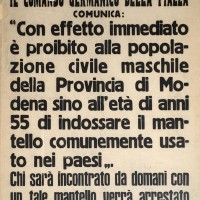 Divieto di indossare il mantello (in inverno!) per timore che così fossero nascoste armi.
Divieto di indossare il mantello (in inverno!) per timore che così fossero nascoste armi. L'originario 'cippo' a ricordo di una delle vittime della rappresaglia di Mirandola.
L'originario 'cippo' a ricordo di una delle vittime della rappresaglia di Mirandola. Una delle rappresaglie invernali che utilizza partigiani prigionieri in carcere a Modena. Bettolino di Vignola 13 febbraio 1945.
Una delle rappresaglie invernali che utilizza partigiani prigionieri in carcere a Modena. Bettolino di Vignola 13 febbraio 1945.
 25 maggio 1941: posto di ristoro allestito dai Fasci femminili per distribuire alle mondariso in transito panini e formaggini
25 maggio 1941: posto di ristoro allestito dai Fasci femminili per distribuire alle mondariso in transito panini e formaggini 10 luglio 1941 nel carpigiano: visita alle mondariso del segretario federale Franz Pagliani insieme al segretario dell'Unione fascista lavoratori agricoltura
10 luglio 1941 nel carpigiano: visita alle mondariso del segretario federale Franz Pagliani insieme al segretario dell'Unione fascista lavoratori agricoltura Luglio 1941: figlie delle mondine durante il pranzo alla Casa delle mondariso in viale Monte Kosica
Luglio 1941: figlie delle mondine durante il pranzo alla Casa delle mondariso in viale Monte Kosica 5 maggio 1941: operaie della Maserati che ascoltano un discorso del Duce alla radio. Sulla parete il suo ritratto
5 maggio 1941: operaie della Maserati che ascoltano un discorso del Duce alla radio. Sulla parete il suo ritratto Mondine al lavoro nel dopoguerra
Mondine al lavoro nel dopoguerra
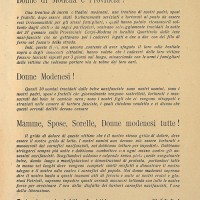 Volantino dei GDD che invita le donne a trasformare il grido di dolore per i morti in grido di lotta
Volantino dei GDD che invita le donne a trasformare il grido di dolore per i morti in grido di lotta Funerale partigiano, celebrato dopo la fine della guerra
Funerale partigiano, celebrato dopo la fine della guerra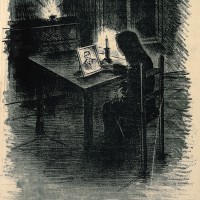 Propaganda fascista. Sul retro: «Deciditi se desideri rivedere tuo figlio invece di dover piangere dolorosamente la sua morte, senza sapere dove si trovi la sua tomba»
Propaganda fascista. Sul retro: «Deciditi se desideri rivedere tuo figlio invece di dover piangere dolorosamente la sua morte, senza sapere dove si trovi la sua tomba»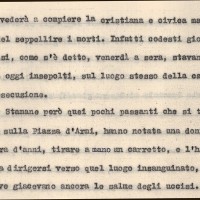 Nella giornata del 15 aprile 1945 il cronista Adamo Pedrazzi racconta il recupero del corpo di un giovane partigiano
Nella giornata del 15 aprile 1945 il cronista Adamo Pedrazzi racconta il recupero del corpo di un giovane partigiano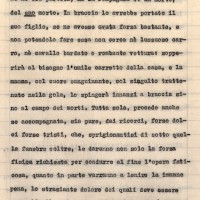 Nella giornata del 15 aprile 1945 il cronista Adamo Pedrazzi racconta il recupero del corpo di un giovane partigiano
Nella giornata del 15 aprile 1945 il cronista Adamo Pedrazzi racconta il recupero del corpo di un giovane partigiano
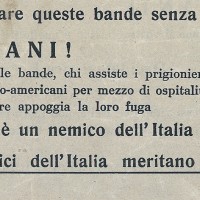 Propaganda fascista che intima alla popolazione di non sostenere né la lotta di liberazione, né i prigionieri alleati in fuga
Propaganda fascista che intima alla popolazione di non sostenere né la lotta di liberazione, né i prigionieri alleati in fuga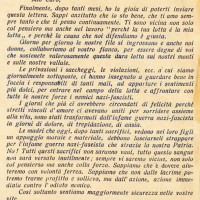 Lettera di una moglie ad un partigiano, pubblicata sul giornale dei GDD “Rinascita della donna”
Lettera di una moglie ad un partigiano, pubblicata sul giornale dei GDD “Rinascita della donna”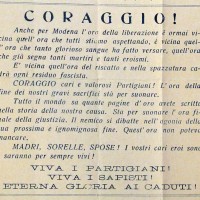 Incoraggiamento ai partigiani pubblicato nel marzo 1945 sul giornale dei GDD modenesi, “Rinascita della donna”
Incoraggiamento ai partigiani pubblicato nel marzo 1945 sul giornale dei GDD modenesi, “Rinascita della donna”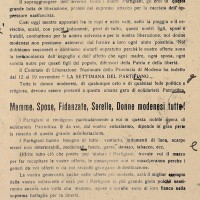 Volantino diffuso dai GDD che invita le donne a partecipare alla Settimana del partigiano, indetta dal CLN modenese dal 12 al 19 novembre 1944
Volantino diffuso dai GDD che invita le donne a partecipare alla Settimana del partigiano, indetta dal CLN modenese dal 12 al 19 novembre 1944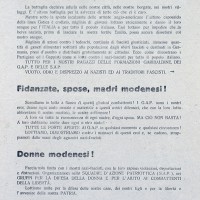 Volantino diffuso dai GDD nel momento in cui ci si illude che sia vicina la Liberazione
Volantino diffuso dai GDD nel momento in cui ci si illude che sia vicina la Liberazione
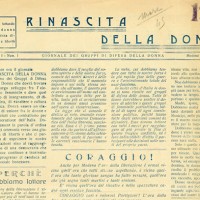 Come molte organizzazioni della Resistenza, i GDD, anche a livello locale, producono un giornale clandestino per diffondere le proprie idee
Come molte organizzazioni della Resistenza, i GDD, anche a livello locale, producono un giornale clandestino per diffondere le proprie idee “La verità” del 25 ottobre 1945 rende conto dell'attività svolta dall'Unione donne italiane, associazione nata dai GDD con la Liberazione
“La verità” del 25 ottobre 1945 rende conto dell'attività svolta dall'Unione donne italiane, associazione nata dai GDD con la Liberazione Nel marzo 1946, in occasione delle prime elezioni amministrative nell'Italia liberata, “L'Unità” sottolinea la novità del voto femminile
Nel marzo 1946, in occasione delle prime elezioni amministrative nell'Italia liberata, “L'Unità” sottolinea la novità del voto femminile Clelia Manelli, partigiana, nel 1945 entra nella Giunta popolare del CLN modenese e nel 1946 nel Consiglio comunale. Tra le fondatrici dell’UDI, fa parte del Comitato provinciale
Clelia Manelli, partigiana, nel 1945 entra nella Giunta popolare del CLN modenese e nel 1946 nel Consiglio comunale. Tra le fondatrici dell’UDI, fa parte del Comitato provinciale
 Rifugio antiaereo in viale Regina Elena, ora viale Martiri della libertà, di fronte alla Prefettura
Rifugio antiaereo in viale Regina Elena, ora viale Martiri della libertà, di fronte alla Prefettura Impiegate al lavoro nell'Ufficio annonario del Comune
Impiegate al lavoro nell'Ufficio annonario del Comune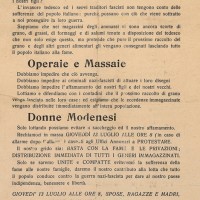 Volantino diffuso dai GDD per invitare le donne modenesi a manifestare davanti agli Uffici Annonari la mattina del 13 luglio
Volantino diffuso dai GDD per invitare le donne modenesi a manifestare davanti agli Uffici Annonari la mattina del 13 luglio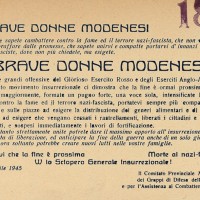 Volantino dei GDD che invita a dimostrare per la cessazione dei lavori di fortificazione, evitando così distruzioni all’arrivo degli alleati
Volantino dei GDD che invita a dimostrare per la cessazione dei lavori di fortificazione, evitando così distruzioni all’arrivo degli alleati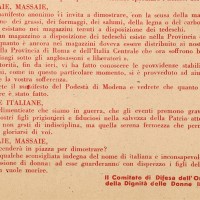 Volantino fascista che invita a non dare ascolto alla propaganda dei GDD
Volantino fascista che invita a non dare ascolto alla propaganda dei GDD
 2 aprile 1940: partenza di 327 donne e uomini da Carpi, Novi, Fiorano e Sassuolo, destinati a sopperire alla mancanza di lavoratori agricoli in Germania
2 aprile 1940: partenza di 327 donne e uomini da Carpi, Novi, Fiorano e Sassuolo, destinati a sopperire alla mancanza di lavoratori agricoli in Germania Saluto del Prefetto Boltraffio e del Segretario federale Franz Pagliani alla partenza dalla stazione di Modena il 2 aprile 1940
Saluto del Prefetto Boltraffio e del Segretario federale Franz Pagliani alla partenza dalla stazione di Modena il 2 aprile 1940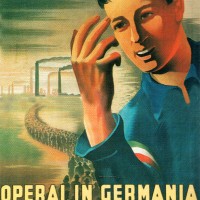 Manifesto di propaganda per il lavoro in Germania
Manifesto di propaganda per il lavoro in Germania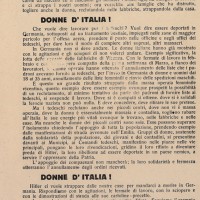 «In Germania non si deve andare» sostiene il volantino diffuso dai GDD a Modena nell'aprile del 1944 invitando a scioperare
«In Germania non si deve andare» sostiene il volantino diffuso dai GDD a Modena nell'aprile del 1944 invitando a scioperare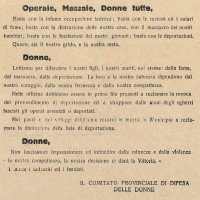 Volantino dei GDD che invita a resistere alla deportazioni. Fu diffuso in alcuni paesi della provincia modenese nell'aprile del 1944
Volantino dei GDD che invita a resistere alla deportazioni. Fu diffuso in alcuni paesi della provincia modenese nell'aprile del 1944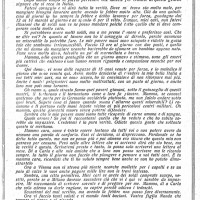 Il grido di disperazione di una deportata, diffuso nel settembre 1944 dall'organo nazionale dei GDD Noi Donne, racconta «tutta la verità» sulle condizioni di vita e lavoro in Germania
Il grido di disperazione di una deportata, diffuso nel settembre 1944 dall'organo nazionale dei GDD Noi Donne, racconta «tutta la verità» sulle condizioni di vita e lavoro in Germania
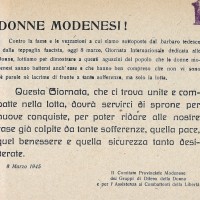 Volantino dei GDD che incita le modenesi alla lotta nella Giornata internazionale dedicata alle donne
Volantino dei GDD che incita le modenesi alla lotta nella Giornata internazionale dedicata alle donne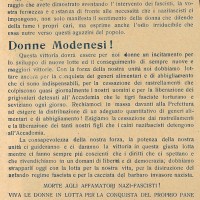 Volantino dei GDD che elogia le donne per il prelevamento di Paganine e le invita a compiere nuove azioni di lotta
Volantino dei GDD che elogia le donne per il prelevamento di Paganine e le invita a compiere nuove azioni di lotta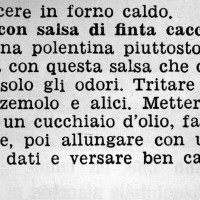 Ricetta di cucina per far fronte alla penuria di viveri. Fu pubblicata nel dicembre 1944 sul giornale dei GDD “Noi donne”
Ricetta di cucina per far fronte alla penuria di viveri. Fu pubblicata nel dicembre 1944 sul giornale dei GDD “Noi donne”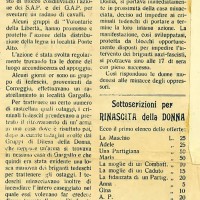 Nell'inverno 1945 anche il combustibile scarseggia. Nel marzo “Rinascita della donna”, giornale dei GDD modenesi, rende conto di un prelevamento di legna
Nell'inverno 1945 anche il combustibile scarseggia. Nel marzo “Rinascita della donna”, giornale dei GDD modenesi, rende conto di un prelevamento di legna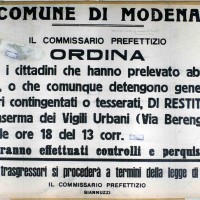 Fin dal settembre 1943 le donne assaltano gli ammassi per prelevare viveri, nonostante le contromisure prese dalle autorità
Fin dal settembre 1943 le donne assaltano gli ammassi per prelevare viveri, nonostante le contromisure prese dalle autorità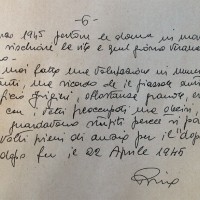 Testimonianza di Ibes Pioli “Rina”
Testimonianza di Ibes Pioli “Rina”
 monte Caio, cima Bocchialini
monte Caio, cima Bocchialini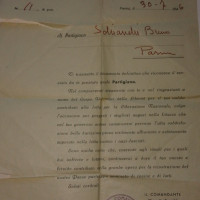 documenti dell’attività partigiana di Bruno Schianchi
documenti dell’attività partigiana di Bruno Schianchi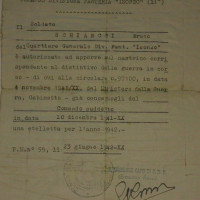 documenti dell’attività partigiana di Bruno Schianchi
documenti dell’attività partigiana di Bruno Schianchi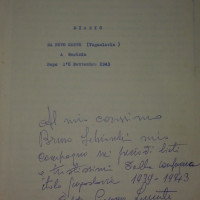 documenti dell’attività partigiana di Bruno Schianchi
documenti dell’attività partigiana di Bruno Schianchi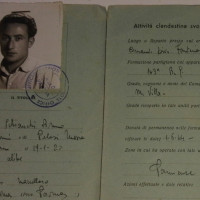 documenti dell’attività partigiana di Bruno Schianchi
documenti dell’attività partigiana di Bruno Schianchi documenti dell’attività partigiana di Bruno Schianchi
documenti dell’attività partigiana di Bruno Schianchi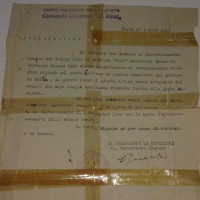 documenti dell’attività partigiana di Bruno Schianchi
documenti dell’attività partigiana di Bruno Schianchi Bruno e Rita
Bruno e Rita
 I sapisti sfilano il 5 maggio 1945 nel centro di Piacenza.
I sapisti sfilano il 5 maggio 1945 nel centro di Piacenza.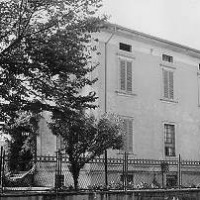 La “Villa delle torture” a S. Giuliano di Castelvetro, dove passarono partigiani delle SAP di pianura sottoposti agli interrogatori delle SS italiane del tenente Lombardo.
La “Villa delle torture” a S. Giuliano di Castelvetro, dove passarono partigiani delle SAP di pianura sottoposti agli interrogatori delle SS italiane del tenente Lombardo.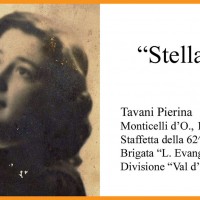 Pierina Tavani, “Stella”, staffetta da Monticelli ai monti della val d'Arda.
Pierina Tavani, “Stella”, staffetta da Monticelli ai monti della val d'Arda. Dario Bianchera comandante delle squadre SAP.
Dario Bianchera comandante delle squadre SAP. Alcuni partigiani della bassa della 38° Brigata Garibaldi.
Alcuni partigiani della bassa della 38° Brigata Garibaldi. Lino Vescovi, il “Valoroso”, sul Po a Monticelli d'Ongina dove era nato.
Lino Vescovi, il “Valoroso”, sul Po a Monticelli d'Ongina dove era nato.
 1938: il re a Forlì
1938: il re a Forlì Piazza della Vittoria: cerimonie fasciste
Piazza della Vittoria: cerimonie fasciste Vista aerea Piazza della Vittoria
Vista aerea Piazza della Vittoria Vista aerea Piazza della Vittoria
Vista aerea Piazza della Vittoria Piazza della Vittoria: cerimonie fasciste
Piazza della Vittoria: cerimonie fasciste Piazza della Vittoria: cerimonie fasciste
Piazza della Vittoria: cerimonie fasciste Piazza della Vittoria: cerimonie fasciste
Piazza della Vittoria: cerimonie fasciste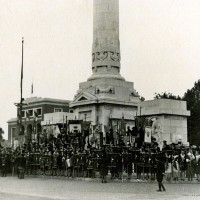 Piazza della Vittoria: cerimonie fasciste
Piazza della Vittoria: cerimonie fasciste Piazza della Vittoria: cerimonie fasciste
Piazza della Vittoria: cerimonie fasciste Mussolini visita i cantieri del Monumento alla Vittoria
Mussolini visita i cantieri del Monumento alla Vittoria Piazza della Vittoria: cerimonie fasciste
Piazza della Vittoria: cerimonie fasciste Piazza della Vittoria: cerimonia degli anni '70-'80
Piazza della Vittoria: cerimonia degli anni '70-'80 Piazza della Vittoria
Piazza della Vittoria Piazza della Vittoria: Liberazione di Forlì (9 novembre 1944)
Piazza della Vittoria: Liberazione di Forlì (9 novembre 1944) Piazza della Vittoria: Liberazione di Forlì (9 novembre 1944)
Piazza della Vittoria: Liberazione di Forlì (9 novembre 1944)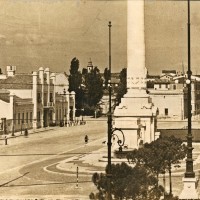 Piazza della Vittoria
Piazza della Vittoria Mussolini visita i cantieri del Monumento alla Vittoria
Mussolini visita i cantieri del Monumento alla Vittoria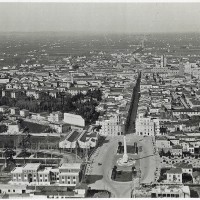 Vista aerea Piazza della Vittoria
Vista aerea Piazza della Vittoria
 Renzo Strada, figlio di Urbano, residente al Mulino fino al 1928, poi riconosciuto partigiano della 28ª Brigata Gordini
Renzo Strada, figlio di Urbano, residente al Mulino fino al 1928, poi riconosciuto partigiano della 28ª Brigata Gordini Zelio Strada (a sx), figlio di Urbano, residente al Mulino fino al 1928, poi riconosciuto partigiano della 28ª Brigata Gordini
Zelio Strada (a sx), figlio di Urbano, residente al Mulino fino al 1928, poi riconosciuto partigiano della 28ª Brigata Gordini Il mulino oggi
Il mulino oggi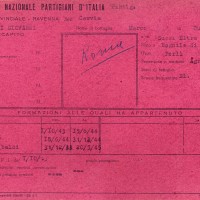 Riconoscimento partigiano di Giovanni Rossi
Riconoscimento partigiano di Giovanni Rossi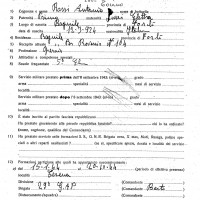 Riconoscimento partigiano di Tonino Rossi
Riconoscimento partigiano di Tonino Rossi
 Questa cartolina, non datata ma risalente alla prima metà del Novecento, mostra l'abitato di Soliera, ancora circoscritto all'area delle antiche mura. All'esterno del borgo si aprono le campagne, dove sorgono case coloniche sparse (da Biblioteca Poletti).
Questa cartolina, non datata ma risalente alla prima metà del Novecento, mostra l'abitato di Soliera, ancora circoscritto all'area delle antiche mura. All'esterno del borgo si aprono le campagne, dove sorgono case coloniche sparse (da Biblioteca Poletti).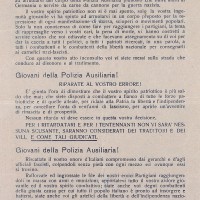 L’ organizzazione della Resistenza esorta i giovani che sono entrati nella Polizia ausiliaria della Repubblica Sociale Italiana a disertare: solo unendosi ai partigiani potranno togliersi la macchia di aver collaborato con il fascismo di Salò.
L’ organizzazione della Resistenza esorta i giovani che sono entrati nella Polizia ausiliaria della Repubblica Sociale Italiana a disertare: solo unendosi ai partigiani potranno togliersi la macchia di aver collaborato con il fascismo di Salò.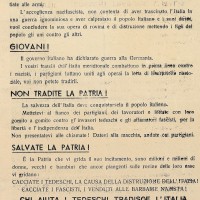 Dopo i richiami alle armi della Repubblica Sociale Italiana le forze antifasciste esortano i giovani a non combattere per Hitler e Mussolini, evitando “domani” la punizione riservata ai “traditori di oggi”.
Dopo i richiami alle armi della Repubblica Sociale Italiana le forze antifasciste esortano i giovani a non combattere per Hitler e Mussolini, evitando “domani” la punizione riservata ai “traditori di oggi”.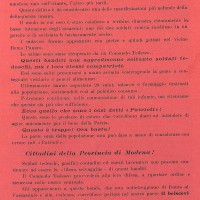 Questo manifestino tedesco del 9 marzo 1945 denuncia gli attacchi compiuti dai partigiani contro i soldati tedeschi e i fascisti repubblicani, oltre alle azioni di prelevamento alimentare. I nazisti rinforzano le minacce di rappresaglia e vendetta sulla popolazione civile, che tuttavia non vengono sempre attuate come risposte alle attività della Resistenza: in diversi casi le violenze naziste e fasciste sono autonome e non riconducibili a meccanismi vendicativi.
Questo manifestino tedesco del 9 marzo 1945 denuncia gli attacchi compiuti dai partigiani contro i soldati tedeschi e i fascisti repubblicani, oltre alle azioni di prelevamento alimentare. I nazisti rinforzano le minacce di rappresaglia e vendetta sulla popolazione civile, che tuttavia non vengono sempre attuate come risposte alle attività della Resistenza: in diversi casi le violenze naziste e fasciste sono autonome e non riconducibili a meccanismi vendicativi.
 Esterina Longarini
Esterina Longarini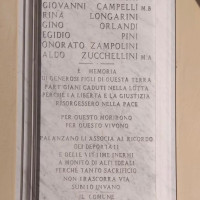 epigrafe, Municipio di Palanzano
epigrafe, Municipio di Palanzano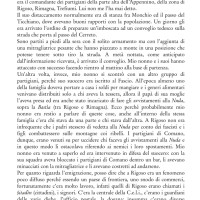 testimonianza sulla reticenza a parlare di Resistenza in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).
testimonianza sulla reticenza a parlare di Resistenza in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).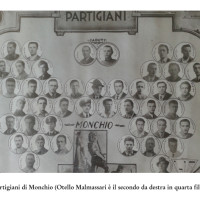 testimonianza sulla reticenza a parlare di Resistenza in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).
testimonianza sulla reticenza a parlare di Resistenza in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).
 Partigiani della 143a Brigata Garibaldi (ex 47a): Ferrante Felisa (Drago), Giovanni Torri (Bufalo), Luigi Diemmi (Rolando), Onelio Torri (Bufalo), Enrico Mordacci (Rossano).
Partigiani della 143a Brigata Garibaldi (ex 47a): Ferrante Felisa (Drago), Giovanni Torri (Bufalo), Luigi Diemmi (Rolando), Onelio Torri (Bufalo), Enrico Mordacci (Rossano).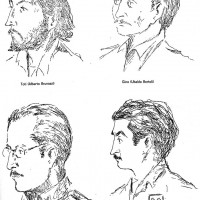 Ritratti di partigiani della 47a brigata Garibaldi (di Ubaldo Bertoli, partigiano Gino ).
Ritratti di partigiani della 47a brigata Garibaldi (di Ubaldo Bertoli, partigiano Gino ).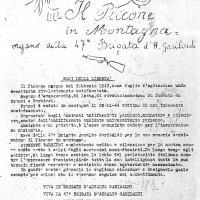 Il Piccone in Montagna, organo di stampa della 47a Brigata Garibaldi.
Il Piccone in Montagna, organo di stampa della 47a Brigata Garibaldi.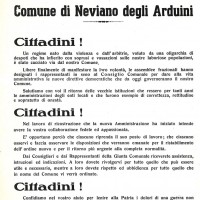 Proclama al popolo della 47a Brigata Garibaldi.
Proclama al popolo della 47a Brigata Garibaldi.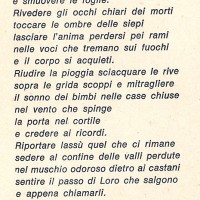 Ai morti della 47a, di Ubaldo Bertoli, partigiano Gino.
Ai morti della 47a, di Ubaldo Bertoli, partigiano Gino.
 Ciminiera della ex fabbrica Mangelli 2014
Ciminiera della ex fabbrica Mangelli 2014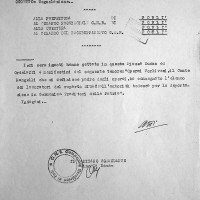 Documento Guardia nazionale repubblicana di Forlì
Documento Guardia nazionale repubblicana di Forlì Ex Orsi mangelli, Palazzo degli uffici_2014 retro
Ex Orsi mangelli, Palazzo degli uffici_2014 retro Orsi Mangelli
Orsi Mangelli Orsi Mangelli, Palazzo degli Uffici
Orsi Mangelli, Palazzo degli Uffici Orsi Mangelli, Palazzo degli uffici
Orsi Mangelli, Palazzo degli uffici Piazzale Orsi Mangelli
Piazzale Orsi Mangelli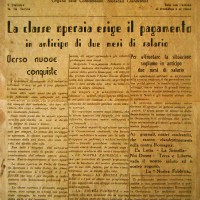 Stampa clandestina. La nostra fabbrica, giugno 1944
Stampa clandestina. La nostra fabbrica, giugno 1944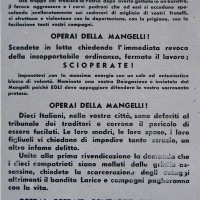 Stampa clandestina. Pci agli operai della Mangelli, volantino
Stampa clandestina. Pci agli operai della Mangelli, volantino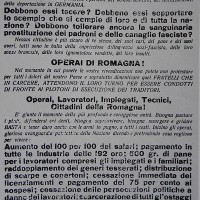 Stampa clandestina. PdA a operai romagnoli, volantino
Stampa clandestina. PdA a operai romagnoli, volantino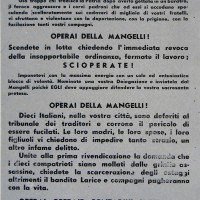 Stampa clandestina. Volantino del Pci agli operai della Mangelli
Stampa clandestina. Volantino del Pci agli operai della Mangelli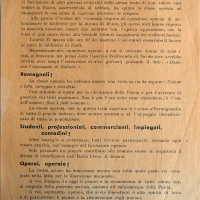 Stampa clandestina. Volantino dello sciopero
Stampa clandestina. Volantino dello sciopero
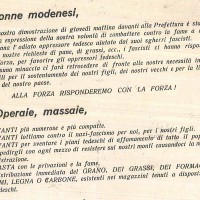 Volantino dei Gruppi di Difesa della donna sulla manifestazione davanti alla Prefettura.
Volantino dei Gruppi di Difesa della donna sulla manifestazione davanti alla Prefettura.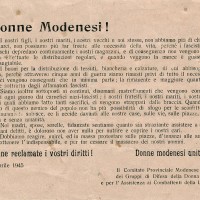 Appello alla mobilitazione delle donne modenesi.
Appello alla mobilitazione delle donne modenesi. Giovani partigiane il giorno della liberazione.
Giovani partigiane il giorno della liberazione.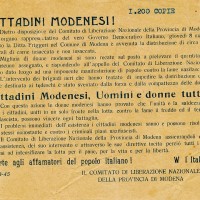 Volantino che esalta la manifestazione di donne davanti al salumificio Frigeri di Paganine, l'8 marzo 1945.
Volantino che esalta la manifestazione di donne davanti al salumificio Frigeri di Paganine, l'8 marzo 1945.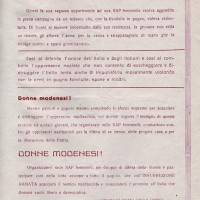 Volantino dei Gruppi di difesa della donna di Modena.
Volantino dei Gruppi di difesa della donna di Modena.
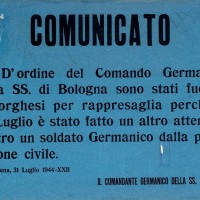 Comunicato tedesco sulla rappresaglia realizzata il giorno dopo quella di Piazza Grande.
Comunicato tedesco sulla rappresaglia realizzata il giorno dopo quella di Piazza Grande.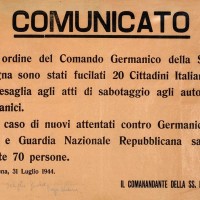 Il comunicato tedesco sulla strage di Piazza Grande.
Il comunicato tedesco sulla strage di Piazza Grande.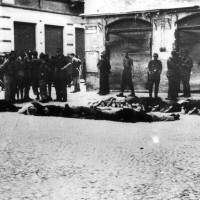 L'eccidio di Piazza Grande. La foto fu scattata da un sacerdote di nascosto.
L'eccidio di Piazza Grande. La foto fu scattata da un sacerdote di nascosto.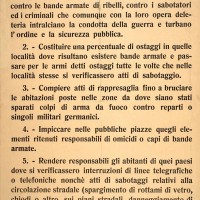 L'ordine di inasprimento della repressione contro i partigiani emanato da Kesserling.
L'ordine di inasprimento della repressione contro i partigiani emanato da Kesserling.
 Giuseppe Ghirardelli (25/9/1904 – 29/1/2015). Propagandista antifascista, ospito e organizzo nella sua osteria riunioni clandestine, partecipo al salvataggio di piloti alleati. Arrestato dai nazifascisti il 18/1/1945, dopo essere stato torturato, fu condannato a morte per “partigianismo” e fucilato il 29/1/1945
Giuseppe Ghirardelli (25/9/1904 – 29/1/2015). Propagandista antifascista, ospito e organizzo nella sua osteria riunioni clandestine, partecipo al salvataggio di piloti alleati. Arrestato dai nazifascisti il 18/1/1945, dopo essere stato torturato, fu condannato a morte per “partigianismo” e fucilato il 29/1/1945 Giovanni Farinelli (28/4/1915 – 29/1/1945). Propagandista antifascista partecipo al salvataggio di piloti alleati. Arrestato dai nazifascisti il 1771/194, dopo essere stato torturato fu condannato a morte per “partigianismo” e fucilato il 29/1/1945
Giovanni Farinelli (28/4/1915 – 29/1/1945). Propagandista antifascista partecipo al salvataggio di piloti alleati. Arrestato dai nazifascisti il 1771/194, dopo essere stato torturato fu condannato a morte per “partigianismo” e fucilato il 29/1/1945 Timbro della 35ª Brigata Garibaldi distaccamento di Comacchio
Timbro della 35ª Brigata Garibaldi distaccamento di Comacchio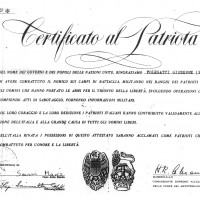 Certificato del patriota di Giuseppe Folegatti
Certificato del patriota di Giuseppe Folegatti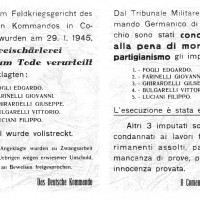 Pubblicizzazione della condanna ed esecuzione di partigiani da parte del comando tedesco
Pubblicizzazione della condanna ed esecuzione di partigiani da parte del comando tedesco 27 febbraio 1945. Partigiani della 28ª brigata che caricano munizioni in un carretto
27 febbraio 1945. Partigiani della 28ª brigata che caricano munizioni in un carretto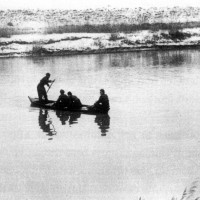 Partigiani che attraversano il fiume Reno dopo aver recuperato alcune pecore che hanno ucciso sull’altra riva del fiume
Partigiani che attraversano il fiume Reno dopo aver recuperato alcune pecore che hanno ucciso sull’altra riva del fiume I Partigiani scaricano le pecore che hanno ucciso sull'altra riva del fiume Reno. Gennaio 1945
I Partigiani scaricano le pecore che hanno ucciso sull'altra riva del fiume Reno. Gennaio 1945
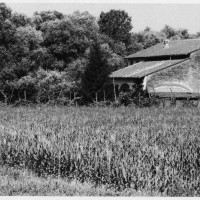 Casa Malvisi
Casa Malvisi Lapide casa Malvisi: didascalia “targa posta sulla casa Malvisi che ricorda Sisto Fontanili, Walter Cantoni (caduti nella battaglia di Casa Malvisi) e Gino Bondi (caduto il 26 aprile 1945 negli scontri contro i tedeschi in località Giarole)
Lapide casa Malvisi: didascalia “targa posta sulla casa Malvisi che ricorda Sisto Fontanili, Walter Cantoni (caduti nella battaglia di Casa Malvisi) e Gino Bondi (caduto il 26 aprile 1945 negli scontri contro i tedeschi in località Giarole)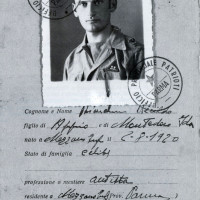 Cesare: didascalia: Ricildo Bianchini “Cesare”. Tesserino partigiano, nella foto sono visibili sulla spalla sinistra del giubbotto i fori provocati dai proiettili che lo ferirono gravemente durante gli scontri nella battaglia di casa Malvisi.
Cesare: didascalia: Ricildo Bianchini “Cesare”. Tesserino partigiano, nella foto sono visibili sulla spalla sinistra del giubbotto i fori provocati dai proiettili che lo ferirono gravemente durante gli scontri nella battaglia di casa Malvisi.
 Don Elio Monari.
Don Elio Monari. Angelo Donati, ebreo modenese protagonista del salvataggio di migliaia di ebrei nel sud-est della Francia.
Angelo Donati, ebreo modenese protagonista del salvataggio di migliaia di ebrei nel sud-est della Francia. Don Arrigo Beccari, parroco di Rubbiara, uno dei più attivi sacerdoti nel salvataggio degli ebrei.
Don Arrigo Beccari, parroco di Rubbiara, uno dei più attivi sacerdoti nel salvataggio degli ebrei. Monumento ai fucilati delle cascine a Firenze. Qui trovò la morte don Elio Monari (foto Giovanni Baldini).
Monumento ai fucilati delle cascine a Firenze. Qui trovò la morte don Elio Monari (foto Giovanni Baldini).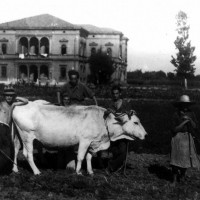 Villa Emma di Nonantola.
Villa Emma di Nonantola.
 Ritratto di Adelmo Dalmari nella composizione fotografica dedicata ai caduti partigiani di Soliera.
Ritratto di Adelmo Dalmari nella composizione fotografica dedicata ai caduti partigiani di Soliera. Il Passo dell’Uccellino sul fiume Secchia. Adelmo Dalmari presta qui l’attività di traghettatore da una sponda all’altra (da Biblioteca Poletti).
Il Passo dell’Uccellino sul fiume Secchia. Adelmo Dalmari presta qui l’attività di traghettatore da una sponda all’altra (da Biblioteca Poletti). Lavori per la costruzione di un ponte presso il Passo dell’Uccellino sul fiume Secchia.
Lavori per la costruzione di un ponte presso il Passo dell’Uccellino sul fiume Secchia.
 cippo
cippo la testimonianza dei giorni del rastrellamento a Casarola e Pianadetto in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).
la testimonianza dei giorni del rastrellamento a Casarola e Pianadetto in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).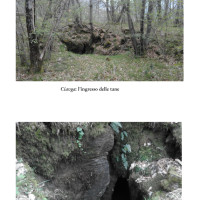 la testimonianza dei giorni del rastrellamento a Casarola e Pianadetto in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).
la testimonianza dei giorni del rastrellamento a Casarola e Pianadetto in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).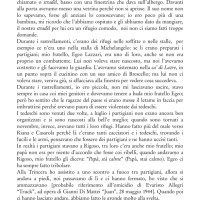 la testimonianza dei giorni del rastrellamento a Casarola e Pianadetto in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).
la testimonianza dei giorni del rastrellamento a Casarola e Pianadetto in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).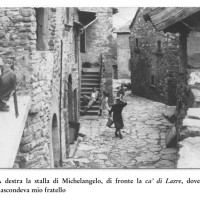 la testimonianza dei giorni del rastrellamento a Casarola e Pianadetto in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).
la testimonianza dei giorni del rastrellamento a Casarola e Pianadetto in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).
 Foto del comandante “Fausto” della Divisione “Piacenza” al Monticello (Fausto Cossu, Tempio Pausania 1915 - Piacenza, 16 aprile 2005; avvocato)
Foto del comandante “Fausto” della Divisione “Piacenza” al Monticello (Fausto Cossu, Tempio Pausania 1915 - Piacenza, 16 aprile 2005; avvocato) Dopo la Liberazione: consegna delle armi nel cortile di Palazzo Farnese
Dopo la Liberazione: consegna delle armi nel cortile di Palazzo Farnese Dopo la Liberazione: cerimonia e sfilata delle Divisioni partigiane in centro città
Dopo la Liberazione: cerimonia e sfilata delle Divisioni partigiane in centro città Dopo la Liberazione: uno dei tanti funerali partigiani
Dopo la Liberazione: uno dei tanti funerali partigiani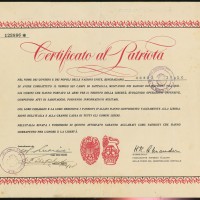 Un attestato di “Patriota” conferito a un partigiano firmato dal Generale Alexander
Un attestato di “Patriota” conferito a un partigiano firmato dal Generale Alexander
 Manifestazione militare in Piazza Cavalli a Piacenza negli anni della RSI
Manifestazione militare in Piazza Cavalli a Piacenza negli anni della RSI Manifesto della RSI
Manifesto della RSI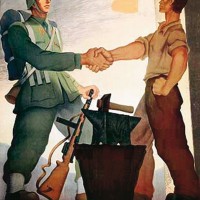 Manifesto della RSI
Manifesto della RSI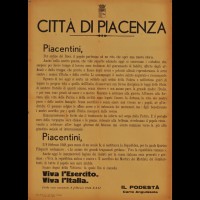 Volantino del Podestà di Piacenza che invita ad una cerimonia ufficiale
Volantino del Podestà di Piacenza che invita ad una cerimonia ufficiale Trafiletto su La Scure dell'1 febbraio 1944 che documenta i buoni rapporti con l'occupante tedesco
Trafiletto su La Scure dell'1 febbraio 1944 che documenta i buoni rapporti con l'occupante tedesco Il Palazzo INA gli inizi della costruzione del palazzo INPS
Il Palazzo INA gli inizi della costruzione del palazzo INPS Palazzo Gotico e Palazzo INA in Piazza Cavalli
Palazzo Gotico e Palazzo INA in Piazza Cavalli Il Federale di Piacenza Antonino Maccagni
Il Federale di Piacenza Antonino Maccagni
 Uno dei rifugi antiaerei in città
Uno dei rifugi antiaerei in città Cittadini che fuggono al suono dell'allarme antiaereo in Via San Vitale
Cittadini che fuggono al suono dell'allarme antiaereo in Via San Vitale Cittadini che fuggono con ogni mezzo al suono dell'allarme antiaereo in Via San Vitale
Cittadini che fuggono con ogni mezzo al suono dell'allarme antiaereo in Via San Vitale Cittadini che fuggono al suono dell'allarme antiaereo in Via San Vitale
Cittadini che fuggono al suono dell'allarme antiaereo in Via San Vitale Il clima che si respira in città è di forte senso del pericolo: i cittadini sono pronti a fuggire al suono dell'allarme antiaereo
Il clima che si respira in città è di forte senso del pericolo: i cittadini sono pronti a fuggire al suono dell'allarme antiaereo
 Il 22 aprile 1945 l'ormai anziano antifascista Geminiano Loschi, già sindaco socialista di Soliera fra il 1919 e il 1920, tiene il discorso della Liberazione dal balcone di Casa Lugli, in piazza Fratelli Sassi.
Il 22 aprile 1945 l'ormai anziano antifascista Geminiano Loschi, già sindaco socialista di Soliera fra il 1919 e il 1920, tiene il discorso della Liberazione dal balcone di Casa Lugli, in piazza Fratelli Sassi. Il 22 aprile 1945 Mario Bisi, Commissario politico delle formazioni partigiane solieresi e protagonista della Resistenza nella Prima zona, tiene il discorso della Liberazione dal balcone di Casa Lugli, in piazza Fratelli Sassi.
Il 22 aprile 1945 Mario Bisi, Commissario politico delle formazioni partigiane solieresi e protagonista della Resistenza nella Prima zona, tiene il discorso della Liberazione dal balcone di Casa Lugli, in piazza Fratelli Sassi. Corteo funebre a Soliera dopo la Liberazione. La banda accompagna la cerimonia, alla quale partecipa un gran numero di persone.
Corteo funebre a Soliera dopo la Liberazione. La banda accompagna la cerimonia, alla quale partecipa un gran numero di persone.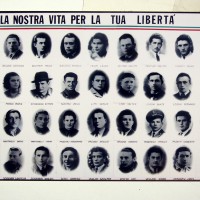 Dopo la Liberazione la sezione ANPI di Soliera omaggia i caduti della Resistenza con la stampa di un manifesto che riunisce i loro volti e i loro nomi.
Dopo la Liberazione la sezione ANPI di Soliera omaggia i caduti della Resistenza con la stampa di un manifesto che riunisce i loro volti e i loro nomi.
 Autorità militari tedesche e della RSI davanti al Palazzo del Governatore, 28 ottobre 1943
Autorità militari tedesche e della RSI davanti al Palazzo del Governatore, 28 ottobre 1943 Giuramento dei reparti del nuovo esercito della RSI, 28 ottobre 1943
Giuramento dei reparti del nuovo esercito della RSI, 28 ottobre 1943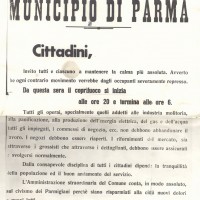 Disposizioni del Commissario prefettizio per la città occupata, 9 settembre 1943
Disposizioni del Commissario prefettizio per la città occupata, 9 settembre 1943 La Chiesa di San Pietro e la canonica dopo i bombardamenti alleati
La Chiesa di San Pietro e la canonica dopo i bombardamenti alleati Don Igino Guardiani tra le macerie della canonica di San Pietro bombardata dagli alleati
Don Igino Guardiani tra le macerie della canonica di San Pietro bombardata dagli alleati Un'immagine della Liberazione di Parma
Un'immagine della Liberazione di Parma Partigiani feriti assistono dal palco alla sfilata del 9 maggio 1945
Partigiani feriti assistono dal palco alla sfilata del 9 maggio 1945 I partigiani depongono le armi, 9 maggio 1945
I partigiani depongono le armi, 9 maggio 1945 I partigiani sfilano in via Cavour, 9 maggio 1945
I partigiani sfilano in via Cavour, 9 maggio 1945 La folla in festa accoglie i partigiani in piazza Garibaldi, 9 maggio 1945
La folla in festa accoglie i partigiani in piazza Garibaldi, 9 maggio 1945 Piazza Garibaldi il 9 maggio 1945
Piazza Garibaldi il 9 maggio 1945
 Corassori inaugura la lapide a Emilio Po, Alfonso Piazza e Giacomo Ulivi nel 1948.
Corassori inaugura la lapide a Emilio Po, Alfonso Piazza e Giacomo Ulivi nel 1948. Giacomo Ulivi.
Giacomo Ulivi. Il Comitato di liberazione nazionale condanna a morte i fascisti responsabili di torture e violenze.
Il Comitato di liberazione nazionale condanna a morte i fascisti responsabili di torture e violenze.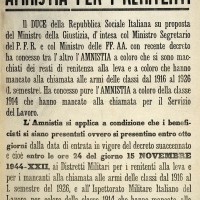 Manifesto che annuncia una delle tante amnistie offerte dal fascismo repubblicano.
Manifesto che annuncia una delle tante amnistie offerte dal fascismo repubblicano. Treno tedesco fatto saltare dai partigiani nel modenese.
Treno tedesco fatto saltare dai partigiani nel modenese.
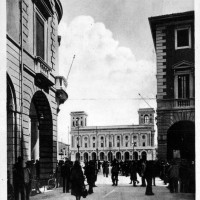 Cartolina Palazzo delle poste
Cartolina Palazzo delle poste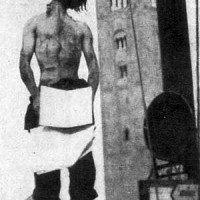 Corbari, 18 agosto 1944
Corbari, 18 agosto 1944 Corbari, Casadei e Versari, 18 agosto 1944
Corbari, Casadei e Versari, 18 agosto 1944 Corbari e Casadei, 18 agosto 1944
Corbari e Casadei, 18 agosto 1944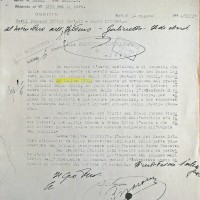 Documento Questura sui fatti del 26 luglio 1943
Documento Questura sui fatti del 26 luglio 1943 Iris Versari
Iris Versari Iris Versari, 18 agosto 1944
Iris Versari, 18 agosto 1944 Novembre 1944, gli Alleati, sullo sfondo il Palazzo delle Poste
Novembre 1944, gli Alleati, sullo sfondo il Palazzo delle Poste Palazzo degli Uffici statali
Palazzo degli Uffici statali Panorama di Piazza Saffi
Panorama di Piazza Saffi Piazza Saffi, anni '30
Piazza Saffi, anni '30 Piazza Saffi, anni '30
Piazza Saffi, anni '30 Piazza Saffi, prima della costruzione dei Palazzi statali
Piazza Saffi, prima della costruzione dei Palazzi statali Piazza Saffi, prima della costruzione del Palazzo delle Poste
Piazza Saffi, prima della costruzione del Palazzo delle Poste Piazza Saffi, prima della costruzione del Palazzo delle Poste e Uffici Statali
Piazza Saffi, prima della costruzione del Palazzo delle Poste e Uffici Statali
 Gli uomini dell'VIII Brigata della Divisione “Piacenza” al comando di Enrico Rancati entrano in città la mattina del 28 aprile 1945
Gli uomini dell'VIII Brigata della Divisione “Piacenza” al comando di Enrico Rancati entrano in città la mattina del 28 aprile 1945 Un gruppo di militari dell'86° Battaglione territoriale che partecipò alla Resistenza contro i tedeschi il 9 settembre 1943
Un gruppo di militari dell'86° Battaglione territoriale che partecipò alla Resistenza contro i tedeschi il 9 settembre 1943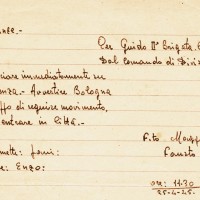 Ordine autografo di Fausto Cossu, comandante della Divisione “Piacenza” di marciare verso la città, 25 aprile 1945, ore 11,30
Ordine autografo di Fausto Cossu, comandante della Divisione “Piacenza” di marciare verso la città, 25 aprile 1945, ore 11,30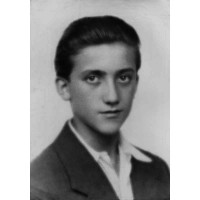 Giorgio Gasperini all'età di 18 anni: uno dei partigiani uccisi durante i combattimenti per la Liberazione di Piacenza
Giorgio Gasperini all'età di 18 anni: uno dei partigiani uccisi durante i combattimenti per la Liberazione di Piacenza
 Piazza Duomo bombardata
Piazza Duomo bombardata Discesa in un rifugio antiaereo
Discesa in un rifugio antiaereo Prima della guerra: esercitazione di ragazzi della GIL (Gioventù Italiana del Littorio) con maschere antigas
Prima della guerra: esercitazione di ragazzi della GIL (Gioventù Italiana del Littorio) con maschere antigas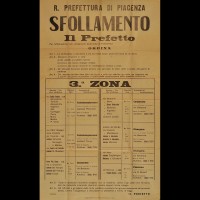 Manifesto per lo sfollamento programmato degli abitanti di una zona cittadina
Manifesto per lo sfollamento programmato degli abitanti di una zona cittadina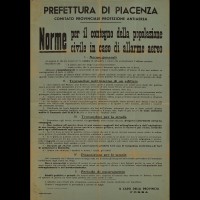 Volantino “norme per la popolazione civile in caso di bombardamento”
Volantino “norme per la popolazione civile in caso di bombardamento”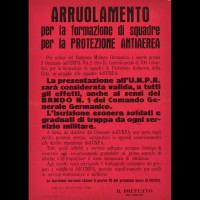 Manifesto per l'arruolamento nell'UNPA
Manifesto per l'arruolamento nell'UNPA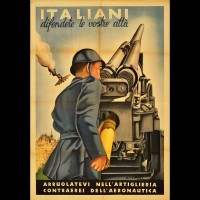 Manifesto per l'arruolamento nell'artiglieria contraerea
Manifesto per l'arruolamento nell'artiglieria contraerea
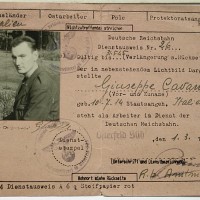 Documento del Deutsche Reichsbahn.
Documento del Deutsche Reichsbahn. Internati militari italiani sono costretti a lavorare per i tedeschi.
Internati militari italiani sono costretti a lavorare per i tedeschi. Parte degli internati militari sono costretti a lavorare per le industrie tedesche. Questo documento era di un internato modenese.
Parte degli internati militari sono costretti a lavorare per le industrie tedesche. Questo documento era di un internato modenese. Un gruppo di internati militari italiani in Germania.
Un gruppo di internati militari italiani in Germania. Una piastrina in metallo appartenuta a un internato militare modenese.
Una piastrina in metallo appartenuta a un internato militare modenese.
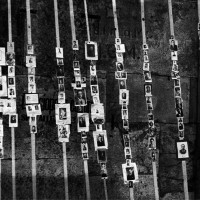 Fotografie dei partigiani esposte sul muro della Ghirlandina nell'immediato dopoguerra.
Fotografie dei partigiani esposte sul muro della Ghirlandina nell'immediato dopoguerra. Celebrazione davanti al sacrario partigiano in occasione del congresso nazionale degli antifascisti.
Celebrazione davanti al sacrario partigiano in occasione del congresso nazionale degli antifascisti. Commemoriazione di fronte alla Ghirlandina il 9 gennaio 1951, primo anniversario dell'eccidio davanti alle Fonderie Riunite.
Commemoriazione di fronte alla Ghirlandina il 9 gennaio 1951, primo anniversario dell'eccidio davanti alle Fonderie Riunite. Il sacrario partigiano prima della ristrutturazione attuale.
Il sacrario partigiano prima della ristrutturazione attuale. Si raccolgono le firme davanti al Sacrario della Ghirlandina contro la guerra in Vietnam.
Si raccolgono le firme davanti al Sacrario della Ghirlandina contro la guerra in Vietnam.
 Un contadino insieme ad alcuni partigiani e soldati italiani traina una jeep impantanatasi a Pieve di Rivoschio nell'ottobre del 1944.
Un contadino insieme ad alcuni partigiani e soldati italiani traina una jeep impantanatasi a Pieve di Rivoschio nell'ottobre del 1944. A Castellonchio (Pieve di Rivoschio) alcuni partigiani conversano tra loro mentre una ragazza risale la strada. Sullo sfondo si intravedono alcuni bambini.
A Castellonchio (Pieve di Rivoschio) alcuni partigiani conversano tra loro mentre una ragazza risale la strada. Sullo sfondo si intravedono alcuni bambini. Lapide all'ingresso del Parco della Pace e della Resistenza.
Lapide all'ingresso del Parco della Pace e della Resistenza. Ingresso del Parco della Pace e della Resistenza.
Ingresso del Parco della Pace e della Resistenza.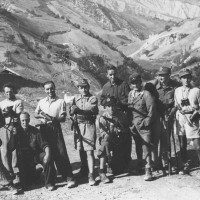 Partigiani a Pieve di Rivoschio (settembre 1944).
Partigiani a Pieve di Rivoschio (settembre 1944).
 Una squadra di fiocinini (Archivio Fotowall)
Una squadra di fiocinini (Archivio Fotowall) Guardie vallive a bordo di vulicépi (archivio fotografico Direzione didtatica Comacchio)
Guardie vallive a bordo di vulicépi (archivio fotografico Direzione didtatica Comacchio)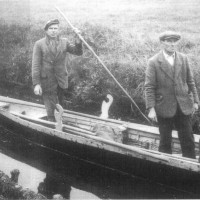 Guardie vallive
Guardie vallive Zona di attività partigiana. Chiavica Scirocca (Capanno di canne e fango, ricovero di partigiani, ASDS Ferrara)
Zona di attività partigiana. Chiavica Scirocca (Capanno di canne e fango, ricovero di partigiani, ASDS Ferrara) Basi e zona dell’attività partigiana nelle valli di Comacchio
Basi e zona dell’attività partigiana nelle valli di Comacchio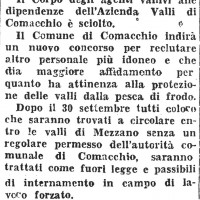 30 settembre 1944. Bando della Prefettura Repubblicana di Ferrara, sulla regolamentazione della circolazione in barca nelle valli di Mezzano a seguito dello scioglimento del Corpo degli agenti vallivi
30 settembre 1944. Bando della Prefettura Repubblicana di Ferrara, sulla regolamentazione della circolazione in barca nelle valli di Mezzano a seguito dello scioglimento del Corpo degli agenti vallivi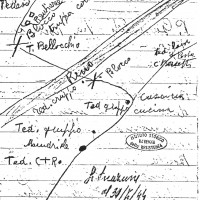 Mappa partigiana disegnata a mano, 30/7/1944
Mappa partigiana disegnata a mano, 30/7/1944
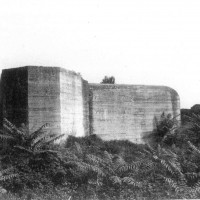 Bunker tedeschi lungo la strada Romea a nord di Comacchio. Foto C. Fanti
Bunker tedeschi lungo la strada Romea a nord di Comacchio. Foto C. Fanti Bunker tedeschi lungo la strada Romea a nord di Comacchio. Foto C. Fanti
Bunker tedeschi lungo la strada Romea a nord di Comacchio. Foto C. Fanti Porto Garibaldi. Via Provinciale bombardata. ASDS Ferrara
Porto Garibaldi. Via Provinciale bombardata. ASDS Ferrara Porto Garibaldi. Porto Bombardato. ASDS Ferrara
Porto Garibaldi. Porto Bombardato. ASDS Ferrara Porto Garibaldi Paese Bombardato
Porto Garibaldi Paese Bombardato Porto Garibaldi Paese Bombardato
Porto Garibaldi Paese Bombardato Porto Garibaldi. Chiesa Bombardata. ASDS Ferrara
Porto Garibaldi. Chiesa Bombardata. ASDS Ferrara Porto Garibaldi. Acquedotto comunale bombardato. ASDS Ferrara
Porto Garibaldi. Acquedotto comunale bombardato. ASDS Ferrara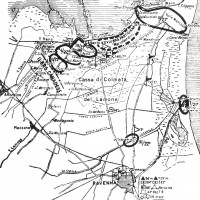 Linea del Fronte 23 gennaio 1945. Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, I gruppi combattenti, (1944- 1945) Roma 1973
Linea del Fronte 23 gennaio 1945. Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, I gruppi combattenti, (1944- 1945) Roma 1973 Soldati della North Irish Horse sul fronte dell’VIII Armata nelle trincee sul Reno
Soldati della North Irish Horse sul fronte dell’VIII Armata nelle trincee sul Reno Il tenente generale C.F Keightley viene trasportato in barca attraverso il fiume Reno dai Partigiani
Il tenente generale C.F Keightley viene trasportato in barca attraverso il fiume Reno dai Partigiani Una chiatta Bailey pronta per essere impiegata (1-2 aprile 1945)
Una chiatta Bailey pronta per essere impiegata (1-2 aprile 1945) Il Feldermaresciallo Alexander e il suo seguito ispezionato trincee ed equipaggiamenti nella zona delle vene di Bellocchio tra le valli di Comacchio e il mare
Il Feldermaresciallo Alexander e il suo seguito ispezionato trincee ed equipaggiamenti nella zona delle vene di Bellocchio tra le valli di Comacchio e il mare Fantails condotti attraverso un Bailey costruito sul fiume Reno (4 aprile 1945)
Fantails condotti attraverso un Bailey costruito sul fiume Reno (4 aprile 1945) Soldati in trincea
Soldati in trincea 11 aprile 1945. Fantails nelle valli di Comacchio
11 aprile 1945. Fantails nelle valli di Comacchio Fantails si avviano al riparo di una cortina fumogena
Fantails si avviano al riparo di una cortina fumogena 11 aprile 1945. Il commando X 40 della marina scarica la propria imbarcazione lungo l’argine Agosta
11 aprile 1945. Il commando X 40 della marina scarica la propria imbarcazione lungo l’argine Agosta I Commandos avanzano nella zona presso l’idrivora
I Commandos avanzano nella zona presso l’idrivora Commandos lungo l’argine Agosta
Commandos lungo l’argine Agosta 11 aprile 1945. Commandos della Marina Inglese marciano lungo gli argini meridionali delle valli attraverso le campagne allagate
11 aprile 1945. Commandos della Marina Inglese marciano lungo gli argini meridionali delle valli attraverso le campagne allagate 1 Aprile 1945. Commandos della marina inglese marciano lungo gli argini meridionali delle valli attraverso le campagne allagate
1 Aprile 1945. Commandos della marina inglese marciano lungo gli argini meridionali delle valli attraverso le campagne allagate 1 Aprile 1945. Commandos della marina inglese marciano lungo gli argini meridionali delle valli attraverso le campagne allagate
1 Aprile 1945. Commandos della marina inglese marciano lungo gli argini meridionali delle valli attraverso le campagne allagate Cannonieri 267/67 reggimento controcarro (Anti -Tank Regiment) artiglieri britannica, caricamento di un cannone controcarro su di un Fantail
Cannonieri 267/67 reggimento controcarro (Anti -Tank Regiment) artiglieri britannica, caricamento di un cannone controcarro su di un Fantail Un Weasel viene introdotto a bordo di un Fantail
Un Weasel viene introdotto a bordo di un Fantail Fantails trasportante truppe dalle valli di Comacchio
Fantails trasportante truppe dalle valli di Comacchio Soldato tedesco morto sulla riva del Reno
Soldato tedesco morto sulla riva del Reno Prigionieri tedeschi
Prigionieri tedeschi
 Il 5° Battaglione (Northamptonshire regiment) a Portomaggiore.
Il 5° Battaglione (Northamptonshire regiment) a Portomaggiore.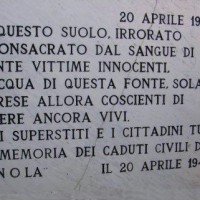 Lapide ai caduti della Gnola.
Lapide ai caduti della Gnola. Piazza del Municipio nel corso dell'Ottocento.
Piazza del Municipio nel corso dell'Ottocento. Piazza Umberto I a Portomaggiore.
Piazza Umberto I a Portomaggiore.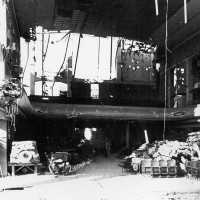 Teatro di Portomaggiore.
Teatro di Portomaggiore. Una scena dal film Ferrara, aprile 1945, dal Reno al Po di Claudio Magri.
Una scena dal film Ferrara, aprile 1945, dal Reno al Po di Claudio Magri. Soldati inglesi entrano a Portomaggiore.
Soldati inglesi entrano a Portomaggiore. Portomaggiore, 19 aprile 1945. Fanti del 5° Battaglione Northhants della 11a Brigata 78a Divisione Fanteria britannica attraversano Portomaggiore (tratto da Giuseppe Pieraccini, Finale. VIII Armata - Offensiva finale. Dal fiume Reno al Panaro al Po 13-28 aprile 1945, Ravenna, Il Ponte Vecchio, 2001, 125).
Portomaggiore, 19 aprile 1945. Fanti del 5° Battaglione Northhants della 11a Brigata 78a Divisione Fanteria britannica attraversano Portomaggiore (tratto da Giuseppe Pieraccini, Finale. VIII Armata - Offensiva finale. Dal fiume Reno al Panaro al Po 13-28 aprile 1945, Ravenna, Il Ponte Vecchio, 2001, 125). Carriarmati Sherman nella piazza principale di Portomaggiore, 20 aprile 1945.
Carriarmati Sherman nella piazza principale di Portomaggiore, 20 aprile 1945.
 epigrafe commemorativa
epigrafe commemorativa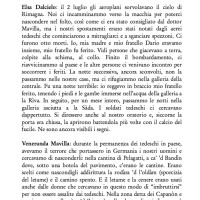 il racconto di quel giorno nelle testimonianze di alcuni abitanti di Rimagna in “Ribelli della montagna” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)
il racconto di quel giorno nelle testimonianze di alcuni abitanti di Rimagna in “Ribelli della montagna” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)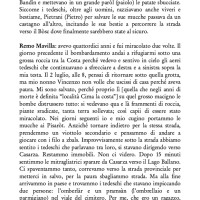 il racconto di quel giorno nelle testimonianze di alcuni abitanti di Rimagna in “Ribelli della montagna” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)
il racconto di quel giorno nelle testimonianze di alcuni abitanti di Rimagna in “Ribelli della montagna” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)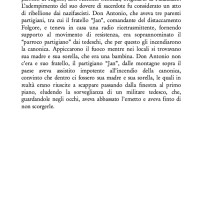 il racconto di quel giorno nelle testimonianze di alcuni abitanti di Rimagna in “Ribelli della montagna” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)
il racconto di quel giorno nelle testimonianze di alcuni abitanti di Rimagna in “Ribelli della montagna” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)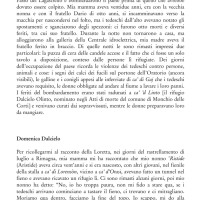 altre testimonianze raccolte in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).
altre testimonianze raccolte in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/). altre testimonianze raccolte in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).
altre testimonianze raccolte in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).
 La Rocca d'Olgisio, antico fortilizio sopra Pianello Val Tidone, caposaldo della Divisione GL- Piacenza, più volte attaccato dai nazifascisti.
La Rocca d'Olgisio, antico fortilizio sopra Pianello Val Tidone, caposaldo della Divisione GL- Piacenza, più volte attaccato dai nazifascisti. Fausto Cossu.
Fausto Cossu.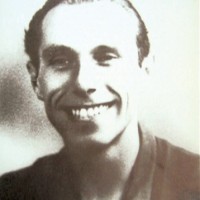 “Maber”, Manfredo Bertini è stato decorato con medaglia d'oro al valor militare. Nato nel 1914 a Montecarlo (Lucca) entrò subito nella resistenza in Versilia, addestrato per il Servizio Informazioni alleato, nei primi giorni d’agosto come agente della missione-radio “Balilla I”, viene paracadutato in Val Tidone presso la Divisione “Giustizia e Libertà “, comandata da Fausto Cossu. In breve tempo riusce con i compagni a organizzare nella zona un’efficiente rete informativa e di collegamento, potenziata nel settembre con l’invio della missione “Balilla II”.
“Maber”, Manfredo Bertini è stato decorato con medaglia d'oro al valor militare. Nato nel 1914 a Montecarlo (Lucca) entrò subito nella resistenza in Versilia, addestrato per il Servizio Informazioni alleato, nei primi giorni d’agosto come agente della missione-radio “Balilla I”, viene paracadutato in Val Tidone presso la Divisione “Giustizia e Libertà “, comandata da Fausto Cossu. In breve tempo riusce con i compagni a organizzare nella zona un’efficiente rete informativa e di collegamento, potenziata nel settembre con l’invio della missione “Balilla II”. Il “Valoroso” e la sua “camiassa”.
Il “Valoroso” e la sua “camiassa”.
 Augusto Maraldi
Augusto Maraldi Duilio Fusconi
Duilio Fusconi La famiglia Fusconi con alcuni partigiani di Ronta, Vittorio è il primo da sinistra e Duilio ha in braccio la figlia Gisella, 25 settembre 1944 (MB)
La famiglia Fusconi con alcuni partigiani di Ronta, Vittorio è il primo da sinistra e Duilio ha in braccio la figlia Gisella, 25 settembre 1944 (MB)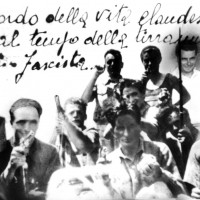 Il GAP di Ronta, il primo in alto da destra è Aldo Fusconi e in basso al centro è Duilio Fusconi (MB)
Il GAP di Ronta, il primo in alto da destra è Aldo Fusconi e in basso al centro è Duilio Fusconi (MB) Componenti della famiglia Fusconi, Vittorio è il terzo da destra, 1951.
Componenti della famiglia Fusconi, Vittorio è il terzo da destra, 1951. Foto di casa Maraldi oggi
Foto di casa Maraldi oggi
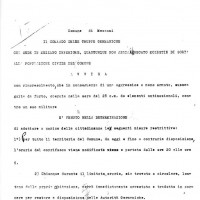 Avviso congiunto delle autorità comunali e del comando tedesco locali circa i provvedimenti da attuare per garantire la sicurezza delle truppe di occupazione tedesche
Avviso congiunto delle autorità comunali e del comando tedesco locali circa i provvedimenti da attuare per garantire la sicurezza delle truppe di occupazione tedesche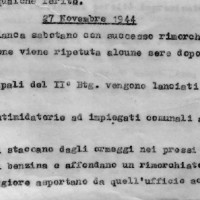 Alcune azioni di sabotaggio riportate nel diario storico della 78° Brigata Garibaldi Sap
Alcune azioni di sabotaggio riportate nel diario storico della 78° Brigata Garibaldi Sap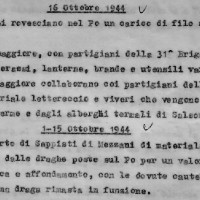 Alcune azioni di sabotaggio riportate nel diario storico della 78° Brigata Garibaldi Sap
Alcune azioni di sabotaggio riportate nel diario storico della 78° Brigata Garibaldi Sap
 Commemorazione al Sacrario di Madonna dell'Albero
Commemorazione al Sacrario di Madonna dell'Albero Il Sacrario di Madonna dell'Albero
Il Sacrario di Madonna dell'Albero Targa commemorativa per l'eccidio di Don Paolo Turci
Targa commemorativa per l'eccidio di Don Paolo Turci Un mosaico per la pace realizzato dai bambini delle scuole elementari di Ponte Nuovo nel 2002. Particolare
Un mosaico per la pace realizzato dai bambini delle scuole elementari di Ponte Nuovo nel 2002. Particolare Un mosaico per la pace realizzato dai bambini delle scuole elementari di Ponte Nuovo nel 2002
Un mosaico per la pace realizzato dai bambini delle scuole elementari di Ponte Nuovo nel 2002
 Virgilio Lucci
Virgilio Lucci Agapito Latini da giovane
Agapito Latini da giovane Agapito Latini
Agapito Latini Agapito Latini a sinistra con un amico
Agapito Latini a sinistra con un amico Foto del cippo nella posizione originale
Foto del cippo nella posizione originale Foto del cippo dopo la ricollocazione
Foto del cippo dopo la ricollocazione Commemorazione delle vittime con delegazioni da Sassoferrato e Fabriano, all’estrema destra Lucio Lucci, nipote di Virgilio, 26 ottobre 2003
Commemorazione delle vittime con delegazioni da Sassoferrato e Fabriano, all’estrema destra Lucio Lucci, nipote di Virgilio, 26 ottobre 2003 Foto del cippo ad oggi
Foto del cippo ad oggi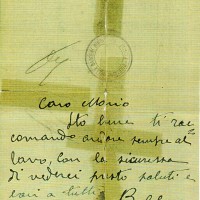 Lettera di Agapito Latini inviata al figlio Mario il 13 giugno 1944 dal carcere di Forlì
Lettera di Agapito Latini inviata al figlio Mario il 13 giugno 1944 dal carcere di Forlì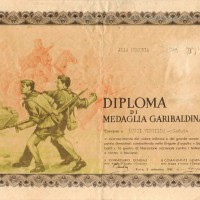 Diploma di medaglia garibaldina di Virgilio Lucci
Diploma di medaglia garibaldina di Virgilio Lucci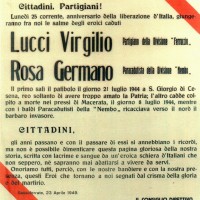 Manifesto ANPI sulla traslazione della salma di Virgilio Lucci, 23 aprile 1949
Manifesto ANPI sulla traslazione della salma di Virgilio Lucci, 23 aprile 1949
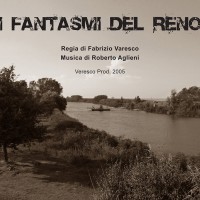 I fantasmi del Reno.
I fantasmi del Reno. Partigiani in azioni lungo gli argini del Reno.
Partigiani in azioni lungo gli argini del Reno. Soldati italiani del Gruppo di Combattimento Cremona appostati presso Sant’Alberto.
Soldati italiani del Gruppo di Combattimento Cremona appostati presso Sant’Alberto. Un partigiano nelle campagne di Sant’Alberto.
Un partigiano nelle campagne di Sant’Alberto. Casa colonica sede del comando partigiano della 28a Brigata Mario Gordini.
Casa colonica sede del comando partigiano della 28a Brigata Mario Gordini. Il Generale Keightley ispeziona un avamposto sul Reno in compagnia del comandante partigiano Arrigo Boldrini, Bulow.
Il Generale Keightley ispeziona un avamposto sul Reno in compagnia del comandante partigiano Arrigo Boldrini, Bulow. Il Generale Keightley ispeziona un avamposto sul Reno in compagnia del comandante partigiano Arrigo Boldrini, Bulow.
Il Generale Keightley ispeziona un avamposto sul Reno in compagnia del comandante partigiano Arrigo Boldrini, Bulow. Partigiani in azioni lungo gli argini del Reno.
Partigiani in azioni lungo gli argini del Reno.
 Ingresso del Giardino pubblico di Cesena prima della demolizione della cancellata nel 1936 (BCM Fondo Casalboni, FCP 64)
Ingresso del Giardino pubblico di Cesena prima della demolizione della cancellata nel 1936 (BCM Fondo Casalboni, FCP 64) Ingresso del Giardino pubblico di Cesena oggi (foto dell'autore)
Ingresso del Giardino pubblico di Cesena oggi (foto dell'autore) Planimetria del rifugio nei sotterranei della scuola, 1944 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28)
Planimetria del rifugio nei sotterranei della scuola, 1944 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28)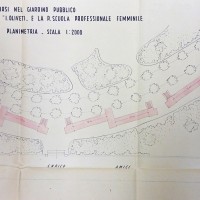 Planimetria dei rifugi tubolari nel giardino, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28)
Planimetria dei rifugi tubolari nel giardino, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28)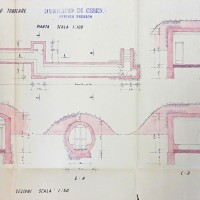 Particolari costruttivi dei rifugi tubolari, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28)
Particolari costruttivi dei rifugi tubolari, 1943 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 28)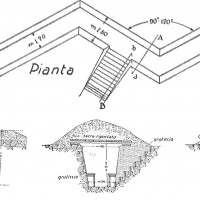 Esempio di trincea (rielaborazione dell’autore di AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 60)
Esempio di trincea (rielaborazione dell’autore di AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 60)
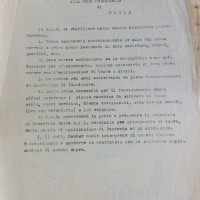 Disposizione del Comando militare germanico di Parma alla segreteria comunale per l'uso dei locali nelle Scuole Pietro Giordani
Disposizione del Comando militare germanico di Parma alla segreteria comunale per l'uso dei locali nelle Scuole Pietro Giordani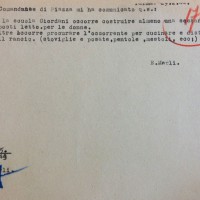 Disposizione del Comando militare germanico di Parma alla segreteria comunale per l'uso dei locali nelle Scuole Pietro Giordani
Disposizione del Comando militare germanico di Parma alla segreteria comunale per l'uso dei locali nelle Scuole Pietro Giordani Disposizione del Comando militare germanico di Parma alla segreteria comunale per l'uso dei locali nelle Scuole Pietro Giordani
Disposizione del Comando militare germanico di Parma alla segreteria comunale per l'uso dei locali nelle Scuole Pietro Giordani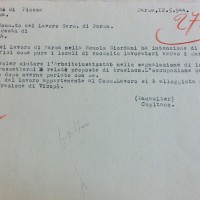 Disposizione del Comando militare germanico di Parma alla segreteria comunale per l'uso dei locali nelle Scuole Pietro Giordani
Disposizione del Comando militare germanico di Parma alla segreteria comunale per l'uso dei locali nelle Scuole Pietro Giordani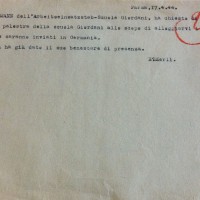 Disposizione del Comando militare germanico di Parma alla segreteria comunale per l'uso dei locali nelle Scuole Pietro Giordani
Disposizione del Comando militare germanico di Parma alla segreteria comunale per l'uso dei locali nelle Scuole Pietro Giordani Le Scuole Pietro Giordani
Le Scuole Pietro Giordani Foto della scuola dopo i bombardamenti del 1944
Foto della scuola dopo i bombardamenti del 1944 Foto della scuola dopo i bombardamenti del 1944
Foto della scuola dopo i bombardamenti del 1944
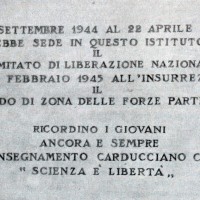 La targa originale che ricorda la sede del Clnp.
La targa originale che ricorda la sede del Clnp. Alessandro Coppi presidente del CLN di Modena.
Alessandro Coppi presidente del CLN di Modena.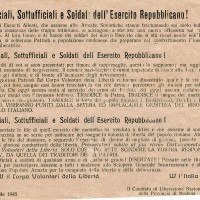 Appello del CLN alla diserzione dall'esercito fascista.
Appello del CLN alla diserzione dall'esercito fascista.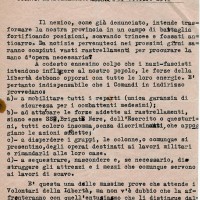 Disposizioni del comando piazza del CLN per l'insurrezione.
Disposizioni del comando piazza del CLN per l'insurrezione. Sfilata della liberazione. Il primo a sinistra è il comandante unico delle forze partigiane modenesi Marco Guidelli Guidi.
Sfilata della liberazione. Il primo a sinistra è il comandante unico delle forze partigiane modenesi Marco Guidelli Guidi.
 Dettaglio del Monumento per i caduti partigiani della Battaglia di Rocchetta, sulla sponda del torrente Scoltenna, Sestola
Dettaglio del Monumento per i caduti partigiani della Battaglia di Rocchetta, sulla sponda del torrente Scoltenna, Sestola Monumento a Rocchetta Sandri, Sestola
Monumento a Rocchetta Sandri, Sestola Monumento per i caduti partigiani della Battaglia di Rocchetta, sulla sponda del torrente Scoltenna, Sestola
Monumento per i caduti partigiani della Battaglia di Rocchetta, sulla sponda del torrente Scoltenna, Sestola Monumento per i caduti partigiani della Battaglia di Rocchetta, sulla sponda del torrente Scoltenna, Sestola
Monumento per i caduti partigiani della Battaglia di Rocchetta, sulla sponda del torrente Scoltenna, Sestola Targa celebrativa della liberazione di Sestola
Targa celebrativa della liberazione di Sestola Targa in memoria di Irma Marchiani in piazza a Sestola
Targa in memoria di Irma Marchiani in piazza a Sestola Targa sul monumento di Rocchetta Sandri, Sestola
Targa sul monumento di Rocchetta Sandri, Sestola
 Palazzo del Ridotto, 1893 (BCM Fondo Casalboni, FCP 53)
Palazzo del Ridotto, 1893 (BCM Fondo Casalboni, FCP 53) Palazzo del Ridotto oggi (foto dell’autore)
Palazzo del Ridotto oggi (foto dell’autore) Torre civica del Palazzo del Ridotto, primi anni 2000 (O. AMADUCCI (a cura di), 1944-1945 Il passaggio del fronte a Cesena, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2007, p. 107)
Torre civica del Palazzo del Ridotto, primi anni 2000 (O. AMADUCCI (a cura di), 1944-1945 Il passaggio del fronte a Cesena, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2007, p. 107) Sirena di allarme sulla torre del Palazzo del Ridotto (BCM Fondo Bacchi, FBP 533)
Sirena di allarme sulla torre del Palazzo del Ridotto (BCM Fondo Bacchi, FBP 533)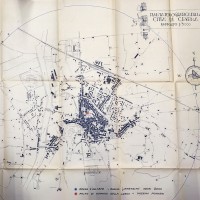 Planimetria con collocazione della sirena del Ridotto (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato
Planimetria con collocazione della sirena del Ridotto (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Planimetria con collocazione degli impianti sussidiari di allarme, 1941 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 6)
Planimetria con collocazione degli impianti sussidiari di allarme, 1941 (AS-FC Fo, C.P.P.A.A. Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea, busta n. 6) Planimetria con collocazione delle torri civiche e dei campanili di Cesena (ASFC Fo, C.P.P.A.A., n. generale 51)
Planimetria con collocazione delle torri civiche e dei campanili di Cesena (ASFC Fo, C.P.P.A.A., n. generale 51) Via Carbonari dopo la ritirata dei tedeschi, Palazzo del Ridotto a destra, ottobre 1944 (BCM Dellamore, FDP 1207)
Via Carbonari dopo la ritirata dei tedeschi, Palazzo del Ridotto a destra, ottobre 1944 (BCM Dellamore, FDP 1207)
 Anniversario della fucilazione di cinque partigiani in viale Verdi, notte 17-18 marzo 1945.
Anniversario della fucilazione di cinque partigiani in viale Verdi, notte 17-18 marzo 1945. Partigiani della 38a Brigata Garibaldi “A.Villa” che operava in Val D’Arda, provincia di Piacenza, nella quale combatterono numerosi giovani di Soragna (Antonio Mareghi “Nino” primo in piedi a sinistra).
Partigiani della 38a Brigata Garibaldi “A.Villa” che operava in Val D’Arda, provincia di Piacenza, nella quale combatterono numerosi giovani di Soragna (Antonio Mareghi “Nino” primo in piedi a sinistra). Partigiani del distaccamento “Giovane Italia”, 38a Brigata Garibaldi “A. Villa”, a Lugnano (Piacenza) alla vigilia della liberazione. Adolfo Breviglieri “Dolfo” (terzo in piedi da sinistra), Angelo Allegri “Sisén” e Anacleto Parizzi “Cleto” (ultimi due in piedi abbracciati), Primo Manfredini “Primòn” (ultimo in piedi dietro), tutti di Soragna.
Partigiani del distaccamento “Giovane Italia”, 38a Brigata Garibaldi “A. Villa”, a Lugnano (Piacenza) alla vigilia della liberazione. Adolfo Breviglieri “Dolfo” (terzo in piedi da sinistra), Angelo Allegri “Sisén” e Anacleto Parizzi “Cleto” (ultimi due in piedi abbracciati), Primo Manfredini “Primòn” (ultimo in piedi dietro), tutti di Soragna.
 1928 Celebrazione Madonna del Fuoco di Forlì, Patrona di di Forlì
1928 Celebrazione Madonna del Fuoco di Forlì, Patrona di di Forlì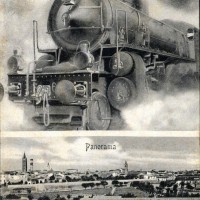 Cartolina
Cartolina Fontana piazza stazione ferroviaria e viale della Libertà
Fontana piazza stazione ferroviaria e viale della Libertà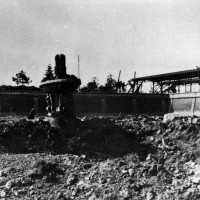 La stazione bombardata
La stazione bombardata La stazione bombardata
La stazione bombardata Panorama di Forlì dalla stazione ferroviaria
Panorama di Forlì dalla stazione ferroviaria Stazione ferroviaria
Stazione ferroviaria Stazione ferroviaria
Stazione ferroviaria Stazione ferroviaria
Stazione ferroviaria Stazione ferroviaria
Stazione ferroviaria
 La stazione ferroviaria dopo un bombardamento
La stazione ferroviaria dopo un bombardamento Deposito vagoni (1944)
Deposito vagoni (1944) Stazione ferroviaria
Stazione ferroviaria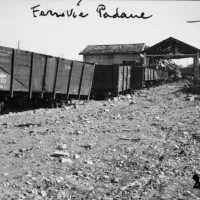 Deposito vagoni (1944)
Deposito vagoni (1944) Deposito vagoni (1944)
Deposito vagoni (1944) Esterno della Stazione ferroviaria (1944)
Esterno della Stazione ferroviaria (1944) Piazzale della Stazione ferroviaria
Piazzale della Stazione ferroviaria Stazione ferroviaria
Stazione ferroviaria OGR - Officina grandi riparazioni
OGR - Officina grandi riparazioni OGR - Officina grandi riparazioni
OGR - Officina grandi riparazioni OGR - Officina grandi riparazioni
OGR - Officina grandi riparazioni
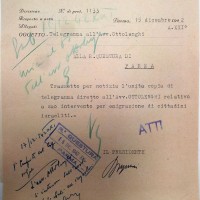 Documento della Commissione per la censura che segnala l’opera di Ottolenghi per consentire l’emigrazione di cittadini ebrei. Archivio di Stato di Parma
Documento della Commissione per la censura che segnala l’opera di Ottolenghi per consentire l’emigrazione di cittadini ebrei. Archivio di Stato di Parma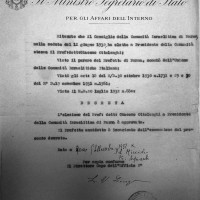 Approvazione del Ministero dell’Interno dell’elezione di Ottolenghi a Presidente della Comunità israelitica di Parma, settembre 1932. Archivio di Stato di Parma
Approvazione del Ministero dell’Interno dell’elezione di Ottolenghi a Presidente della Comunità israelitica di Parma, settembre 1932. Archivio di Stato di Parma
 Aristide Rossi
Aristide Rossi Partigiani della brigata “Parma Vecchia”, aprile 1945
Partigiani della brigata “Parma Vecchia”, aprile 1945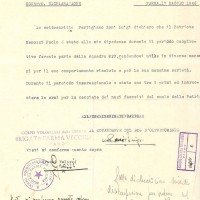 Dichiarazione del Comando Brigata “Parma Vecchia”, 17 maggio 1946
Dichiarazione del Comando Brigata “Parma Vecchia”, 17 maggio 1946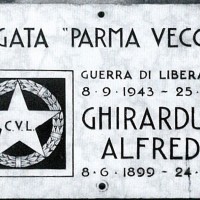 Lapide posta in via D’Azeglio in ricordo di Alfredo Ghirarduzzi, caduto il 24 aprile 1945
Lapide posta in via D’Azeglio in ricordo di Alfredo Ghirarduzzi, caduto il 24 aprile 1945 Lapide posta in via Benassi in ricordo di Aristide Rossi, caduto il 25 aprile 1945
Lapide posta in via Benassi in ricordo di Aristide Rossi, caduto il 25 aprile 1945 Lapide posta in via Rismondo in ricordo di Walter Saccani, caduto il 25 aprile 1945
Lapide posta in via Rismondo in ricordo di Walter Saccani, caduto il 25 aprile 1945
 La casa dell'eccidio negli anni Cinquanta.
La casa dell'eccidio negli anni Cinquanta. Il borgo.
Il borgo. La casa dell'eccidio oggi.
La casa dell'eccidio oggi. L'albero e la casa oggi.
L'albero e la casa oggi. Concerto di studenti durante la Scuola di Pace.
Concerto di studenti durante la Scuola di Pace. Studenti che percorrono il Sentiero della memoria.
Studenti che percorrono il Sentiero della memoria. La pluriclasse di Tavolicci fotografata nel giugno 1944. Un mese dopo la maggior parte dei bambini ritratti nella foto perse la vita nella strage.
La pluriclasse di Tavolicci fotografata nel giugno 1944. Un mese dopo la maggior parte dei bambini ritratti nella foto perse la vita nella strage.
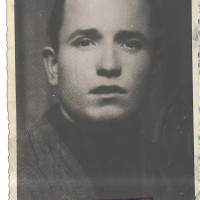 Lidio Ubaldi
Lidio Ubaldi cippo commemorativo posto all’ingresso di Trefiumi
cippo commemorativo posto all’ingresso di Trefiumi il racconto di quei giorni nelle parole di alcuni abitanti di Trefiumi in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)
il racconto di quei giorni nelle parole di alcuni abitanti di Trefiumi in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)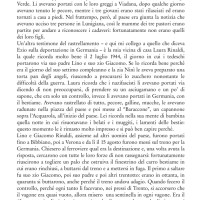 il racconto di quei giorni nelle parole di alcuni abitanti di Trefiumi in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)
il racconto di quei giorni nelle parole di alcuni abitanti di Trefiumi in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/) il racconto di quei giorni nelle parole di alcuni abitanti di Trefiumi in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)
il racconto di quei giorni nelle parole di alcuni abitanti di Trefiumi in “Mappe di comunità” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/)
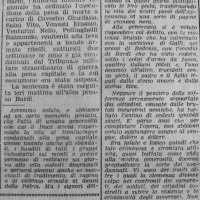 “Gazzetta di Parma”, 5 maggio 1944
“Gazzetta di Parma”, 5 maggio 1944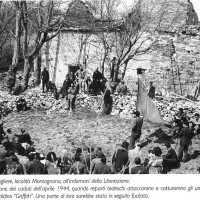 Aprile 1946: Manifestazione per ricordare il secondo anniversario della cattura dei partigiani del distaccamento “Griffith”
Aprile 1946: Manifestazione per ricordare il secondo anniversario della cattura dei partigiani del distaccamento “Griffith”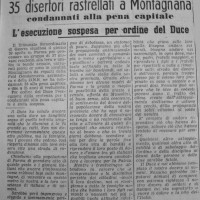 “Gazzetta di Parma”, 22 aprile 1944
“Gazzetta di Parma”, 22 aprile 1944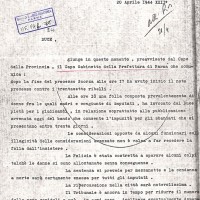 Relazione del Ministro per l’Interno al Duce sulla protesta davanti al Tribunale, 20 aprile 1944
Relazione del Ministro per l’Interno al Duce sulla protesta davanti al Tribunale, 20 aprile 1944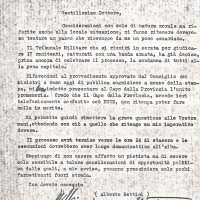 Lettera del questore di Parma sul processo ai partigiani catturati sul Montagnana, 20 aprile 1944
Lettera del questore di Parma sul processo ai partigiani catturati sul Montagnana, 20 aprile 1944 Partigiani del distaccamento “E. Griffith” catturati sul monte Montagnana, in detenzione alla Certosa di Parma
Partigiani del distaccamento “E. Griffith” catturati sul monte Montagnana, in detenzione alla Certosa di Parma
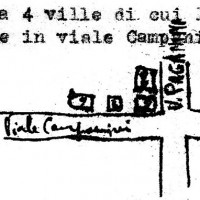 Mappa degli edifici occupati dall'Aussenkommando della Polizia di sicurezza-SD all'angolo tra Viale Campanini e Via Paganini, disegnata da un informatore del servizio informazioni partigiano nell'aprile 1945
Mappa degli edifici occupati dall'Aussenkommando della Polizia di sicurezza-SD all'angolo tra Viale Campanini e Via Paganini, disegnata da un informatore del servizio informazioni partigiano nell'aprile 1945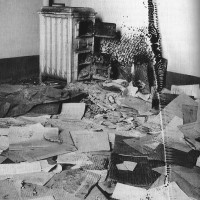 Documenti bruciati nella sede della SD
Documenti bruciati nella sede della SD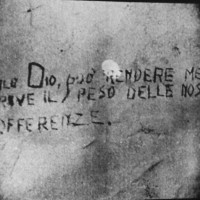 Graffiti dei prigionieri nelle celle della Polizia di sicurezza-SD in Viale Campanini, Parma 1945
Graffiti dei prigionieri nelle celle della Polizia di sicurezza-SD in Viale Campanini, Parma 1945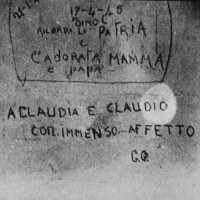 Graffiti dei prigionieri nelle celle della Polizia di sicurezza-SD in Viale Campanini, Parma 1945
Graffiti dei prigionieri nelle celle della Polizia di sicurezza-SD in Viale Campanini, Parma 1945
 cippo
cippo Achille Miodini
Achille Miodini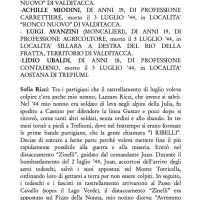 la testimonianza della nipote di Lazzaro Ricci del distaccamento Zinelli in “Ribelli della montagna” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).
la testimonianza della nipote di Lazzaro Ricci del distaccamento Zinelli in “Ribelli della montagna” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/). la testimonianza della nipote di Lazzaro Ricci del distaccamento Zinelli in “Ribelli della montagna” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).
la testimonianza della nipote di Lazzaro Ricci del distaccamento Zinelli in “Ribelli della montagna” (https://www.mabappennino.it/il-progetto-mappe-di-comunita/).
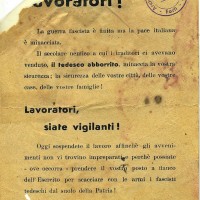 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti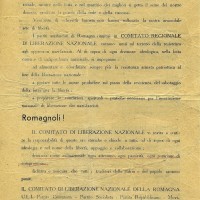 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti Monumento 11 Fanteria Casale
Monumento 11 Fanteria Casale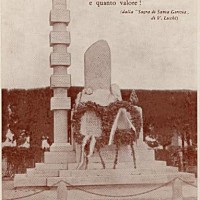 Monumento 11 Fanteria Casale
Monumento 11 Fanteria Casale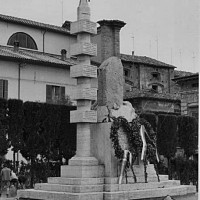 Monumento 11 Fanteria Casale
Monumento 11 Fanteria Casale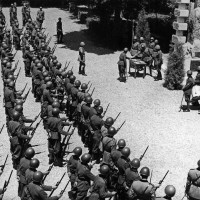 Monumento 11 Fanteria Casale
Monumento 11 Fanteria Casale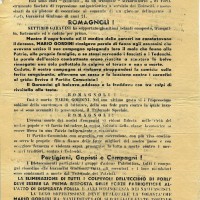 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti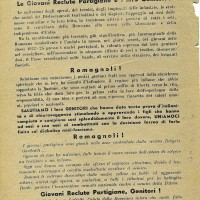 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti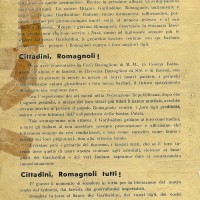 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti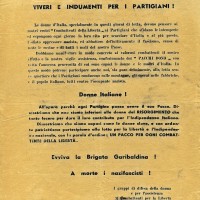 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti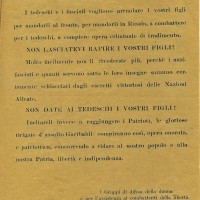 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti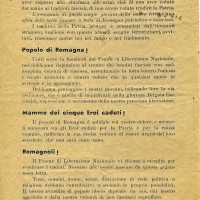 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti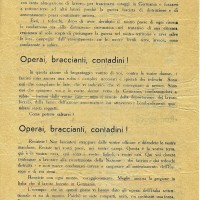 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti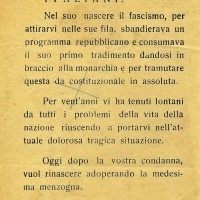 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti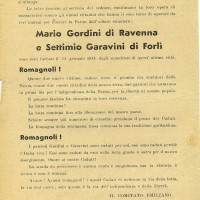 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti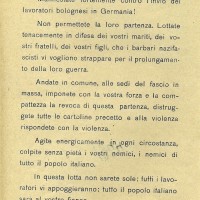 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti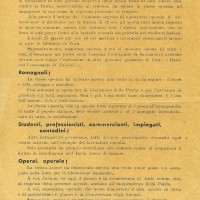 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti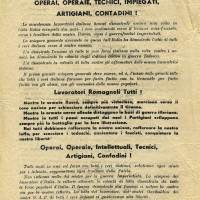 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti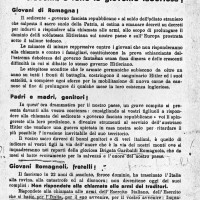 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti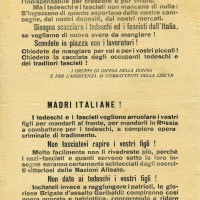 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti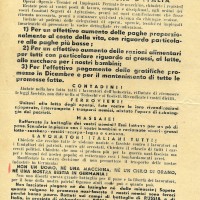 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti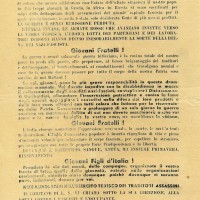 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti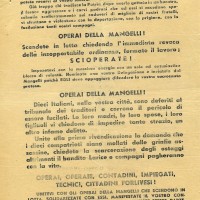 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti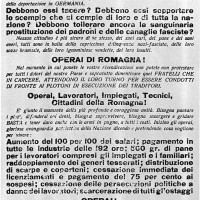 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti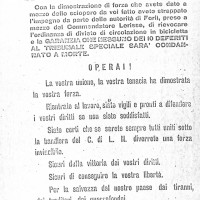 1943, volantini antifascisti
1943, volantini antifascisti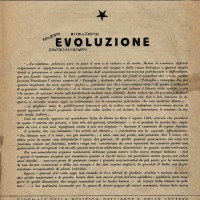 Stampa clandestina, Italia giovane
Stampa clandestina, Italia giovane
 1933: Inaugurazione della “Littorina” che prendeva il nome del fascio Littorio sulla locomotiva
1933: Inaugurazione della “Littorina” che prendeva il nome del fascio Littorio sulla locomotiva Avviso su “La Scure” del 20 febbraio 1944 contro i renitenti e i disertori
Avviso su “La Scure” del 20 febbraio 1944 contro i renitenti e i disertori Gruppo di partigiani. Sono riconoscibili le divise militari che ne denunciano la fuga dai doveri imposti dalla Repubblica Socale Italiana
Gruppo di partigiani. Sono riconoscibili le divise militari che ne denunciano la fuga dai doveri imposti dalla Repubblica Socale Italiana
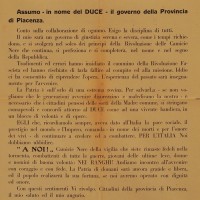 Volantino della Prefettura repubblicana di Piacenza
Volantino della Prefettura repubblicana di Piacenza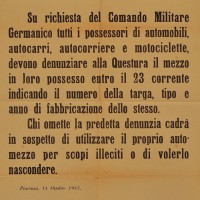 Volantino della Prefettura repubblicana di Piacenza che dirama un ordine dei tedeschi
Volantino della Prefettura repubblicana di Piacenza che dirama un ordine dei tedeschi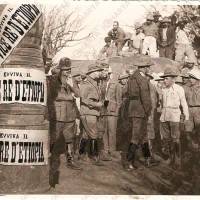 Il Prefetto di Piacenza Davide Fossa in una foto del 1937 in Etiopia con Rodolfo Graziani
Il Prefetto di Piacenza Davide Fossa in una foto del 1937 in Etiopia con Rodolfo Graziani Il Prefetto di Piacenza Alberto Graziani, giustiziato dai partigiani il 1° maggio 1945
Il Prefetto di Piacenza Alberto Graziani, giustiziato dai partigiani il 1° maggio 1945
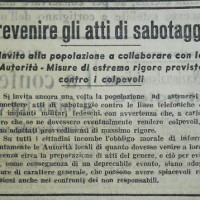 Avviso contro gli atti di sabotaggio (La Scure, 6 giugno 1944)
Avviso contro gli atti di sabotaggio (La Scure, 6 giugno 1944)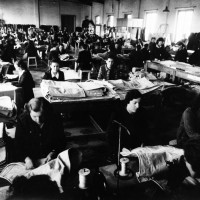 Maestranze al lavoro presso la Direzione d'Artiglieria negli anni '40
Maestranze al lavoro presso la Direzione d'Artiglieria negli anni '40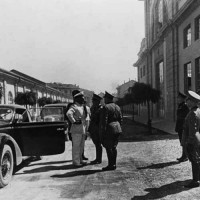 Mussolini in visita all'Arsenale militare di Piacenza l'8 ottobre del 1940
Mussolini in visita all'Arsenale militare di Piacenza l'8 ottobre del 1940 Legionari della sezione Ordine Pubblico della GNR in posa davanti al “tullon dla vardüra” in viale Beverora a Piacenza
Legionari della sezione Ordine Pubblico della GNR in posa davanti al “tullon dla vardüra” in viale Beverora a Piacenza
 il viale B. Mussolini visto dalla stazione
il viale B. Mussolini visto dalla stazione Il Viale visto dalla stazione ferroviaria
Il Viale visto dalla stazione ferroviaria Lapide Viale della Libertà
Lapide Viale della Libertà Lavori in Viale della Libertà, 1947
Lavori in Viale della Libertà, 1947 Panorama dall'alto
Panorama dall'alto Viale della Libertà
Viale della Libertà Viale della Libertà, foto aerea
Viale della Libertà, foto aerea Viale della Libertà nei primi anni Trenta
Viale della Libertà nei primi anni Trenta Viale della Libertà vista da Piazza della Vittoria
Viale della Libertà vista da Piazza della Vittoria Viale della Libertà visto dai giardini della Resistenza
Viale della Libertà visto dai giardini della Resistenza
 Prima pagina del periodico clandestino “Il Martello”, organo della Federazione comunista di Piacenza, anno I, n. 9, 18 ottobre 1944
Prima pagina del periodico clandestino “Il Martello”, organo della Federazione comunista di Piacenza, anno I, n. 9, 18 ottobre 1944 Mussolini in visita all'Arsenale militare di Piacenza (anni '40)
Mussolini in visita all'Arsenale militare di Piacenza (anni '40) Stazione della “Littorina”: un binario congiungeva direttamente l'Arsenale militare
Stazione della “Littorina”: un binario congiungeva direttamente l'Arsenale militare Carta delle aree militari di Piacenza
Carta delle aree militari di Piacenza
 Enrico Richetti, deportato ad Auschwitz perché ebreo e morta a Dachau a 34 anni
Enrico Richetti, deportato ad Auschwitz perché ebreo e morta a Dachau a 34 anni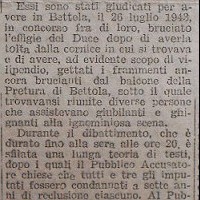 Trafiletto su La Scure che annuncia la condanna a cinque anni inflitta dal Tribunale speciale a Francesco Daveri (5 marzo 1944)
Trafiletto su La Scure che annuncia la condanna a cinque anni inflitta dal Tribunale speciale a Francesco Daveri (5 marzo 1944) Interno delle carceri di Piacenza di Palazzo Madama
Interno delle carceri di Piacenza di Palazzo Madama Tina Pesaro, deportata ad Auschwitz perché ebrea e morta a Dachau a 31 anni
Tina Pesaro, deportata ad Auschwitz perché ebrea e morta a Dachau a 31 anni
 Vicolo Squallore.
Vicolo Squallore. La famiglia Donati - una delle più influenti della comunità modenese - nel 1907.
La famiglia Donati - una delle più influenti della comunità modenese - nel 1907. Lavori di sventramento per creare la piazza nella zona del ghetto.
Lavori di sventramento per creare la piazza nella zona del ghetto. Tomba monumento di Duilio Sinigaglia, fascista ebreo ucciso nel 1921 dalla Guardia regia.
Tomba monumento di Duilio Sinigaglia, fascista ebreo ucciso nel 1921 dalla Guardia regia. Una delle vie del ghetto prima dell'abbattimento per realizzare Piazza Mazzini.
Una delle vie del ghetto prima dell'abbattimento per realizzare Piazza Mazzini.
 Ritratto di Vincenzo Folegatti
Ritratto di Vincenzo Folegatti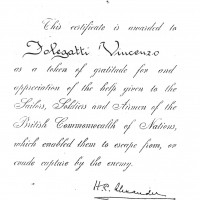 Attestato di riconoscimento alleato, firmato dal generale Alexander, Comandante supremo delle forze alleate del Mediterraneo
Attestato di riconoscimento alleato, firmato dal generale Alexander, Comandante supremo delle forze alleate del Mediterraneo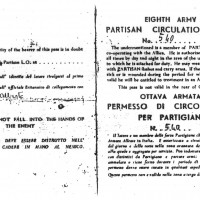 Lasciapassare alleato al partigiano Vincenzo Folegatti
Lasciapassare alleato al partigiano Vincenzo Folegatti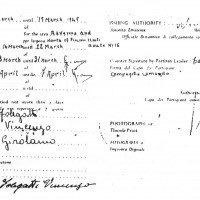 Lasciapassare alleato al partigiano Vincenzo Folegatti
Lasciapassare alleato al partigiano Vincenzo Folegatti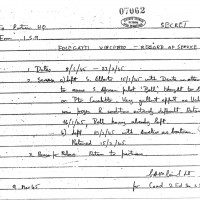 Record of Service Folegatti Vincenzo, 9 Marzo 1945
Record of Service Folegatti Vincenzo, 9 Marzo 1945